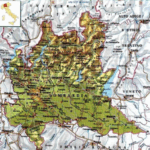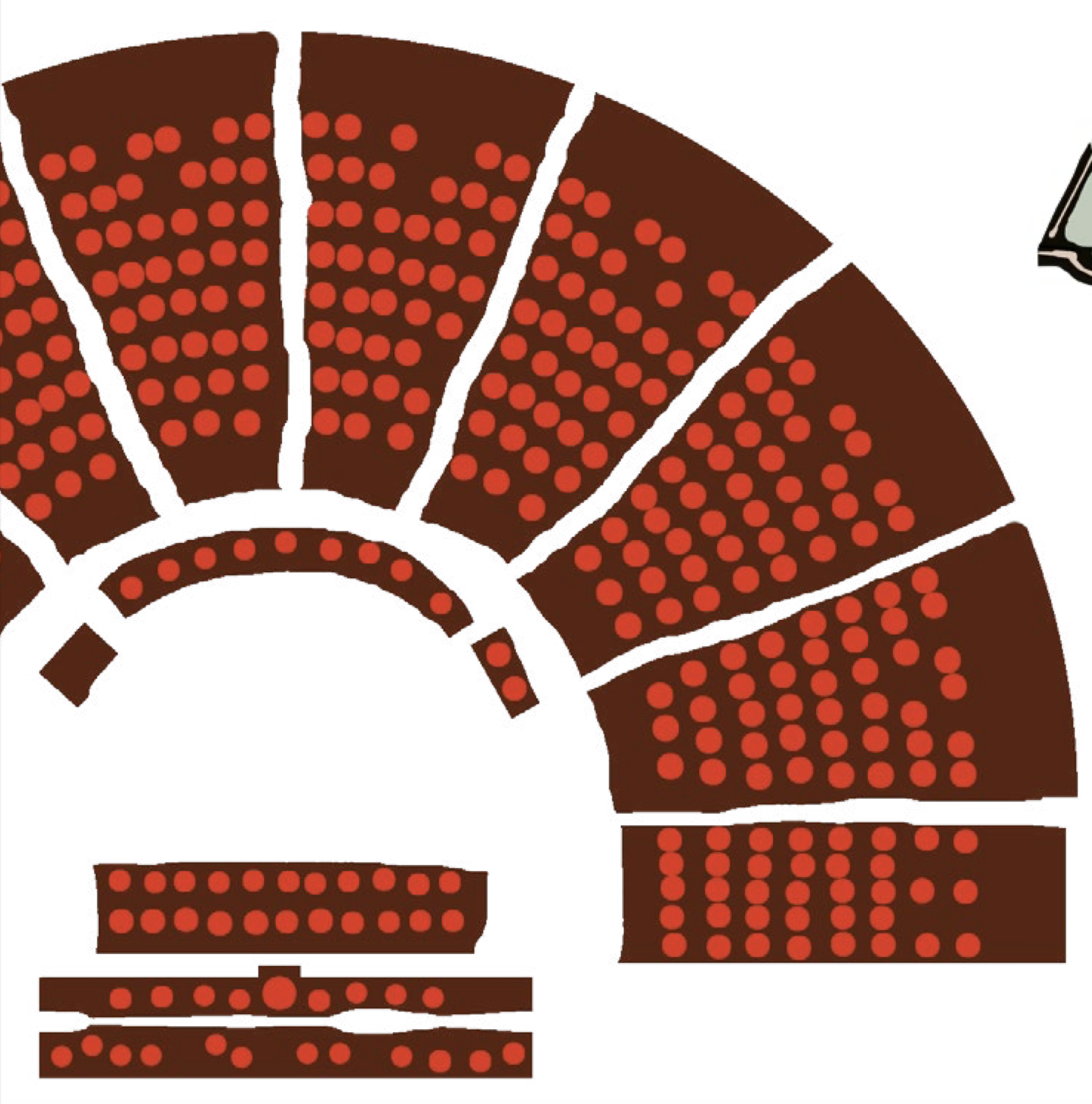Di seguito riportiamo l’intervento di Gustavo Zagrebelsky durante l’audizione in commissione Affari costituzionali al Senato in merito al ddl sul premierato. Questo testo è stato pubblicato su La Repubblica del 30 novembre 2023.
Gustavo Zagrebelsky è costituzionalista, Presidente della Corte Costituzionale nel 2004 e Presidente onorario di Libertà e Giustizia.
✒︎✒︎✒︎
È iniziato in Parlamento l’iter di quella che il governo ha definito “la madre di tutte le riforme”. Chiamato in audizione martedì, davanti alla commissione affari costituzionali del Senato, ho sollevato alcuni rilievi sui punti salienti del disegno di legge.
Legge elettorale (art. 3)
Proposta. Non è indicata quale debba essere la formula elettorale. Si dice solo che la legge relativa dovrà ispirarsi ai principi di rappresentatività e governabilità (su questa ultima parola, desidererei spendere qualche considerazione se ce ne fosse la possibilità) e dovrà garantire un premio di maggioranza, nella misura del 55 per cento dei seggi in ciascuna Camera alle liste e ai candidati collegati al presidente del Consiglio – sottinteso: che abbiano ottenuto più voti degli altri.
Commento. La proposta non dice altro e il silenzio suscita le due seguenti considerazioni. Innanzitutto, non è stabilita nessuna condizione all’operatività del premio di maggioranza. Ora, l’elezione del presidente porta con sé, in un unico schieramento, l’elezione dei deputati e dei senatori onde, se i candidati alla presidenza che si affrontano sono solo due, è chiaro che gli eletti risulteranno da un voto maggioritario e non sarà necessario stabilire alcuna soglia minima di consensi elettorali per godere del premio. Essi raggiungeranno naturalmente la maggioranza dei voti validi. Ma, se il sistema elettorale per il presidente consentirà il confronto tra più d’un candidato (cosa tutt’altro che impensabile in una situazione partitica come l’attuale in cui i vari partiti, pur di analogo orientamento, potrebbero presentare i propri candidati nella speranza e nella prospettiva di prevalere sui propri concorrenti ed eleggere il proprio candidato alla presidenza e i propri candidati alle Camere, pur appartenendo tutti alla medesima area politica), il premio potrebbe essere conquistato anche da una maggioranza solo relativa molto bassa. Il silenzio su questo aspetto del sistema elettorale potrebbe aprire uno scenario in radicale contrasto con le esigenze di minima, necessaria, rappresentatività. Esigenze che, in conformità con l’insegnamento della Corte costituzionale, configurerebbe la violazione di un “principio supremo” della Costituzione democratica: in breve, una riforma costituzionale incostituzionale. Si dirà, forse: questo problema potrà essere affrontato dalla legge elettorale necessaria in seguito alla modifica della Costituzione e, in quella sede si potrà provvedere a stabilire la necessaria soglia minima. Non è così poiché secondo la nuova norma costituzionale il premio di maggioranza dovrà essere “garantito”, mentre la condizione della soglia da superare, comunque determinata, trasformerebbe la garanzia in una mera eventualità. Sarebbe, insomma, incostituzionale alla stregua della nuova norma costituzionale che si vorrebbe approvare. Un nodo che potrebbe essere sciolto solo da un’indicazione costituzionale che imponga una forma di bipolarismo.
C’è poi un’altra questione derivante da un silenzio forse ancor più gravido di pericoli. La maggioranza assoluta garantita alle Camere le consentirebbe di operare da sola per eleggere un (proprio) presidente della Repubblica (dopo il terzo scrutinio), ciò che rende insignificanti le tante parole spese sul suo ruolo di garanzia super partes e sul suo mantenimento. Cosa analoga può ripetersi per l’elezione da parte del Parlamento dei cinque giudici costituzionali e dei dieci componenti del Consiglio superiore della magistratura: la maggioranza gratificata dal premio potrebbe facilmente fare integralmente sue quelle scelte. Quanto alla Corte costituzionale, se si sommano ai cinque giudici di elezione parlamentare i cinque di nomina presidenziale, una volta che la maggioranza disponesse del proprio presidente, la conseguenza sarebbe una Corte a immagine e somiglianza della maggioranza politica. A considerare, poi, la possibilità di occupazione di altre istituzioni che si vorrebbero neutrali, come le Autorità indipendenti, e lo snaturamento o lo svilimento delle varie procedure parlamentari previste a garanzia delle minoranze, prima fra tutte quella per la revisione della Costituzione, l’immagine che ne risulta è ciò che, negli anni trenta si chiamava “allineamento” o “ugualizzazione” (Gleichschaltung). Altro che piccola riforma, piccoli ritocchi: è uno stravolgimento senza cautele, ponderazioni e contrappesi. Anche coloro che hanno guardato con una certa simpatia all’ipotesi dell’elezione diretta del presidente del Consiglio hanno avvertito della necessità di accompagnarla, o farla precedere, da un rafforzamento delle garanzie. Nulla di ciò; anzi l’opposto.
Rapporti Parlamento-Governo (art. 4)
Proposta. Si prevede, innanzitutto, che il Governo debba avere la fiducia delle Camere e si disciplinano due ipotesi di sfiducia, l’una iniziale, l’altra in corso d’opera. Nella prima ipotesi, al presidente del Consiglio sfiduciato fin dall’inizio il presidente della Repubblica rinnova (deve rinnovare?) l’incarico di formare il governo. Se anche questo secondo tentativo va a vuoto, si sciolgono le Camere. Nella seconda ipotesi, quando cioè il presidente del Consiglio “cessi dalla carica”, si aprono due possibilità. Per la prima, il presidente della Repubblica può conferire di nuovo al dimissionario l’incarico di formare un nuovo governo; per la seconda, l’incarico può essere conferito a un parlamentare che sia stato eletto in collegamento col presidente del Consiglio precedente. In tal caso, l’incarico non è conferito senza mandato, ma con il compito di “attuare le dichiarazioni relative all’indirizzo politico e agli impegni programmatici su cui il presidente del Consiglio precedente aveva ottenuto la fiducia.
Commento. La proposta mantiene fermo un istituto tipico del regime parlamentare: il rapporto di fiducia e la correlativa possibilità che venga a mancare. Le conseguenze, nella teoria e nella pratica possono essere o le dimissioni del governo e la sua sostituzione con uno nuovo, oppure la “dismissione”, cioè lo scioglimento, del Parlamento e le nuove elezioni. Il presupposto è l’alterità: la fiducia (e la sfiducia) possono esistere solo tra soggetti politicamente distinti. Non è il nostro caso: il presidente del Consiglio e il Parlamento, cioè la maggioranza parlamentare, sono politicamente la stessa cosa: nascono insieme con un sistema che assicura la perfetta omogeneità dell’uno con l’altro. Onde, si potrebbe immaginare che la crisi politica del primo corrisponda all’identica crisi della seconda. Nascono insieme come due gemelli ciascuno dei quali ha bisogno dell’altro. Simul stabunt, simul cadent. Questa ovvia sincronia, ancorché sia stata discussa e sostenuta, non è accolta nella proposta che, invece, prevede “secondi tempi”. Le Camere sono (o possono essere) chiamate a rivedere la propria posizione, dando o confermando la fiducia che, appena pochi giorni prima, era stata negata: in altre parole, a pentirsi come si chiede ai discoli di fare. Il senso di questo mea culpa sembra essere solo questo: costringere il presidente eletto a intavolare trattative con i partiti della maggioranza per nuovi equilibri e diverse distribuzioni o spartizioni di potere. Ma il maggior pregio dell’elezione diretta del presidente del Consiglio non doveva essere precisamente quello di evitare tutto ciò, mettendo nelle mani degli elettori il potere di scegliere, con il programma, la sua incarnazione senza “lacci e i laccioli”?
Il “secondo tempo” sembra una norma fatta apposta per assicurare a partiti della maggioranza la possibilità di logorare il presidente con la minaccia dello scioglimento e delle nuove elezioni che sono sullo sfondo. Ma è previsto anche un secondo tempo, non più con il presidente del Consiglio eletto, ma con un parlamentare della maggioranza scelto al suo posto. Anche questa “trovata” sembra giustificarsi con la medesima ragione or ora detta, dare alla possibilità a un concorrente (o a più d’uno) d’insidiare il presidente eletto. Ma ciò è in puntuale contrasto con la ratio dell’intera riforma: garantire omogeneità e stabilità, e permettere ai cittadini, nelle urne, di fare loro stessi la scelta di colui (o colei) dal quale vogliono essere governati. Il dover, costui, essere tratto dalle file della maggioranza, contro le apparenze non la rafforzerebbe affatto ma, al contrario, la minerebbe dall’interno, con buona pace del proposito di impedire i giochi di palazzo. In più, il nuovo presedente del Consiglio che fosse riuscito nel suo proposito a scalzare il vecchio non potrebbe dirsi presidente “eletto dal popolo”. Sarebbe un deputato o un senatore, eletti, sì, ma per una carica diversa. È una differenza qualitativa: chi si candida a presidente del Consiglio, per quanto sia indicato da un partito, aspira a essere ben più che uomo o donna di partito, a differenza di chi si candida a un posto in Parlamento.
Il fatto poi che il successore debba impegnarsi a rispettare il programma del predecessore, a parte la scarsa costrittività di un simile impegno (“Parigi val bene una messa”) è la confessione esplicita che l’inedita e molto creativa trovata (cosiddetta anti-ribaltone) ha poco di confronto o lotta politica (la politica dovrebbe restare la stessa) e molto di litigiosità essenzialmente personalistica. Inoltre, tale impegno dovrebbe estendersi anche al partito o ai partiti che formano la maggioranza, quella di prima e la stessa di dopo, ed allora ci si potrebbe chiedere se ciò non confligge con il “senza vincolo di mandato” dell’articolo 67 della Costituzione che costituisce l’essenza della posizione del parlamentare nelle costituzioni liberali. E, infine, l’impegno al rispetto della formula politica anteriore costituirebbe non solo l’antidoto contro i “ribaltoni”, ma anche alla formazione di più larghe maggioranze nel segno dei governi di “unità nazionale” necessari per far fronte ai momenti di crisi acute.
Senatori a vita (art. 1 e 5)
Proposta. La soppressione dei senatori a vita. L’art. 2 abroga l’art. 59, secondo comma, della Costituzione vigente, cioè elimina i senatori a vita la cui nomina, fino a ora, rientrava nelle prerogative del presidente della Repubblica. La Relazione ne spiega la ratio: l’estensione della legittimazione democratica a tutti gli istituti della “forma di governo” ed evitare che tale presenza di “nominati” e non “eletti” incida sulla dinamica maggioranza-opposizione, tanto più dopo la riduzione numerica dei membri del Senato. Alla soppressione della “figura” dei senatori a vita, si accompagna la norma transitoria (art. 5) per la quale i già nominati “restano in carica”.
Commento. Gli articoli citati sono espressione del principio di elettività inteso nella sua portata radicale e sembrano esprimere una certa allergia nei confronti del “merito”. Una volta si diceva: “avere ben meritato della Patria”. Si può condividere e non condividere, ed è una scelta. Ma la motivazione che chiama in ballo il sovrappeso dei senatori a vita nel Senato numericamente dimezzato è pretestuosa: la maggioranza disporrà per legge (elettorale) della maggioranza assoluta degli eletti e non avrà nulla da temere dai pochi non eletti. Inoltre, per evitare il rischio di alterazioni delle maggioranze elette, basterebbe stabilire che i senatori a vita non partecipano alle votazioni di natura politica, dalle quali dipende la vita delle maggioranze e dei governi, cioè le votazioni sulla fiducia.
Ciò sarebbe conforme alla natura super partes di questa carica che guarda a interessi permanenti della Patria, al di là delle dinamiche politico-partitiche. In più avrebbe il pregio di non infilarsi nell’abborracciata norma transitoria. Il riformatore costituzionale vuole l’eliminazione della figura; i senatori a vita non hanno ragione di esistere; dunque, via per il futuro. Ma, nel presente, occorre tenere conto che ce ne sono cinque. Che se ne fa? Li si lascia dove sono sino a quando non provvederanno loro stessi ad andarsene. Li si chiamerebbe ancora senatori “ad vitam”? Questa definizione indica che si augura loro “lunga vita” tra noi, perché apprezziamo i loro meriti. Ma, quando si afferma che non c’è bisogno, che non li vogliamo tra noi e che, se si potesse, se ne farebbe volentieri a meno perché superflui, inutili se non anche fastidiosi e dannosi per la democrazia, allora li si trasforma in “senatori ad mortem”. Ospiti non graditi, per il minor tempo possibile. È facile immaginare che, per protesta e per difesa della propria dignità, non accetterebbero di rimanere in carica con un tale pregiudizio gravante su di sé e rimetterebbero il mandato di propria iniziativa, dimettendosi. Ma sarebbe uno scontro tra “altissimi meriti” e “raffazzonamento politico”.
Elezione diretta (art. 3)
Proposta. Il cuore della proposta di riforma costituzionale è certamente l’elezione popolare diretta del capo dell’Esecutivo. È indicata come il rimedio ai difetti della forma di governo parlamentare delineata dalla Costituzione: instabilità dei governi, eterogeneità e volatilità delle maggioranze e “transfughismo” parlamentare, come è detto nella Relazione. La chiave per entrare in un’era di stabilità, omogeneità, solidità e fedeltà è, dunque, l’elezione diretta del presidente del Consiglio “per la durata di cinque anni”, contestualmente all’elezione dei membri del Parlamento (“con unica scheda”, si diceva ambiguamente in una versione precedente). Non solo: si tratterebbe di “consolidare il principio democratico, valorizzando il ruolo del corpo elettorale nella determinazione dell’indirizzo politico della Nazione”, dando così “appoggio e continuità al mandato democratico”. Stabilità, coesione della compagine di governo, garanzie del continuum che lega maggioranza parlamentare ed Esecutivo, indirizzi politici di medio e lungo periodo, riforme organiche, futuro della Nazione, rimedio all’astensionismo, responsabilizzazione della “classe dirigente” nel momento elettorale. Ecco i doni della riforma, una riforma che la Relazione definisce “ormai ampiamente nota e sostanzialmente condivisa a livello istituzionale, scientifico e di opinione pubblica”.
Commento. Dopo le osservazioni precedenti su aspetti particolari, è necessario ora chiarire che non di riforma si tratta, ma di rifacimento dalle fondamenta del sistema di governo. C’è una contraddizione nel sostenere che si tratta solo di interventi “minimali nella convinzione che si debba operare, per quanto possibile, in continuità con la nostra tradizione costituzionale e parlamentare e che pertanto gli interventi di revisione debbano limitarsi a quelli strettamente necessari”: c’è contraddizione tra queste espressioni della Relazione non solo con la propaganda del tipo “inauguriamo così la quarta Repubblica” o “ questa è la madre di tutte le riforme”, ma anche e soprattutto con il contenuto della proposta. È bensì vero che si toccano poche norme (il che, in assenza – come s’è detto, dei necessari pesi e contrappesi, non è affatto segno di moderazione, ma di smodatezza), ma con un piccolo gesto normativo si rovescia addirittura l’impianto costituzionale e la base della democrazia ch’essa delinea.