In Italia, come in parecchi altri ordinamenti europei, manca una qualsivoglia “istituzionalizzazione” (rectius: costituzionalizzazione) delle opposizioni: difatti, bisognerebbe poter distinguere tra la funzione di governo, che spetta alla maggioranza, e quella di garanzia, che compete invece alle opposizioni, assicurando di tal fatta la tenuta ed il funzionamento di un sistema dialettico ed equilibrato.
Gli articoli 72 e 94 della Costituzione, infatti, pur configurando un autonomo rilievo costituzionale di quote frazionarie di parlamentari legittimate a mettere in moto processi di rilievo costituzionale (ossia i diritti attribuiti ad una frazione di parlamentari) non stabiliscono un vero e proprio “statuto” dell’opposizione (intesa questa volta tout court), poiché i poteri in essi stabiliti possono essere esercitati tanto da formazioni parcellari della maggioranza, quanto dell’opposizione; ma la prassi sempre più frequente della “presidenzializzazione” degli esecutivi impone ormai che siffatto statuto vada definito formalmente.
Ad esempio, proprio sulla base di questa lacuna la Consulta, con l’ordinanza n. 17/2019, ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dai senatori del gruppo del Partito Democratico in relazione all’iter di approvazione della legge di bilancio 2019: difatti, allo Stato, un gruppo parlamentare di minoranza non può agire, nella prassi parlamentare o in giudizio dinanzi alla Corte, quale autonomo potere dello Stato.
Per la verità, mediante l’ordinanza in esame, la Corte distingue i profili soggettivi da quelli oggettivi della questione: dal punto di vista dei primi, tale ordinanza rappresenta un punto di svolta, specificandosi in essa i poteri del singolo parlamentare di cui agli artt. 71 e 72, Cost., dall’angolo di visuale dei secondi, invece, la Corte ha enormemente delimitato la legittimazione del singolo membro di una Camera alle sole “violazioni manifeste delle prerogative costituzionali” che “assurgono a requisiti di ammissibilità” del conflitto, manifestando una sorta di timore dei rischi insiti nell’apertura ad una sorta di “accesso diretto” del singolo parlamentare al sindacato di costituzionalità di una legge – specie come quella di bilancio.
Appena un anno dopo, con l’ordinanza n. 60/2020 (in tema dell’iter di approvazione della legge di bilancio 2020), la Corte compie addirittura un passo indietro rispetto alle enunciazioni dell’anno precedente, in quanto finisce per piegare totalmente le prerogative del singolo parlamentare o gruppo di opposizione ai dogmi dell’efficienza e della tempestività della decisione, giustificando sulla base di essi una vistosa “torsione” del sistema costituzionale, che si ricomporrebbe grazie alla “naturale elasticità” del sistema istituzionale che, secondo la Corte, risulta perennemente soggetto a bilanciamenti e assestamenti.
Da questo punto di vista, è utile una comparazione con l’ordinamento francese: lì il Conseil constitutionnel, nel 2006, dichiarò costituzionalmente illegittima la modifica dell’art. 19 del regolamento dell’Assemblea nazionale, introducente l’obbligo, per i presidenti dei gruppi parlamentari, di dichiarare se il gruppo presieduto afferisse alla maggioranza o all’opposizione: in forza di quella dichiarazione sarebbero scaturite specifiche prerogative. L’incostituzionalità di tale norma fu dichiarata da parte del Conseil per contrasto con l’art. 4, comma 1, della Costituzione, che sancisce la libera attività di ciascun gruppo. Secondo il Consesso, infatti, la normativa censurata avrebbe avuto l’effetto di instaurare una differenza di trattamento ingiustificata tra i gruppi.
Il legislatore francese ha poi tenuto conto di tale pronuncia in occasione della revisione costituzionale del 2008, introducendo l’art. 51-1 della Carta, secondo cui “il regolamento di ogni assemblea determina i diritti dei gruppi parlamentari istituiti in seno ad essa. Esso riconosce dei diritti specifici per i gruppi di opposizione della relativa assemblea, così come per i gruppi minoritari”. L’art. 51-1 della Costituzione costituisce a chiare lettere, nell’ordinamento francese, il nucleo fondante del c.d. “statuto” delle opposizioni che, senza attribuire differenze ingiustificate tra i gruppi e la loro appartenenza, mette in risalto costituzionale la voce in assemblea dei gruppi di opposizione, o anche solo minoritari.
È interessante poi esaminare brevemente le vicende riguardanti le opposizioni parlamentari in Francia nelle elezioni presidenziali del 2017 e del 2022: nelle prime, che vedevano la vittoria a mani basse di Macron contro Le Pen, il partito del Presidente vittorioso, Renaissance, aveva guadagnato la maggioranza assoluta attraendo voti sia da sinistra che da destra, e così determinando la débacle dell’avversaria; invece, cinque anni dopo, alle presidenziali del 2022, lo scarto tra i due contendenti fu molto minore, e portò al più grande scacco matto alle opposizioni in parlamento, e cioè il frequentissimo ricorrere alla caducazione della discussione parlamentare e la conseguente approvazione senza votazione del testo di legge governativo. Si evince quindi che nel primo caso (2017) Macron si fece forza anche del voto delle opposizioni politiche per ottenere la maggioranza assoluta; nel secondo, invece (2022), la labile maggioranza dello stesso ha dovuto astutamente aggirare la voce delle minoranze in Parlamento per ottenere l’approvazione dei propri provvedimenti legislativi.
In Italia, il d.d.l. Renzi-Boschi del 2016, se avesse superato il vaglio referendario, avrebbe potuto sortire il medesimo effetto: era difatti stata prevista l’introduzione di un nuovo secondo comma all’art. 64 della Costituzione, che avrebbe recitato che “i regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni”.
Stante la mancanza di una copertura costituzionale delle opposizioni in seno al Parlamento italiano, la disciplina normativa attribuisce in ogni caso a queste svariate prerogative, ma non tali da poter assicurare loro il pieno svolgimento di quella funzione di garanzia necessaria al miglior funzionamento del complesso delle istituzioni democratiche.
Specie in un momento storico come quello che stiamo oggi vivendo, con una maggioranza schiacciante nei numeri e prevaricatrice nei comportamenti politico-istituzionali, nell’ipotetico statuto costituzionale delle opposizioni (che con l’aria che tira si dubita fortemente arriverà, specialmente a stretto/medio giro) dovrebbe essere addirittura ricompresa l’espressione della figura del Presidente della Repubblica, l’unica, oggigiorno, a dover persino ricordare alle istituzioni di maggioranza che è vietata, a livello costituzionale, la ricostituzione del disciolto partito fascista e che, di conseguenza, la Repubblica italiana ha stampo antifascista.
Se anche la massima carica dello Stato finisse oggi nelle schiere dell’attuale maggioranza, non ci sarebbe alcun modo per garantire un nucleo anche minimo di garanzia istituzionale. Ciò è vero poiché è ormai notorio quanto il Presidente della Repubblica, visto il declino qualitativo dei partiti, debba assumere sempre più, sempre nella sua posizione di super partes, il ruolo di decisore (o quantomeno mediatore) politico.


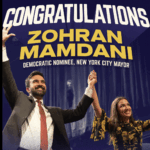






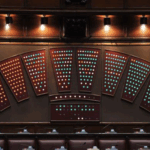

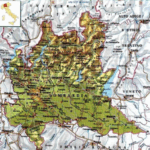



 Gustavo Zagrebelsky
Gustavo Zagrebelsky
 Donatella Stasio
Donatella Stasio

