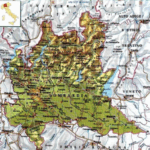Pochi ricordano il nome di Pierre-Joseph Proudhon, morto centocinquant’anni fa. Qualcuno ne incontra lo sguardo nei musei parigini che espongono i due ritratti del suo amico Gustave Courbet. Compaiono ancora nelle discussioni pubbliche alcune sue frasi taglienti – «la proprietà è un furto», «chi dice umanità vuole ingannarvi ». Quest’ultima appartiene all’archivio delle denunce dell’uso strumentale e distorcente di grandi parole, come quelle attribuite a Madame Roland mentre veniva condotta alla ghigliottina («O libertà, quanti crimini si commettono in tuo nome») o a Samuel Johnson («il patriottismo, ultimo rifugio di una canaglia»). L’invettiva di Proudhon ha trovato un rilancio e un’ambigua, rinnovata fortuna quando se ne è impadronito nel 1927 Carl Schmitt, che dell’idea di umanità ha parlato come di una «disonesta finzione», come di «uno strumento ideologico particolarmente idoneo alle espansioni imperialistiche ». Queste parole sferzanti colgono l’uso strumentale del termine, gli abusi linguistici e politici, tra i quali spicca ormai il riferimento alla “guerra umanitaria” per fondare interventi ispirati a pura logica di potenza. La riflessione di Schmitt è accompagnata dal rifiuto della “dottrina della fratellanza e dell’uguaglianza”, sì che la costruzione della “vera humanitas”, svincolata da questi riferimenti, deve rispondere a un «ideale di selezione razziale e matrimoniale», che si converte in un’esclusione dall’umanità di chi non corrisponde ad un determinato modello, con gli esiti violenti che abbiamo conosciuto. Sgombrato il campo dalla disonesta finzione, il dato reale è la consegna alla politica liberata da ogni vincolo di tutti gli esclusi, ormai degradati a oggetti.
Nelle parole di Proudhon si coglie piuttosto una messa in guardia, in quelle di Schmitt una ripulsa. Si avvia così una costruzione dell’umanità “per sottrazione”, con una continua operazione di “scarto” di coloro i quali non sono ritenuti degni di farne parte. Ma questa non è una vicenda che possiamo consegnare al passato, per tranquillizzarci. Viviamo in società che producono quelle che Zygmunt Bauman ha definito “vite di scarto”, selezionate con criteri attinti unicamente dal processo produttivo. Ecco allora un orizzonte ingombro di poveri e disoccupati, precari e immigrati, persone alle quali vengono negate eguaglianza e dignità, destituite di umanità.
Il realismo drammatico di questa constatazione, tuttavia, non ci consegna ad un pensiero che deve espellere da sé la consapevolezza dell’umanità. Al rifiuto dell’altro, al disgusto che può destare il suo modo di vivere, Martha Nussbaum contrappone “la politica dell’umanità”. Alla sottrazione di diritti, che la costruzione per sottrazione dell’umanità implica, si oppone la riflessione di Hannah Arendt, che ci ricorda come «il diritto ad avere diritti, o il diritto di ogni individuo ad appartenere all’umanità, dovrebbe essere garantito dall’umanità stessa».
Ma come si definisce l’umanità? Chi parla in suo nome? Per rispondere, bisogna muovere da una premessa semplice, anche se impegnativa: può ritrovarsi umanità solo là dove eguaglianza, dignità e solidarietà trovano pieno riconoscimento. Troviamo un riferimento eloquente nelle parole dell’Internazionale: «L’In-ternazionale futura umanità», bella traduzione del testo originale, dove si dice «l’Internationale sera le genre humain». Perché sottolineare queste parole? Perché l’umanità è declinata al futuro, non è vista come la somma degli esseri viventi, come un semplice dato quantitativo, un insieme biologico, una realtà già esistente, di cui ci si può limitare a prendere atto. È qualcosa da costruire incessantemente attraverso l’azione comune e solidale di una molteplicità di soggetti, che producono non tanto un “valore aggiunto”, ma una realtà continuamente “aumentata”. È il processo al quale stiamo assistendo, quello di umanità che include e riconosce tutti gli altri, quasi capovolgendo la conclusione di Sartre, «l’inferno sono gli altri».
Ma, con la globalizzazione, questa umanità si fa tutta presente, e può essere percepita come invadente. Ogni accadimento, per quanto lontano, ci fa partecipi di quel che accade alle persone colpite da un terremoto, o da uno tsunami, in luoghi che fino a ieri erano remoti e che il sistema della comunicazione avvicina e rende visibili. Questo provoca moti di solidarietà: basta digitare un numero sul cellulare per far arrivare un contributo finanziario all’alluvionato asiatico o al bambino africano. Se, però, queste persone si materializzano ai nostri confini, possono diventare oggetto di rifiuto. È così per i migranti, per i poveri, visti come aggressori o incomodi. Così gli altri tornano ad essere segni d’un inferno al quale si vuole sfuggire.
Di colpo l’umanità si scompone e si immiserisce. Quella lontana suscita ancora sentimenti e azioni solidali, quella vicina turba. L’idea di “prossimo” si rattrappisce, sembra addirittura morire. Al suo posto troviamo spesso comunità chiuse. Ma questa constatazione, ci conferma che l’umanità è una costruzione ininterrotta, non un approdo consolatorio. Vi sono usi di “umanità” che la costruiscono come un riferimento capace di sottrarci a sopraffazioni. Quando si parla di patrimoni dell’umanità, si sfidano sovranità e proprietà, che vorrebbero sottoporre al potere e agli egoismi degli Stati e dei privati pezzi del mondo, e persino ciò che è fuori di esso come spazio e tempo. Lo spazio extra-atmosferico non può essere sottoposto alla sovranità statale, come il fondo del mare o l’Antartide. I luoghi dichiarati dall’Unesco patrimonio dell’umanità vengono ritenuti meritevoli di una disciplina che li sottragga agli intenti speculativi nell’interesse anche delle generazioni future. E così cominciano ad individuarsi anche i soggetti che possono parlare in nome dell’umanità, con specifici diritti, obblighi e responsabilità. Compaiono gli Stati che, avendo firmato un trattato comune sullo spazio extra-atmosferico o sul fondo del mare, possono opporsi alle mire di chi vuole appropriarsene. E tutte le persone alle quali, per salvaguardare un sito o un ambiente o una eredità culturale, deve essere attribuito un diritto di azione popolare per impedire che interessi proprietari possano sottrarre all’umanità il godimento di quei beni.
Qui l’umanità comincia a parlare il linguaggio dei beni comuni. L’acqua e l’aria, l’ambiente globale e la conoscenza in Rete, mostrano connessioni che rinviano alla sopravvivenza stessa dell’umanità, all’esistenza di ogni suo componente, quindi alla necessità di sottrarre quei beni a forme di appropriazione che possono determinare la negazione di diritti fondamentali. Ma l’umanità si trova di fronte anche all’imperativo di sottrarre se stessa a trasformazioni che portano verso un ambiguo postumano o addirittura alla sua scomparsa, sopraffatta dall’intelligenza artificiale. È il tema della tecnoscienza ad occupare sempre più l’orizzonte, con le denunce di una persona espropriata di umanità, avviata a divenire una “nano- bio-info-neuro machine”. Inoltrandosi in questo sconfinato territorio, la comprensione non è aiutata dal cedere agli opposti estremismi di un catastrofismo senza speranza e di un ottimismo senza misura. Le indispensabili analisi del mutamento, di cui non vanno ignorati i benefici, dovrebbero sempre essere accompagnate da un consapevole sguardo all’indietro, mantenendo saldamente al centro eguaglianza e dignità. L’eguaglianza nell’accesso ai vantaggi incessantemente offerti dalla tecnoscienza è condizione indispensabile perché non nasca una società “castale”. La dignità è limite invalicabile, perché proprio qui, reagendo alle aggressioni di ieri e alle negazioni di oggi, possiamo ritrovare il proprio dell’umano.
Repubblica, 7 dicembre 2015