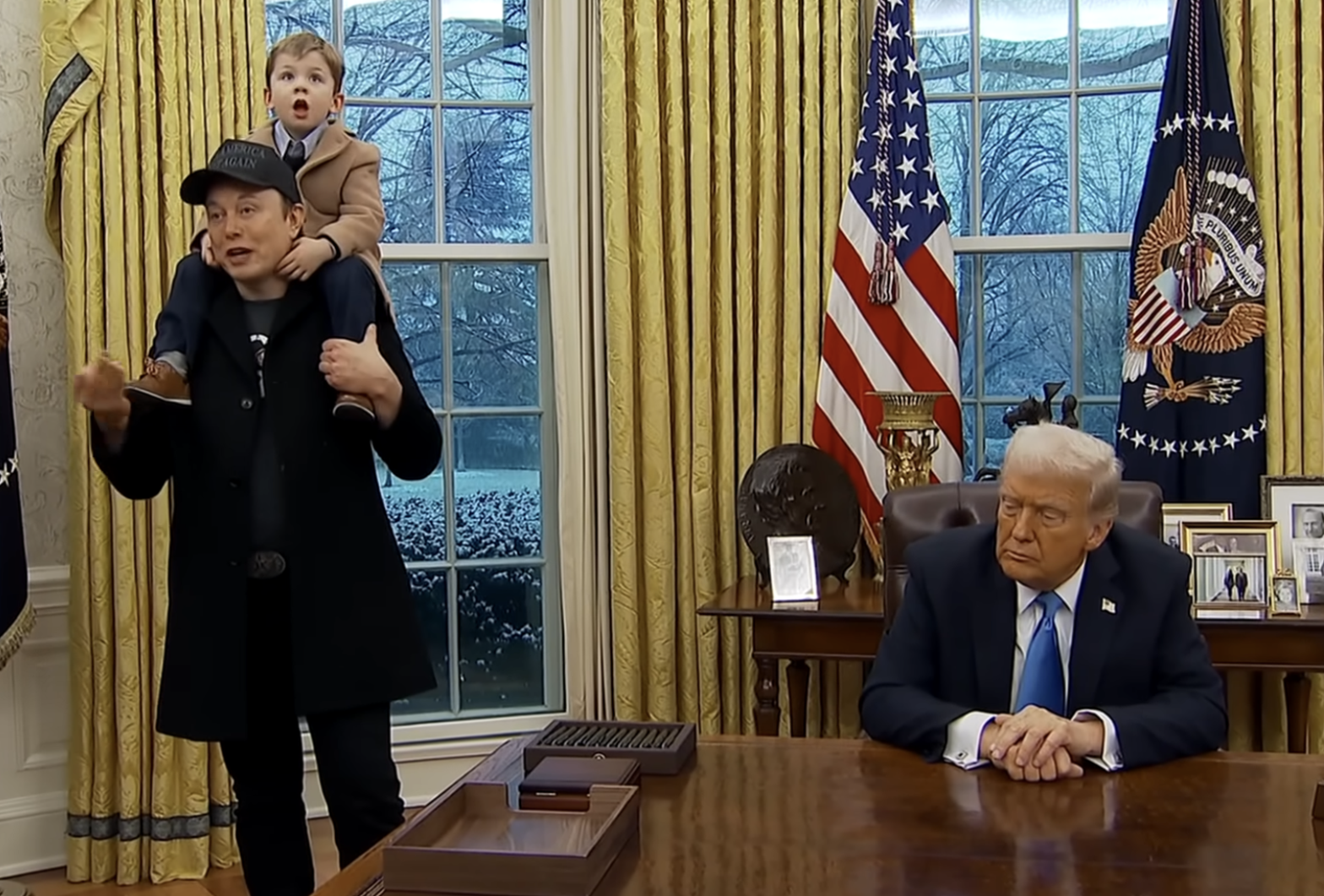L’attesa sentenza del 1 agosto 2025 della Corte di Giustizia dell’Unione europea (cause riunite Alace e Canpelli) è particolarmente importante perché, nel chiarire la portata del concetto di “Paese di origine sicuro” in materia di protezione internazionale, riafferma solennemente il principio del diritto di difesa e della necessità di un controllo giurisdizionale, caso per caso, su ogni singola domanda d’asilo.
Tale diritto deve, infatti, essere garantito a tutte le persone, richiedenti asilo compresi, sulla base dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Ora tutti i giornali enfatizzano che la Corte di Lussemburgo ha dato torto al governo italiano sul controverso protocollo con l’Albania.
Si tratta, in realtà, di una lettura parziale, perché la questione del trattenimento in territorio albanese dei richiedenti asilo nell’ambito delle cosiddette procedure accelerate di frontiera ha a che fare solo incidentalmente con questa pronuncia.
Sul punto la Corte di Giustizia sarà chiamata a esprimersi a seguito di un altro rinvio pregiudiziale dello scorso 25 giugno, da parte della Corte di Cassazione, che dubita della legittimità del trattenimento nel Cpr di Gjader dei migranti coinvolti nelle procedure di espulsione rispetto alla direttiva rimpatri. Il governo, con decreto-legge 28 marzo 2025 n. 37, ha, infatti, consentito il trasferimento in Albania degli stranieri destinatari di provvedimenti di trattenimento convalidati o prorogati dai giudici di pace in esecuzione di un decreto di espulsione. Tale frettoloso cambio di rotta da parte del governo si configura come un maldestro tentativo di fare fronte allo svuotamento dei centri albanesi dei richiedenti asilo, a cui inizialmente essi erano destinati, proprio in conseguenza dei dubbi interpretativi sollevati dai giudici romani ed oggetto della sentenza del 1 agosto.
Ma torniamo alla sentenza di ieri.
I casi posti all’attenzione della Corte di Giustizia riguardano due cittadini del Bangladesh, soccorsi in acque internazionali dalle autorità italiane, condotti in Albania e trattenuti nel centro di Gjader per essere sottoposti alle procedure accelerate di frontiera in quanto provenienti da un paese suppostamente sicuro.
È la legislazione europea a introdurre sia le procedure accelerate di frontiera sia la categoria di Paese di origine sicuro (ai cui cittadini dette procedure sono riservate), lasciando agli Stati membri il compito di designare tali paesi attraverso dei criteri di ordine generale sanciti dall’allegato I della direttiva 32/2013, la c.d. direttiva procedure. L’Italia inizialmente li aveva indicati con un decreto interministeriale che conteneva delle schede informative su ogni paese ma nell’ottobre del 2024, per superare le frequenti disapplicazioni di detto decreto da parte dei giudici, il governo ne traspone la lista in un decreto-legge, convertito in legge lo scorso 4 dicembre. Tale legge non fa più riferimento alle schede paese né indica le fonti sulla cui base il governo è pervenuto a designarli come sicuri. Per i cittadini dei paesi ritenuti sicuri è consentita una procedura più sommaria perché vi è la presunzione relativa che essi non abbiano diritto a vedersi riconoscere la protezione internazionale. Essi non hanno diritto alla sospensione automatica del rigetto della domanda da parte delle competenti Commissioni territoriali in caso di ricorso ed anche i termini processuali sono abbreviati.
Nella vicenda oggetto della sentenza della Corte di Giustizia il tribunale di Roma non provvedeva alla convalida del trattenimento dei due cittadini del Bangladesh, rimettendo in libertà i due richiedenti, i quali, tornati in Italia, avanzavano ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale di rigetto delle loro domande all’esito della menzionata procedura accelerata perché provenienti, appunto, da paese sicuro.
È in sede di ricorso che il tribunale di Roma solleva i dubbi di compatibilità della normativa italiana con quella europea, chiedendo alla Corte di chiarire: 1) se una legge nazionale possa designare uno Stato terzo come Paese di origine sicuro; 2) se il legislatore nazionale possa “non rendere accessibili e verificabili le fonti adoperate per giungere a detta designazione impedendo al richiedente asilo e al giudice di sindacarne la provenienza, l’autorevolezza, l’attendibilità, la pertinenza, l’attualità, la completezza ed in generale il contenuto al fine di trarne le proprie valutazioni sul merito di una tale designazione secondo quanto prescritto dalla normativa europea”; 3) se in una procedura accelerata di frontiera il giudice possa utilizzare informazioni sul paese di provenienza attingendole da fonti indipendenti come quelle indicate nell’allegato I alla direttiva procedure; 4) infine se possa essere ritenuto sicuro un Paese nel quale alcune categorie di persone non possono considerarsi tali.
La questione più controversa, l’ultima elencata, è quella sul concetto di paese di origine sicuro. Secondo la Corte di Giustizia i giudici italiani avevano ragione nel dubitare che un paese terzo possa definirsi “di origine sicuro” per un richiedente asilo, qualora lì vi siano categorie di persone non sicure (perseguitate o violate nei loro diritti per l’appartenenza a determinate categorie sociali invise al governo di quel paese), come nel caso del Bangladesh.
La Corte, sul punto, ritiene che la normativa europea attualmente in vigore (la direttiva n. 32 del 2013) non lo consenta alla luce di un’interpretazione letterale del suo articolo 37, secondo il quale un paese terzo può essere designato sicuro se è possibile dimostrare che non ci sono “generalmente” e “costantemente” persecuzioni, né tortura o altre forme di pena o trattamento disumano o degradante, né pericolo a causa di una violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Tali termini tendono ad indicare che dette condizioni devono essere rispettate con riferimento a tutta la popolazione del paese terzo interessato: “essi esprimono quindi la scelta del legislatore dell’Unione di subordinare la designazione di un paese di origine sicuro alla condizione che il paese terzo sia, generalmente, sicuro per tutta la sua popolazione e non solo per una parte di essa “.
I giudici di Lussemburgo riconoscono che, con il nuovo regolamento procedure (2047/1348), che sarà in vigore dal 12 giugno 2026, la normativa europea in materia subirà una restrizione poiché saranno consentite eccezioni per categorie di persone chiaramente identificabili e che ciò rientra nella prerogativa del legislatore dell’Unione di tornare su tale scelta, procedendo ad un nuovo bilanciamento degli interessi in causa. Tuttavia, sino all’entrata in vigore di tale regolamento (che potrebbe essere anche anticipata) si dovrà applicare l’articolo 37 della direttiva procedure.
La decisione della Corte sul punto potrà avere ricadute significative da qui all’entrata in vigore del nuovo regolamento Ue perché molti dei richiedenti asilo provengono da Paesi che non possono ritenersi sicuri perché vi fanno eccezione diverse categorie. Di conseguenza essi non potranno essere sottoposti alle procedure accelerate di frontiera né trattenuti a tal fine, in Albania o in altri centri posti sui nostri confini.
Ma quello che più colpisce della sentenza è la solenne affermazione che tutte le procedure riguardanti i richiedenti asilo devono garantire l’effettivo esercizio del diritto di difesa.
La Corte analizza le questioni poste alla sua attenzione attraverso la lente dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che riprendendo le disposizioni già contenute nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo, sancisce il diritto di ogni persona a un ricorso effettivo davanti a un giudice imparziale.
È su questa base che la Corte chiarisce che “al diritto ad un ricorso effettivo (..) corrisponde l’obbligo imposto agli Stati membri (..) di prevedere in favore dei richiedenti protezione internazionale tale diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo”.
Se per la Corte nulla osta a che sia la normativa nazionale a designare un Paese come di origine sicuro ciò “non incide sull’obbligo di ogni giudice nazionale di garantire la piena efficacia” della direttiva procedure “disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione nazionale, anche posteriore, che sia contraria a una disposizione di tale direttiva (..)”. Qui la Corte, magistralmente, continua nel ribadire che “gli Stati membri sono tuttavia tenuti ad assicurare, in ciascun caso, il rispetto del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva di tali diritti, quale garantito dall’articolo 47 della Carta (..)”. E ancora: “spetta, dunque, a ciascuno Stato membro garantire il rispetto del diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo che l’articolo 46, paragrafo 1, di detta direttiva riconosce ai richiedenti protezione internazionale (..)”.
Se la premessa è questa, logicamente le risposte agli altri quesiti posti dai giudici di Roma vanno tutte nella direzione dell’obbligo di garantire l’effettività del diritto di difesa, ovvero che tutte le fonti utilizzati dagli Stati membri per designare come sicuro un Paese terzo siano accessibili in modo che il “richiedente sia messo nelle condizioni di conoscere le ragioni per le quali si presume che il suo paese di origine sia sicuro”.
Allo stesso modo non può impedirsi ai giudici nazionali di avvalersi per l’esame del caso concreto e nel contraddittorio delle parti di informazioni analoghe a quelle che sono utilizzabili dagli Stati membri ai fini della designazione.
Di nuovo i giudici europei richiamano a garanzia dell’effettività del diritto di difesa l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva procedure che ne definisce con precisione “la portata di tale diritto a un ricorso effettivo (..) gli Stati membri devono assicurare che il giudice innanzi al quale è contestata la decisione relativa alla domanda di protezione internazionale proceda a un esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto, compreso, se del caso, l’esame delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della direttiva” (qui vengono richiamati precedenti della stessa Corte di Giustizia).
In conclusione, a prescindere da quella che sembra essere una prossima involuzione del diritto d’asilo a livello europeo, i principi contenuti in questa sentenza non potranno essere scalfiti facilmente anche da quegli Stati che, come il nostro, non concepiscono limiti al potere dell’esecutivo, ritenuto investito direttamente dal popolo.
La riaffermazione della centralità della giurisdizione in una materia così delicata come quella della protezione internazionale fa ben sperare nella tenuta dello stato di diritto.
Si può prevedere che, alla luce di questa sentenza, anche in vigenza del nuovo regolamento del 2026 il richiedente asilo anche da Paese considerato di origine sicura dovrà poter contare su un esame approfondito da parte del giudice delle fonti che lo Stato utilizza per designarlo tale, nel contraddittorio delle parti e con approfondita valutazione delle esigenze di protezione, aldilà di ogni automatismo.














 Nadia Urbinati
Nadia Urbinati