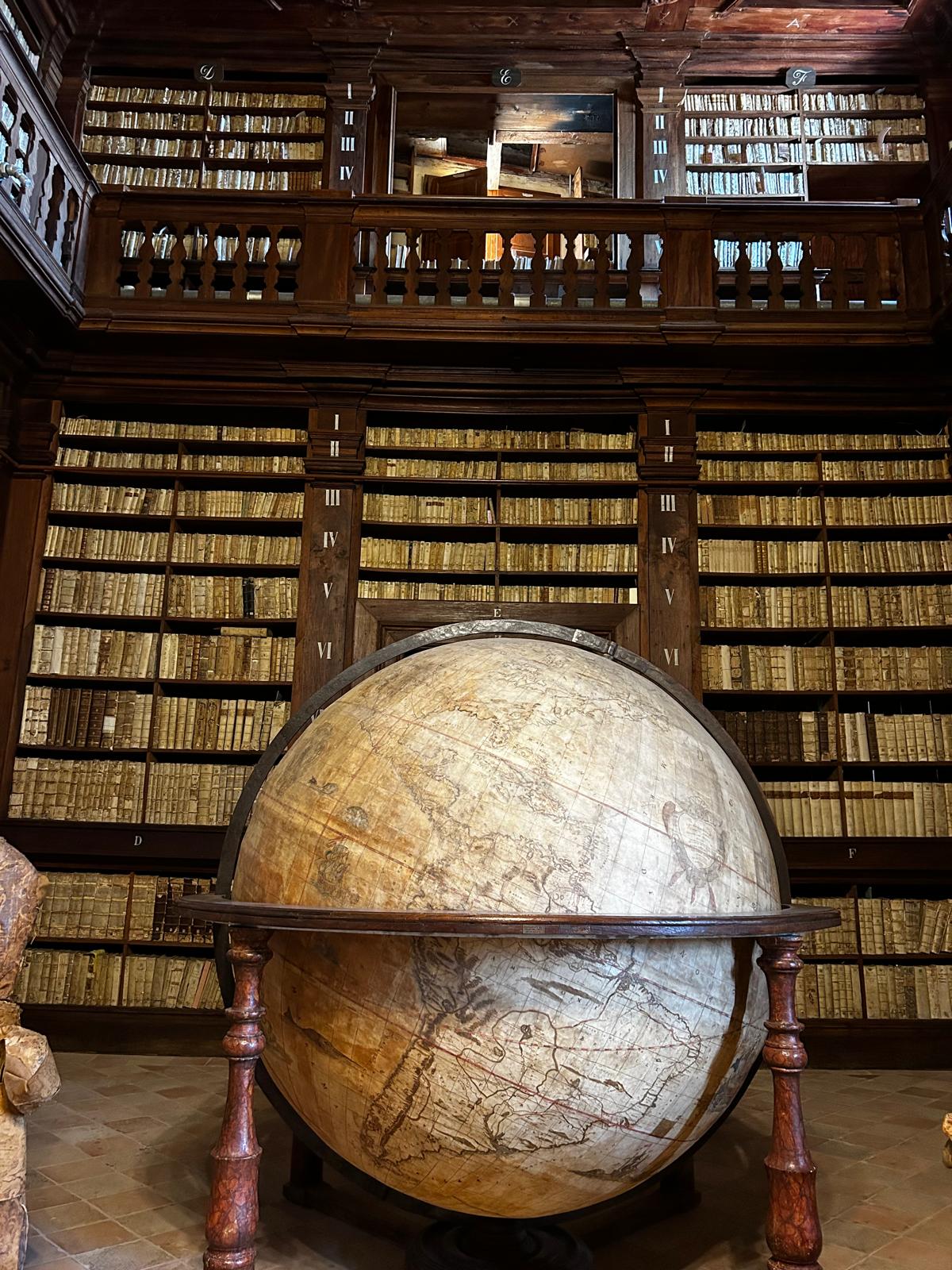Daniela Padoan: A metà degli anni Cinquanta, davanti all’avvento di massa di radio e televisione, il filosofo tedesco Günther Anders predisse la nostra progressiva trasformazione in spettri: individui condannati a nutrirsi di un mondo fantasmatico, attraverso un «sistema di apparecchi» che avrebbe preso il posto del mondo reale facendone a sua volta un fantasma. Non crede che, nell’era digitale, queste parole illuminino il consolidarsi di una nuova forma di autoritarismo?
Daniel Innerarity: Tutta la tecnologia, e forse ancora di più quella digitale, provoca in noi risposte riflesse, piuttosto che riflessività. La tecnologia funziona senza richiedere, o addirittura permettere, di adottare un rapporto esplicito con essa. Questa caratteristica è particolarmente intensa nel caso delle tecnologie digitali, che assumono un’aura di neutralità: passano inosservate, privilegiando l’automatismo, il tacito sull’esplicito. Le tecnologie, e in particolare l’ubiquitous computing, si integrano nel tessuto sociale fino a diventare indistinguibili, generando un «inconscio digitale»: una variazione sull’idea del «sonnambulismo tecnologico» avanzata da Langdon Winner, una mancanza di consapevolezza dello sviluppo tecnologico e delle sue conseguenze, incontrastata, funzionale e neutrale.
DP: La nozione di inconscio digitale potrebbe essere l’evoluzione dell’affermazione di Anders per cui la tecnologia che ci sovrasta, pretendendo da noi qualcosa di eccessivo e impossibile, ci consegna a uno stato patologico collettivo. L’angoscia dell’essere defraudati della capacità di comprendere un mondo sempre più lontano dall’esperienza, divenuto esso stesso macchina, e di distinguere tra realtà e apparenza, si placa nella trasformazione della realtà in spettacolo, ovvero in qualcosa che non ha bisogno della nostra partecipazione.
DI: Questo però non significa che le decisioni chiave siano delegate a macchine in cui non c’è l’uomo. Direi piuttosto che siamo indotti a prendere decisioni in modo tale da non chiederci chi ne sia il vero autore. I sistemi automatizzati ci spingono alla sconsideratezza, nel senso descritto da Hannah Arendt: l’incapacità di criticare le istruzioni, la mancanza di riflessione sulle conseguenze, la volontà di credere che gli ordini siano corretti. L’ideologia della ragione algoritmica non è tanto l’occultamento o la manipolazione deliberata, quanto la sconsideratezza. La sua naturalizzazione consiste nel non chiedersi più a quale tipo di razionalità risponda la razionalità algoritmica; nel pensare che non esista una razionalità alternativa o, almeno, un divario di possibilità su cosa fare con quella razionalità.
DP: Il suddito ideale del regime totalitario è colui che, sottoposto al terrore e a una sistematica manipolazione della realtà, smarrisce la capacità individuale di giudizio e quindi la possibilità di distinguere il vero dal falso. Se la perdita della facoltà di pensare autonomamente garantisce al potere assoluto quell’obbedienza incondizionata che è il presupposto essenziale per realizzare i suoi fini, oggi, in regimi di democrazia sempre più svuotata, corriamo il rischio che una forma pervasiva di propaganda alimenti quella “sconsideratezza” cui ci spingono i sistemi automatizzati, e che al tempo stesso se ne alimenti.
DI: Con la particolarità che l’autoritarismo tecnologico ha prodotto una svolta inaspettata nella vecchia battaglia tra destra e sinistra. Oggi vediamo fronteggiarsi fretta e lentezza: il razzo contro la conversazione, la velocità contro la deliberazione, l’incontrollato contro il regolamentato. Lo Stato, le procedure e la stessa democrazia sono presentati come istituzioni della lentocrazia. Si è diffusa la convinzione di Peter Thiel, il libertario che ha fondato PayPal con Elon Musk, per cui i problemi del mondo contemporaneo non possano essere risolti nel quadro dei valori e delle procedure democratiche. In questa logica, gli esponenti dell’estrema destra vengono considerati affidabili quando parlano a nome dei lavoratori. Una parte della cosiddetta casta guida la lotta contro la casta. La critica alle élite improduttive si sposta da sinistra a destra. Gli autoritari non appaiono più come i difensori del passato ma come coloro che promettono un futuro transumano e post-democratico.
DP: Se prima conservatore era chi difendeva la tradizione, oggi è la sinistra ad essere rappresentata come ancien régime: protettrice delle costituzioni democratiche, degli istituti sovranazionali a tutela dei diritti umani, di una critica del progresso visto come causa dell’erosione del pianeta. Ma la “rivoluzione” tecnologica della destra a cui lei fa riferimento è restauratrice nel suo ipostatizzare un’età dell’oro. Come siamo arrivati a quello che potremmo definire un tecno-darwinismo sociale che, mentre sogna la colonizzazione di Marte, chiede il lavoro schiavo dei carcerati, la deportazione dei migranti, il boicottaggio dell’Onu e dalla Corte penale internazionale?
DI: Credo che il posto classico della politica oggi sia occupato da un esibizionismo tecnologico che afferma di voler superare la lentezza burocratica ma che in realtà disprezza le procedure democratiche. Se si presenta come democratico, è perché è riuscito a far credere di voler realizzare una richiesta di efficienza, prestazioni e soluzioni immediate che la politica democratica ha smesso di fornire, e se impone un ritmo così veloce alla politica, è perché non perde tempo a considerare i suoi effetti sociali e ambientali. Il mantra secondo cui la regolamentazione impedisce la creatività è il grimaldello di cui ha bisogno per sfruttare opportunisticamente le lacune legislative. L’accelerazionismo dà risultati immediati perché, a differenza della deliberazione democratica, non perde tempo a cercare le opinioni di coloro che sono colpiti dalle sue decisioni. Ma senza riflessione, dibattito e inclusione si arriva rapidamente a una spoliticizzazione dove a perdere sono essenzialmente coloro che non hanno i mezzi per far valere i propri interessi. Non a caso l’odierno tecno-soluzionismo sfida la riflessione e la responsabilità mentre plasma un ambiente politico privo di dibattiti significativi e di opportunità di contestazione.
Osservatorio Autoritarismo
Il luogo dove agire insieme per comprendere e fermare il processo di svuotamento della democrazia costituzionale e il progressivo attacco alla libertà di espressione e manifestazione.
Sostieni il progettoL’Osservatorio Autoritarismo è un’iniziativa promossa da Libertà e Giustizia e dalla casa editrice Castelvecchi con la partecipazione di docenti e studiosi di numerose università italiane.
I firmatari del testo costitutivo dell’Osservatorio continuano a crescere con l’adesione, tra gli altri, di Gabriele Nissim e Adam Przeworski.