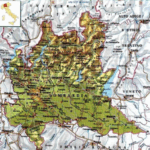Non credo esista modo migliore di verificare se un libro “funziona” di quello di interrogarsi sulle domande che esso ci pone. E dalla lettura delle riflessioni di Umberto Ranieri in “Eravamo comunisti”, il libro edito da Rubbettino in occasione del centenario della fondazione del PCI, non si può certo dire che non vengano poste delle importanti e spesso affascinanti questioni.
La prima è: ci troviamo di fronte a un saggio oppure al racconto di una storia di cui l’autore è stato partecipe in prima persona e sotto la cui lucida analisi cova ancora il tepore delle passioni? O invece, come avviene in alcuni brani di un classico della storiografia contemporanea come “Il Secolo Breve”, ci troviamo di fronte a entrambi questi elementi, pur restando Ranieri, autore di un saggio sul padre della socialdemocrazia Bernstein, su posizioni ben distanti da quelle del grande storico marxista leninista austro-britannico?
Ma veniamo subito al principale quesito posto dal libro di Ranieri, che a mio parere non verte tanto sul perché il PCI non sia riuscito a trasformarsi in un partito socialdemocratico, cosa mai accaduta ad un partito comunista nella storia, ma piuttosto su come mai ciò sia stato ritenuto possibile da alcuni esponenti riformisti del PCI, al punto da dedicare la propria vita politica a questo scopo. E potrei citare tra gli intellettuali Biagio De Giovanni e Salvatore Veca, che appaiono nel libro con dei brevi interventi assieme all’intellettuale e politico socialista Giuliano Amato, o anche Michele Salvati e Massimo Salvadori e, tra i politici, oltre all’autore i “miglioristi” Giorgio Napolitano e Gerardo Chiaromonte (nella scia di Giorgio Amendola) o, con altri connotati e contaminazioni, figure come quelle di Alfredo Reichlin e di Emanuele Macaluso e di numerosi leader della CGIL, con in testa il mitico Giuseppe Di Vittorio.
L’opera prende le mosse da un’analisi che parte dalle radici della diversità del comunismo italiano, che affondano nell’influenza che l’idealismo di Croce e Gentile ebbero su Gramsci e sulla commistione di materialismo storico e di liberalismo che la complessità del suo pensiero assunse abbracciando, come scrive Aldo Schiavone, “elementi di una teoria della democrazia eterodossi rispetto al pensiero di Marx” ma in parallelo si dipanano anche le ragioni delle esitazioni che vi furono anche all’interno del Partito socialista italiano, a percorrere la strada di un riformismo socialdemocratico sia nel periodo anteriore all’avvento del fascismo sia nel frontismo che caratterizzò gli anni ‘40 e ’50, come anche nelle irrequietezze del PSI dopo l’avvento del centrosinistra negli anni ’60 e nelle successive fughe indietro.
Non a caso l’autore ripercorre il filo della cultura schiettamente riformista, democratica e socialista liberale di Carlo Rosselli e degli esponenti di Giustizia e Libertà, e di coloro che confluirono nel Partito d’Azione e poi nel Partito Repubblicano o nel Mondo di Pannunzio.
Io che, da giovane repubblicano, ebbi modo di testimoniare lo sgomento di Ugo La Malfa quando vide “sciogliersi” il tentativo avviato nella seconda metà degli anni ’70 assieme ad Aldo Moro di scongiurare la spirale di declino che da quei giorni si è abbattuta sul Paese, coinvolgendo in un corale sforzo riformista il Partito comunista e le forze sindacali ad esso vicine, ritrovo oggi dalla prospettiva di un insider nel PCI l’analisi delle ragioni che impedirono quello che sarebbe stato un conseguimento unico nella storia europea e mondiale del dopoguerra.
Forse quel miracolo sarebbe potuto avvenire in Italia negli anni ’70, visto che alcune delle figure che avevano partecipato alla resistenza e all’avvento del nuovo assetto costituzionale repubblicano avevano mantenuto, pur nella dura contrapposizione politica, quei presupposti di rispetto e di stima reciproca che avrebbero potuto renderlo possibile? È difficile dare una risposta positiva, anche se proprio le ombre che gravano sul rapimento e sull’omicidio di Aldo Moro e i fatti successivi potrebbero far ritenere che questo scenario non sarebbe stato impossibile. Tuttavia l’attento esame che Ranieri svolge sulle complessità della sinistra italiana e in particolare le ambiguità e contraddizioni del PCI, che spaziano dai limiti di Giorgio Amendola e il ruolo da lui assunto nella vicenda del Manifesto alle aperture al pragmatismo riformista di una personalità legata allo stalinismo come Togliatti, alle soltanto parziali aperture di un leader carismatico come Berlinguer, la cui mitizzazione tende tuttavia ad ampliarne arbitrariamente l’apertura ideologica, che non fu certo pari a quella che un Santiago Carrillo pagò con la espulsione dal PCE.
La storia successiva, dal crollo del muro di Berlino al cambiamento del nome PCI, dall’avvento del Mattarellum a seguito del referendum e di Tangentopoli alla prima stagione dei governi Prodi ed alla sua chiusura nel ‘98, costituisce a mio avviso un’altra occasione perduta ed un arroccamento degli eredi del PCI, che non si aprirono sufficientemente verso l’esterno, sino al punto di aver perso ai nostri giorni lo storico contatto con le masse che la tradizione politica del Partito comunista aveva sempre tenuto a salvaguardare; fino ai nostri giorni alle speranze affidate PD, e dalle difficoltà da esso incontrate anche a causa delle irrisolte contraddizioni illustrate nel libro, e il cui scadimento ha contribuito ad aprire il campo a populismi di destra e di sinistra. E per questo forse è giusto approfondire l’analisi storica di Ranieri nel momento dell’avvio del governo Draghi, un momento in cui sembrano aprirsi nuovi inesplorati scenari.
Il Mattino, 16 febbraio 2021
* L’autore dell’articolo è coordinatore del Circolo Leg di Napoli