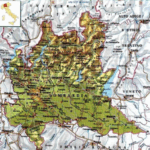Vorrei dire la mia sul nascente governo Draghi. E non perché pensi che la mia voce possa dire molto più di quanto si sta dicendo in questi giorni. Niente affatto. Ma per tre motivi fondamentali, che mi risuonano dentro con forza. Il primo è certamente perché vivo anch’io con preoccupazione un unanimismo che mi suona sempre sospetto e che, a dirla tutta, mi pare sia un sintomo di una crisi profonda del nostro discorso pubblico sulla democrazia.
Il secondo motivo è che vorrei confrontare la mia ipotesi di lettura -certamente radicale e non troppo speranzosa – con quella, del tutto differente, di molti degli intellettuali che stimo e alle cui parole normalmente affido buona parte delle mie consapevolezze politiche di questi tempi precari. Il disaccordo mi spinge a farmi domande e a porre dubbi sulle mie posizioni (del resto coltivare il disaccordo mi pare uno dei tanti compiti pubblici che oggi gli intellettuali ignorano, con buona pace della lezione di Pasolini).
Il terzo motivo è, per così dire, epistemologico: vorrei suggerire che siamo dinanzi a un tempo e a uno scenario in cui il compito di un intellettuale non è di proporre tesi ma di immaginare con rigore delle ipotesi. Ma andiamo con ordine.
Credo che il consenso unanime, quasi una forma di elaborazione collettiva di un trauma, di sollievo generalizzato, debba essere contestualizzato nel lungo termine, non nel breve. Non basta cioè pensare all’adesione prevalente alla formazione di questo governo nei termini puntuali per cui essa sarebbe l’effetto di una causa sotto gli occhi di tutti, lo stato di emergenza pandemica.
Piuttosto la pandemia ha svelato una crisi di legittimazione della politica che in Italia è evidente dal 2011, dal governo Monti. Anche quel governo ebbe un consenso generalizzato, ma le motivazioni erano ben diverse. Lì lo stato di eccezione si chiamava Berlusconi e non era stata un’emergenza puntuale ma la costruzione di un’epoca di linguaggio, costumi e malcondotte.
Monti sembrava agli italiani – anche e soprattutto agli italiani “progressisti” – un male necessario, ma anche un passaggio necessario. Anzi, letteralmente, il gestore di un passaggio da una Repubblica a un’altra, da un’epoca avvelenata dal tarlo berlusconismo a un’epoca finalmente emendata.
Ciò che è successo dopo non è il ripristino di un altro equilibrio. Alla crisi della politica che definiamo berlusconismo è seguita un’altra crisi della politica. È da allora che questo Paese non ha un progetto politico in grado di orientare un governo chiaro e si consegna a esperimenti in vitro, spesso eterodiretti (o almeno condizionati).
Se la crisi di legittimità che nel 2011 poteva essere ricondotta a una causa chiara e distinta, quella di oggi non può essere semplificata. Sono troppe le concause: crisi economica, dialettica tra poteri europei e nazionali (il tema centrale, su cui ritornerò alla fine), l’avvento del populismo, infine la pandemia. Draghi, che non è Monti (il suo spessore, al di là del giudizio che si ha su di lui, è più elevato), giunge al termine di tutto questo e il consenso che lo circonda – anche da parte dei politici – è la presa d’atto di dieci anni in cui la politica italiana non è riuscita a rigenerarsi, ma anzi ha trasversalmente trasmesso ai cittadini frustrazione e impotenza.
Non voglio con ciò negare che la pandemia abbia rappresentato una cesura così netta da segnalare una discontinuità. Voglio dire che il trauma della pandemia non può ridursi alla somma delle incapacità politiche che l’hanno preceduta, ma certamente i suoi effetti sono stati enfatizzati dalle responsabilità politiche precedenti: dalla dismissione del sistema sanitario ai tagli alla scuola, dalla incapacità di avere governi stabili e credibili alla permanenza sull’agone politico di politici letteralmente incredibili.
Al netto della politica come capro espiatorio – cosa quasi inevitabile in questa situazione – le mancanze e le difficoltà strutturali nell’affrontare la pandemia sono state l’amplificazione di ciò che era emerso chiaramente già negli anni precedenti. La pandemia ha semplicemente demistificato ciò che prima l’ideologia dominante tendeva non solo a difendere, ma anzi a coprire.
Oggi i più tenaci difensori della Sanità e dell’Istruzione pubblica sono quelli che hanno chiesto e ottenuto esplicitamente la loro demolizione (e già qui si capisce dove voglio andare a parare: perché abbiamo bisogno del gesto soprannaturale della conversione di coloro che hanno la responsabilità di quanto accaduto e a cui adesso affidiamo la responsabilità di sanare le ferite che loro stessi hanno contribuito a produrre?
Mi ricorda un dialogo con un vecchio barone universitario che, quando gli chiesi perché avrei dovuto sostenerlo, mi rispose più o meno così: “L’Università è in crisi da trent’anni; io sono trent’anni che sto in Università e governo i processi; chi meglio di me, che la conosce così bene, può salvarla?”. Uno strano sillogismo, in effetti.
Tutta questa contestualizzazione ha per me un significato molto semplice. Ci aiuta a non pensare a questo momento come un apax, come uno stato di eccezione che richiede esclusivamente risposte eccezionali. Perché molto semplicemente ciò che il governo dovrebbe fare saranno decisioni normali: ripristinare cioè tutto ciò che è stato indebolito in questi anni.
A nessun governo possiamo chiedere di sconfiggere il virus, da esso dobbiamo attenderci il compito nobile della messa in sicurezza di una società, puntellandone quei punti deboli che c’erano prima e che adesso sono stati con durezza smascherati. Invece a me pare che l’unanimità di Draghi sia in larga parte dovuta a una lettura sincronica del presente, intrisa di misticismo teologico politico.
Come se tutti, in questo momento, avessimo bisogno (e nostalgia) di qualcuno che decida, non di discutere su ciò che si decide. Ecco, io invece penso molto sommessamente che quando qualcuno decide, decide sempre qualcosa. E la democrazia è quella classe che discute così disprezzata da Donoso Cortes (e da noi reazionari ante litteram). Quindi se usciamo dal misticismo teologico politico per cui siamo sollevati di esser passati dal falò delle vanità di Renzi al pragmatismo credibile di Draghi (e come non gioirne?), ci scontriamo con la dura necessità delle cose e del loro accadere: che cosa può decidere colui che finalmente decide?
Ecco la mia ipotesi. Il governo che verrà non è certamente il governo peggiore della storia repubblicana, anzi. Ma è potenzialmente il governo più pericoloso. Che non sia il governo peggiore, non è un compito arduo in effetti. Il che non vuol dire certo che non condivido il sollievo per questa eventualità. Per inciso, ripensavo in questi giorni ai nomi che animavano il governo di Ciampi. Quanto tempo è trascorso e quanto è scaduto il livello dei “competenti”! Il punto però non è questo. È che la questione del governo dei migliori o dei peggiori non attiene in alcun modo alla democrazia.
Niente di peggio del paternalismo per svalorizzarla. Per un motivo sostanziale, non solo formale. Perché la retorica della meritocrazia è essa stessa un regime di verità. Chi decide chi sono i migliori? E soprattutto, i migliori lo sono quanto a che cosa? Non sempre i migliori sono al servizio del bene. Già la retorica dei migliori mi insospettisce, sapendone la natura politico-ideologica a cui essa deve la legittimazione. Se “il migliore” è una segretaria generale di Confindustria che può diventare ministra dello sviluppo economico, cosa posso aspettarmi concretamente (per non parlare dell’Università, dove dopo anni scellerati si continua a riproporre un Rettore come ministro)?
Ecco perché la mia ipotesi di lettura si basa su una previsione culturale. È evidente che Draghi e i suoi ministri non rappresentano una neutralità peraltro impossibile. Dovranno compiere delle scelte politiche. E quali sono le scelte che faranno è la loro storia che lo fa immaginare (al di là della fede in conversioni sovrannaturali). Un governo tecnico è sempre un governo politico, a maggior ragione quando la politica è da anni che appalta ai tecnici le decisioni da prendere.
Ma c’è un elemento in più che mi insospettisce e mi preoccupa, sorprendentemente. Il fatto che questo governo nasca da una sorta di commissariamento dell’inettitudine dei politici italiani da parte degli investitori europei (perdonatemi la genericità della definizione). In fondo, per la prima volta, abbiamo un governo che si troverà a programmare (non a gestire, perché ciò avverrà negli anni) un piano sostanzioso e determinante di investimenti. E dunque potrà permetterci di risparmiarci la scena madre delle lacrime della Fornero.
Questa iniezione di investimenti mette Draghi in una posizione di indubbio vantaggio rispetto ai suoi predecessori e lo immette dentro una traiettoria europea che sembra radicalmente mutata, dall’austerity a un ritorno al keynesismo. Eppure proprio quella che mi pare indubbiamente una buona notizia è ciò che mi fa temere che questo possa essere un governo potenzialmente pericoloso. Perché esso non si limiterà a distruggere, ma le sue scelte saranno strutturali rispetto all’ordine sociale che verrà.
Per fare solo un esempio, non basta rilanciare con forza un piano di investimenti pubblici. Uno dei più grandi keynesiani della storia è stato Ronald Reagan. Ha aumentato esponenzialmente il debito pubblico e ha semplicemente spostato gli investimenti pubblici da settori tradizionalmente attinenti al Welfare a settori in cui il profitto privato era il fine dichiarato (per esempio aumentando a dismisura le spese militari). Draghi non è Reagan e quest’epoca è il tramonto del neoliberismo, non la sua aurora.
Però cosa possiamo attenderci ragionevolmente da Draghi e dalla cultura che rappresenta? Come non temere che la rappresentazione dei consensi potenziali in parlamento dica plasticamente che la crisi della politica è legata al fatto che non c’è più un’alternativa al modello di società neoliberista? A quale solido puntello politico-culturale possiamo attaccarci – al di là del misticismo teologico politico – per credere che l’ordine strutturale della società che questo governo costruirà sarà diverso dal modello dominante, magari con qualche modifica di sostenibilità, termine che la distruzione creativa del capitalismo ha ormai metabolizzato?
Ecco, in realtà vi è un puntello, uno solo ma decisivo. Vengo così all’ultimo motivo per cui scrivo queste righe. Draghi rappresenta alla perfezione le luci e le ombre del progetto europeo e la sua traiettoria così drammatica. È stato protagonista della stagione dell’austerity, che non ha rappresentato semplicemente un’opzione economica ma una scelta di ordine culturale e politica che andava contro il progetto federalista di Spinelli.
Il suo spessore gli ha permesso di non essere identificato non solo con gli scempi dell’austerità, ma anche con la tenace e coraggiosa difesa del progetto europeo tramite la sfida ai mercati nel tempo della crisi (il suo ormai proverbiale «whatever it takes»). Non è un esecutore, un grigio ragioniere dell’austerity (come il suo predecessore Monti). E personalità molto più lucide di me – penso per esempio a Roberta De Monticelli (2) – vedono in questo passaggio un segnale che, sommandosi ad altri segnali, a partire dalla inaspettata novità del Recovery Fund – l’Europa stessa stia emendandosi e cambiando natura, tornando alle idealità e ai principi del federalismo europeo.
Ecco, se tante persone pensano questo, forse può anche essere sia così. Io personalmente non riesco a vedere sufficienti motivi per credere che stia avvenendo questo mutamento epocale, anzi, come ho provato a spiegare sommariamente prima, temo che quello in atto sia una controrivoluzione attiva, se così posso dire. Un modo per approfittare dei problemi che sono scoppiati con la pandemia per definire in termini ancora più stringenti il progetto di una Europa fondata sul neoliberismo come regime di governo alternativo alla democrazia.
E la scelta di Draghi, le scelte che farà, il consenso così ampio che sta ricevendo, mi appaiono come indizi sospetti. Mi inquietano, non mi rassicurano. Però di due cose sono certo. La prima è che è solo su questo che dovremmo concentrarci. Cioè che tutto questo passaggio epocale deve essere ricondotto a ciò che sta accadendo circa il progetto dell’Europa. E il compito degli intellettuali è quello di riportare per quanto possibile la discussione a questo unico argomento, che è davvero ciò su cui si gioca il nostro futuro. Non parlare di ministri, ma di quale Europa Draghi rappresenterà.
La seconda cosa, più modesta, è un suggerimento epistemologico. Forse dobbiamo tutti avere meno fiducia in noi stessi e più pazienza nei confronti dell’ordine della storia. Compito dell’intellettuale applicato alla politica è fare delle ipotesi col rigore dovuto, non formulare delle tesi. Ecco, tengo a dire che le mie sono solo ipotesi. E spero tanto siano sbagliate.
1) L’autore dell’articolo è professore associato di Filosofia Teoretica all’Università di Macerata e fa parte del Consiglio di Presidenza di LeG,
2) L’articolo di Roberta De Monticelli appare sulla homepage di questo sito col titolo “Umiltà, competenze e coraggio: le tre virtù di Draghi per un’Europa rinascente” (ndr).