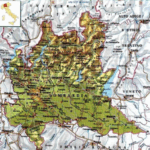Uscito per Cortina nel 2013, dopo La questione morale e la Questione civile, è un tentativo di rispondere alla domanda che cosa sia rinnovamento civile di una società e quale il suo rapporto con il rinnovamento cognitivo e morale degli individui.
Premessa
La questione del rinnovamento
C’è una parola che sale da tante gole, su tante piazze, da tanti anni: rinnovamento.
Rinnovamento, parola lucente e tanto difficile da maneggiare con attenzione: ma rinnovamento di che cosa, e rispetto a che cosa? Tanto ambiguo, tanto indeterminato è il senso di questa parola, quanto urgente è capire che cosa veramente vogliamo.
Però… a ciascuno il suo mestiere. Progetti normativi – progetti di riforma anche radicale dei contenuti e delle forme della nostra democrazia – non mancano sul mercato. Lo sfondo di questa riflessione è anzi la presenza forte e nuova sulla scena italiana di un movimento che predica e tenta di attuare una graduale trasformazione di sistema della vita politica italiana – e, nelle sue ambizioni, globale: da democrazia rappresentativa a democrazia diretta. Ma non è di questo movimento che ci occuperemo, né del suo programma di rinnovamento civile, il quale, a differenza di quanto sostenuto dalla gran parte dei media, esiste ed è facilmente accessibile e chiaro nelle sue linee fondamentali, benché non privo di incoerenze e oscurità nei dettagli e negli sviluppi. Ed è anche del tutto condivisibile, almeno da chiunque riconosca vincoli etici alla politica, in alcuni suoi nuclei centrali: dalla ricostruzione e difesa della legalità alla moralizzazione delle istituzioni – in particolare quelle della politica, dell’amministrazione, dell’economia, delle professioni – alla difesa dell’ambiente e del patrimonio culturale alla promozione di strumenti di informazione indipendente, di trasparenza, di controllo della cittadinanza sull’esercizio legittimo del potere.1
Sono cose assai buone, queste: potremmo chiamarle “i contenuti della speranza civile”. Ma non è su di essi che si appunta in questo saggio la nostra attenzione: per fortuna, sono già oggetto del dibattito pubblico, nonostante un desolante panorama dell’informazione, che, secondo quotazioni recenti, situa il nostro Paese, per quanto riguarda la libertà o piuttosto l’indipendenza della stampa e dei media, al settantaquattresimo posto nella classifica mondiale, fra Macedonia e Panama.
C’è un aspetto, però, della novità rappresentata da questo movimento che ci servirà da punto di partenza. Il talento di comici di ogni sorta, grandi e piccoli, ha segnato la cultura popolare italiana degli ultimi trent’anni. Ma che cos’è cultura? Vorrei riproporre qui una definizione di Nicola Chiaromonte, che di comico se ne intendeva, essendo stato un grande critico teatrale. Fu anche filosofo, benché sui generis – oltre che l’ispiratore, durante gli anni dell’esilio, di alcune delle menti più vivide dell’intelligencija europea e americana.
E da filosofo Chiaromonte definisce la cultura, in base alla sua “ragion d’essere”: che sarebbe “la verità vissuta e partecipata”. E si spiega:
La cultura, infatti, non è il terreno della verità, ma della disputa intorno alla verità.2
Il paese della videocrazia non ne ha viste molte, negli ultimi trent’anni, di dispute di questo genere. Eppure ciascuno di noi ha “vissuto e partecipato” pensieri – convinzioni di valore, opinioni di fatto – la cui verità, la credesse o no certa, sentiva stargli molto “a cuore”, e tanto più quanto più vivo gli si risvegliava dentro – di fronte alla piena maleodorante dell’impunità, della corruzione e della malversazione, della distruzione di beni e di talenti, della rapina di futuro e di speranza – il desiderio di un po’ più di giustizia. Ma quante volte un moto spontaneo, un’azione, una domanda sono ricadute nel nulla di una rassegnazione all’impotenza! Ciascuno, forse, ha rivissuto una delle semplici verità che più profondamente avevano colpito Lev Tolstoj: “la grave dipendenza in cui ci troviamo gli uni rispetto agli altri” – dipendenza che diventa per ciascuno una sorta di destino cieco, come un fatto di natura, una malattia o un terremoto. È ancora Nicola Chiaromonte a farcelo notare. Questa semplice verità rispecchia quella dell’antica formula di Socrate: L’individuo non può essere giusto in una società ingiusta, la società non può essere giusta se gli individui non sono giusti.3
1. R. Caracci, Il ruggito del Grillo. Cronaca semiseria del comico tribuno, Moretti e Vitali, Bergamo 2013. È in realtà molto più di una “cronaca” dell’avventura di Beppe Grillo dai suoi esordi televisivi nel 1977 all’alba delle elezioni del febbraio 2013, che hanno consegnato al Movimento 5 Stelle il voto di un quarto degli italiani. È una riflessione da critico, semiologo, filosofo e storico su una storia che è inscindibilmente di passione civile e di teatralità non avvezza al regime della discussione. Contiene tutto intero il paradosso “fra comicità e verità, fra scena e fuori scena, spettacolo e antispettacolo, cabaret e comizio” (ibidem, p. 73). E contiene in Appendice il Programma del Movimento 5 Stelle.
2. N. Chiaromonte, “La situazione di massa e i valori nobili”, in V. Giacopini (a cura di), Il tempo della malafede e altri scritti, Edizioni dell’asino, Roma 2013, p. 50. Al curatore di questa meritoria riedizione di scritti di Chiaromonte (1905-1972) rimprovereremmo soltanto di non aver riportato le date della loro pubblicazione originaria.
L’oggetto di questo studio è ancora una volta il passaggio dall’uno all’altro segmento di questo circolo vizioso o virtuoso a seconda di come riusciamo o non riusciamo a farlo girare.4 A ognuno il suo mestiere, dicevamo.
La prospettiva filosofica altro non è che la prospettiva di prima persona, cioè lo studio critico e riflessivo del mondo della vita quotidiana, delle sue invarianti e delle sue indefinite possibilità di approfondimento cognitivo, non nella prospettiva delle scienze naturali o sociali (“di terza persona”), ma come appare a chiunque si trovi a vivere “nel terreno della cultura”, cioè “delle dispute intorno alla verità”. E non c’è altro modo di “viverlo” e “parteciparlo” se non “in prima persona”, appunto. La filosofia ci aiuta a diventare più consapevoli e critici nei confronti della nostra esperienza.
Da questo punto di vista, la nostra questione diventa quella dei nessi fra rinnovamento civile di una società e rinnovamento morale di ciascuno. Fra la “speranza civile” cui abbiamo accennato all’inizio e la speranza che ci tiene in vita come persone – o che ci manca, invece, e ci fa mancare di vita.
Ed ecco ciò che da questa prospettiva si vede. L’aspirazione sincera che ha dato vita a tanti movimenti di società civile sale dal profondo di uno stato d’animo nel quale molti di noi si trovano da troppo tempo. Se un soffio di vento lo increspa e ci fa sentire possibile liberarci da questo stato, ancora più pesante sentiamo il timore che possa richiudersi definitivamente su di noi, come pietra tombale. È uno stato d’animo in cui non è tanto che si disperi del proprio personale valore, piuttosto si dubita che possa avere più valore
l’esistenza di nessuno. È una forma sorda, che in molti oscilla fra la rassegnazione e un’aspirazione attiva a un po’ più di giustizia, che spesso non riesce a trovare una via convincente al pensiero pratico e all’azione comune. Ma che cosa c’entra questo stato d’animo con la giustizia? Ce lo spiega Kant, in una frase famosa che non si finirebbe mai di commentare:
Se la giustizia scompare, non ha più valore la vita degli uomini sulla terra.
Non si finirebbe di commentarla perché ci rivela una dimensione di ciò che è dovuto agli esseri umani (la giustizia) eccedente la sfera dei bisogni come comunemente intesi: la sfera certamente basilare che chiamiamo dei diritti sociali. Ci sono bisogni, per così dire, “dell’anima”, e c’entrano con la giustizia. Abbiamo bisogno di sentire che le nostre vite, e soprattutto quelle dei nostri figli, valgano la pena che costano, cioè abbiano senso. L’ingiustizia è il male principale della vita associata. Alcuni suoi aspetti oggi particolarmente visibili, connessi con la lenta erosione della differenza fra uno Stato e una banda di briganti (rubo l’espressione a Agostino di Ippona), tolgono alle nostre vite non tanto il sostegno materiale, quanto il respiro e il senso.
Come appare, a chi la vive, una vita senza valore?
Guardatevi intorno o dentro. È uno stato depressivo, uno stato di assenza di speranza che, per andare un poco oltre la semplice psicologia, si può descrivere come una forma di atrofia della nostra mente nella parte essenziale della sua vita, la sensibilità ai fatti di valore (con la sua ricca, diramata, esatta cognizione del dolore, con la sua incerta trama di esigenze assolute e di congetturali speranze). Finché di questa atrofia, e quindi relativa analgesia, si soffre ancora, si aspira al rinnovamento, e in particolare si risponde da cittadini attivi, si tiene in vita per quanto possibile la democrazia. Quando non se ne soffre più, si è già destituito in sé il soggetto morale, e tanto più il cittadino. La sentinella si è addormentata, la democrazia è pronta a diventare qualcos’altro.
Certo, ogni vita personale, nella sua dimensione privata, ha sempre e dovunque in riserva enormi fatti di valore e disvalore; fatti, comunque, che, nella maggior parte dei casi, impegnano la sensibilità di ciascuno, sottraendola a quella sorta di stato depressivo, simile ad assenza di speranza (molto più che a “disperazione”) che per molto tempo, col suo color di topo, o di piombo, ha tinto l’atmosfera della nostra vita associata e comune, al di sotto del teatrino mediatico e delle grida degli imbonitori. Ma ammettiamolo: proprio oggi che qualche brivido, qualche soffio come di primavera ha potuto sfiorare questa superficie color di topo, ci rendiamo conto di quanto pesi la quotidianità della non-speranza anche sulle singole vite, nostre e dei nostri figli.
3. Citato da N. Chiaromonte, “Che cosa rimane?”, in V. Giacopini (a cura di), Il tempo della malafede e altri scritti, cit., p. 136.
4. Come nei due testi, La questione morale e La questione civile (entrambi pubblicati da Raffaello Cortina, Milano, rispettivamente nel 2010 e nel 2011), di cui questo vorrebbe essere una sorta di postilla conclusiva.
Non è sorprendente. Stiamo lasciando andare tutto quello che apparteneva a tutti. Siamo già in una condizione di quasi-rassegnazione rispetto al nostro destino comune, quello che riguarda la nostra vita associata e la nostra civiltà: lingua, cultura, patrimonio di bellezza, arte e natura, paesaggio e memoria. Non è una rassegnazione matura, però. È fatta essenzialmente di rimozione – lo sguardo si distoglie per evitare una sofferenza inutile, priva di sbocco – e finisce per divenire cieco. Non ci vediamo più. Presi dal nostro stesso star male, non vediamo più come stanno male le cose. Allora il mondo si appiattisce nell’indifferenza, diventa letteralmente wertfrei, privo di valore. Niente rileva, tutto annoia o disgusta, “sono tutti uguali”. È il mondo della banalità. Da cui non si genera altra banalità ma, come la storia del secolo
passato ci insegna, altro e più terribile male.
Cercheremo in questo saggio, direttamente, di dirimere l’ambiguità di uno stato così, sospeso fra il tentativo di reagire all’oppressione e l’indifferenza: le sue grandi potenzialità e i suoi grandi pericoli. Così facendo, indirettamente ci troveremo a riflettere anche sul nostro presente – che è in realtà il più difficile degli oggetti di riflessione, forse soprattutto per il filosofo, che si dice assomigli alla nottola e giunga sempre sul far della sera. Indirettamente ci ritroveremo fra le mani alcuni aspetti della questione di un’iniezione di democrazia diretta nel nostro sistema politico,5 per chi volesse approfondirla con gli strumenti molto più specifici che mancano alla filosofia. Lo faremo attraverso l’analisi di alcuni fenomeni che a quella condizione depressiva sono connessi: la banalizzazione del mondo e la completa dissociazione della politica dall’etica, e perfino dalla logica. Fenomeni che proveremo a illustrare anche attraverso ciò che le tragedie europee del secolo passato ci hanno insegnato sul male che minaccia sempre la nostra vita associata – o su uno dei suoi aspetti.
Il vero male non è il male, ma la mescolanza del bene e del male. Ogni rinnovamento morale aspira in primo luogo a distinguere l’uno dall’altro, per difficile che sia, anche in se stessi. Non ha molla più profonda che il disgusto dell’ambiguità, per quanto radicata essa sia nella condizione umana. Questa spinta catara c’è, in ogni movimento che voglia rinnovarci. Sulla soglia di questo saggio vogliamo chiarire che non è contro, ma per la speranza il nostro tentativo di dirimere l’ambiguità possibile – anche in chi di rinnovamento si fa portatore.