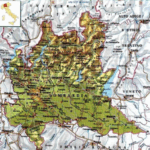E’ vicenda lontana, ma è giusto ricordare quanto forte e vittoriosa – ma anche quanto carica di lutti – fu nei primi giorni del luglio 1960 la rivolta della coscienza antifascista del Paese contro il governo del democristiano Fernando Tambroni. Con l’avallo del presidente della Repubblica Giovanni Gronchi e il sostegno “spirituale” del cardinale di Genova Giuseppe Siri e dello scomparso don Gianni Baget Bozzo (altro genovese poi spretato, quindi riammesso; prima dc, poi socialista e infine ispiratore di Berlusconi) costui aveva creato, sulle ceneri di un ministero centrista, un governo monocolore sostenuto dai soli e determinanti voti dei neofascisti e dei monarchici. Le proteste nel Paese erano cominciate subito, sino ad esplodere a giugno quando l’Msi era passato all’incasso decidendo di tenere proprio a Genova il suo congresso nazionale: un oltraggio alla città medaglia d’oro della Resistenza dove (vicenda tanto più emblematica oggi che si tende a svilir tanto la lotta di Liberazione) le truppe naziste del generale Gunther Meinhold si erano arrese non agli alleati ma ai partigiani: l’atto di resa porta la firma di un operaio comunista, Remo Scappini, comandante del Corpo volontari della libertà della Liguria.
Per denunciare quel congresso-oltraggio, la tre confederazioni sindacali promuovono uno sciopero generale che paralizza la città. Altri scioperi nascono ovunque per l’Italia realizzando una quasi spontanea saldatura tra la rivolta antifascista e le rivendicazioni economiche di molte categorie.
Tambroni decide di usare le maniere forti: antica e sempre nuova scuola di Scelba, anzi peggio. Polizia e carabinieri hanno l’ordine di reprimere con ogni mezzo ogni focolaio di protesta. E le proteste sono tante e ovunque, rivelando le eccezionali dimensioni del malessere che serpeggia soprattutto tra i giovani – le “magliette a strisce” – diventati subito il simbolo delle lotte di un terribile, tragico luglio.
Il 2, sull’onda dello sciopero genovese, la prima vittoria: il congresso dell’Msi viene annullato. Ma rabbiosa sarà la reazione del governo così clamorosamente sconfitto. Ogni pretesto è buono. A San Ferdinando di Puglia i braccianti erano in sciopero per il contratto, come in tutt’Italia? La polizia li attacca con le armi in pugno: tre braccianti sono gravemente feriti. A Licata, nell’Agrigentino, il 5, è in corso uno sciopero generale per il lavoro? Polizia e carabinieri caricano e sparano contro il corteo guidato dal sindaco dc Castelli: il commerciante Vincenzo Napoli, venticinque anni, viene ucciso da un colpo di moschetto. Intanto Tambroni sta manovrando per sopravvivere: ogni manifestazione gli appare come una sfida, un oltraggio personale. Tant’è che a Roma, il giorno appresso, un corteo diretto al sacrario di Porta San Paolo – l’ultimo bastione della difesa di Roma dai nazisti – viene caricato e pestato con violenza. Sono usate persino le truppe a cavallo comandate dai pluriolimpionici Raimondo e Piero D’Inzeo. Tra i feriti Pietro Ingrao, colpito alla testa.
Scatta un nuovo sciopero generale. E scatta una nuova, furiosa reazione del governo che ordina di sparare a vista: cinque morti e ventidue feriti da armi da fuoco a Reggio Emilia il 7. Qualcuno ricorderà il canto dedicato da Fausto Amodei ai caduti, i “morti di Reggio Emilia”. Il primo a cadere è Lauro Ferioli, operaio di ventidue anni. Accanto a lui, cade un istante dopo anche Mario Serri, quarant’anni, ex partigiano: ad ucciderli sono stati due agenti, appostati tra gli alberi. Morirà invece all’ospedale Ovidio Franchi, operaio di diciannove anni, colpito all’addome da una pistolettata. Una raffica di mitra falcerà più tardi Emilio Reverberi, trent’anni anni. Infine, mentre un registratore fissa la voce furiosa di un commissario che grida: “Sparate nel mucchio!”, cade Afro Tondelli, trentacinque anni. Come documenterà una foto, è stato assassinato freddamente da un poliziotto che si è inginocchiato per prendere meglio la mira.
In risposta all’eccidio di Reggio l’indomani è in atto un nuovo sciopero generale nel Paese. E stavolta esplode la rabbia di Catania e di Palermo. Nella città etnea i carabinieri ammazzano un giovane edile, Salvatore Novembre, diciassette anni: prima è massacrato a colpi di calcio di moschetto e poi, quando ormai è riverso esanime sul ciglio di un marciapiede, viene finito con due colpi di quello stesso fucile. A Palermo il bilancio sarà più tragico: quattro morti e cinquantuno feriti gravi. Ma accadrà che non per qualche giorno ma per anni ci si dimenticherà (nei rapporti di polizia, nelle controrelazioni, persino nei molti libri sugli accadimenti del Luglio ’60) di una delle vittime, e per un impressionante particolare.
Tutto si consuma in poche ore, la mattina di quel venerdì 8. Una folla immensa che si era radunata, alla confluenza di due cortei, tra piazza Politeama e piazza Massimo è praticamente imbottigliata da truppe armate e decise a tutto, persino a lanciarsi con la baionetta inastata contro Pompeo Colajanni, il popolare comandante partigiano Barbato, nel tentativo di ucciderlo.
La rabbia esplode. Ma da un lato ci sono le mani e le aste dei cartelli, dall’altro lato i moschetti, i mitra, le pistole. Inerme e indifeso è il primo a cadere ucciso, Francesco Vella, quarantadue anni, operaio edile, gran diffusore dell’Unità. Poi è la volta di Andrea Gangitano, quattordici anni, venditore ambulante di mazzetti di gelsomino. Quindi – a testimonianza dell’ordine di sparare dovunque e comunque – Rosa La Barbera, cinquantatre anni, è uccisa da una pistolettata calibro 9 in pieno petto mentre al terzo piano sta chiudendo le imposte di una finestra di casa. Ma all’elenco delle vittime manca (mancò a lungo) un nome, quello di Giuseppe Malleo, sedici anni, apprendista edile, militante della gioventù comunista. Era uno dei feriti gravi, raggiunto da un colpo di moschetto alla nuca sparato contro un grappolo umano inerme e indifeso che volgeva le spalle alle truppe che sparavano piombo e bombe lacrimogene. Pino fu dimenticato. Morì il 29 dicembre, cioè dopo sei lunghi mesi di sofferenze atroci: operato più volte andò in agonia sotto le feste. Non si tratta di rivendicare “una vittima in più”.
In Sicilia i moti libertari e le lotte per il lavoro e la democrazia hanno una lunga storia di splendide imprese e di tragici sacrifici con un pesante bilancio di sangue in cui vanno annoverati anche più di cinquanta tra capilega, capipopolo, dirigenti sindacali e semplici lavoratori uccisi dalla mafia in questo dopoguerra. E pure Pino Malleo fa parte di questa lunga storia, di questo tragico elenco.
Torniamo a Tambroni. La situazione per lui diventa a questo punto insostenibile. Tre ministri della sinistra dc – Giulio Pastore, Giorgio Bo e Fiorentino Sullo – si dimettono polemicamente, non solo per il peso politico ricattatorio dei fascisti ma anche e proprio per l’uso sconsiderato che viene fatto delle forze di polizia. Saranno giorni di sotterranee manovre (su cui non è stata ancora fatta piena luce). Di disperati, ostinati tentativi del presidente del Consiglio di fronteggiare a ogni costo la crisi. Ma alla fine, il 19 luglio, Tambroni è costretto a mollare. Con la sue dimissioni si apre la strada prima ad un governo di Amintore Fanfani, poi ad un governo “balneare” di Giovanni Leone che preparerà la strada al primo governo di Aldo Moro con la partecipazione del Psi. Titolo dell’Avanti!: “Ciascuno da oggi è più libero”. Troppa enfasi.