Dal caso di Milano dovrebbe partire una verifica delle scelte politiche fatte trent’anni fa, quando, da Milano, prese avvio il processo di disequilibrio dei poteri e delle forze che avevano retto la Repubblica.
Il 1993 fu un anno cruciale. La sera del 30 aprile, Bettino Craxi venne fatto oggetto di una pioggia di monetine mentre stava uscendo dall’Hotel Raphaël; un anno prima, a Milano, erano iniziate le indagini su quel che poi sarebbe diventata Tangentopoli; nel marzo del 1993 venne approvata la legge sull’elezione diretta dei sindaci che toglieva ai partiti la primazia e faceva del sindaco una specie di amministratore delegato che nominava e destituiva i suoi assessori (che non potevano essere consiglieri) mentre il consiglio perdeva potere. Questi eventi erano intrecciati; l’ultimo fu una risposta alla partitocrazia che, oggi, meriterebbe una riflessione critica.
Ad attendere Craxi fuori dall’albergo non c’erano solo i contestatori, ma anche le telecamere. Da allora, la politica nazionale ha visto una crescente spettacolarizzazione con i media protagonisti nell’indirizzare i politici più che nel controllare. Era nata quella che Bernard Manin ha chiamato “democrazia del pubblico”, dove il pubblico, in questo caso, non significa la trasparenza e il “rendere pubblico” ciò che i politici fanno, ma fare audience. La funzione di spettacolarizzazione dei media è cresciuta parallelamente al declino dei partiti e al successo del personalismo nelle istituzioni. Le notizie che dal 1992-93 aprivano i telegiornali furono per mesi le stesse: le aule giudiziarie, i politici sul banco degli imputati, le requisitorie, le arringhe, i verdetti. Il malcostume nazionale di lasciar entrare le telecamere nelle aule di tribunale ha reso la corruzione un intrattenimento, forgiando una mentalità che da allora non ci ha più lasciato e alla base della quale vi è il gemellaggio di populismo giustizialista e di antipolitica. Due fenomeni speculari, esaltati da una pubblicistica che ha fatto fortuna identificando i partiti con la casta e poi da movimenti d’opinione che hanno a loro volta indebolito le istituzioni deliberative e di controllo.
Lo scopo, fallito, doveva essere rendere l’amministrazione più snella, togliere di mezzo poltrone e partiti, abbattere la burocrazia. Si fece invece strada una mentalità bifronte: da un lato, l’idea della politicità della magistratura, e dall’altro l’idea che chi governa debba liberarsi da lacci e laccioli, anche per contenere il potere dei giudici. La legge Salva-Milano, proposta e non approvata dal Parlamento lo scorso anno, rientrava in questa logica. È invece passata la legge che ha abolito il reato di abuso d’ufficio e quella che ha aumentato i reati di opinione e di contestazione – più potere discrezionale a chi esercita il potere, meno potere di controllo orizzontale, cioè ai cittadini.
Le due facce del giustizialismo sono oggi la materia della politica. Per i populisti, la giustizia dovrebbe funzionare come la vendetta contro la politica, per i loro alter, la corruzione è l’illecito, tutto il resto sono chiacchiere moralistiche. Per nessuno dei due ha senso parlare di corruzione politica, nel primo caso perché la politica stessa è corruzione e nel secondo perché non esiste la corruzione politica.
Questa distorsione doppia è forse uno dei danni più duri a morire lasciati dal terremoto di Mani Pulite. La corruzione politica non è semplicisticamente criminalità.
La corruzione politica è spesso associata a casi di abuso di potere che si sviluppano all’interno di istituzioni disfunzionali. Disfunzionali, perché le regole sono state scritte con noncuranza delle possibili ricadute negative, sia perché agevolano comportamenti individuali scorretti, sia perché non agevolano la trasparenza come dovrebbero. Come hanno mostrato Emanuela Ceva e Maria Paola Ferretti, i casi individuali e istituzionali di corruzione politica hanno una radice comune che possiamo comprendere solo se consideriamo la corruzione e l’anticorruzione come una questione di etica della funzione pubblica.
La corruzione politica può essere contrastata mobilitando i titolari di cariche pubbliche affinché rimangano responsabili e rispondenti del proprio comportamento, non solo alla legge ma anche, e anzi prima di tutto, ai loro committenti che sono i cittadini. Anche per questo, la logica della criminalizzazione o delle mele marce è insoddisfacente.
Il fatto è che la personalizzazione del ruolo del sindaco e partiti che sono ormai solo associazioni di eletti, hanno indebolito la capacità della politica democratica di indurre l’etica pubblica con la forza dell’accountability. Forse è tempo di ripensare il sistema di governo delle città per mettere al centro la sua funzione pubblica.



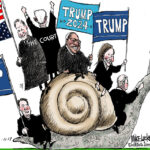












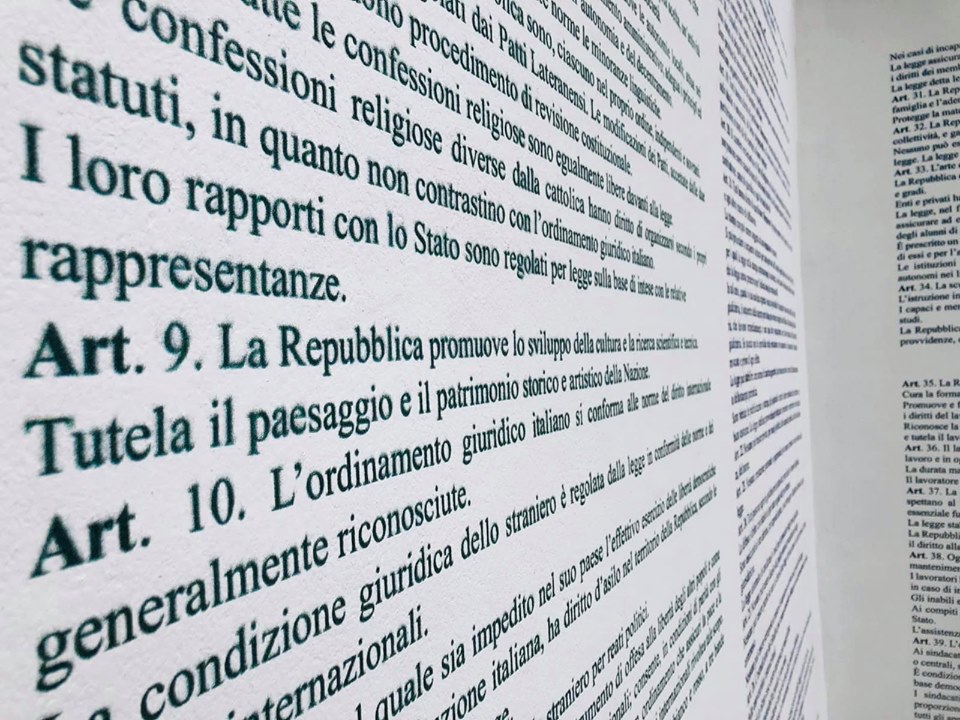
 Francesco Pallante
Francesco Pallante

