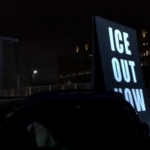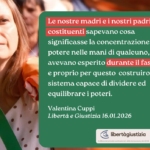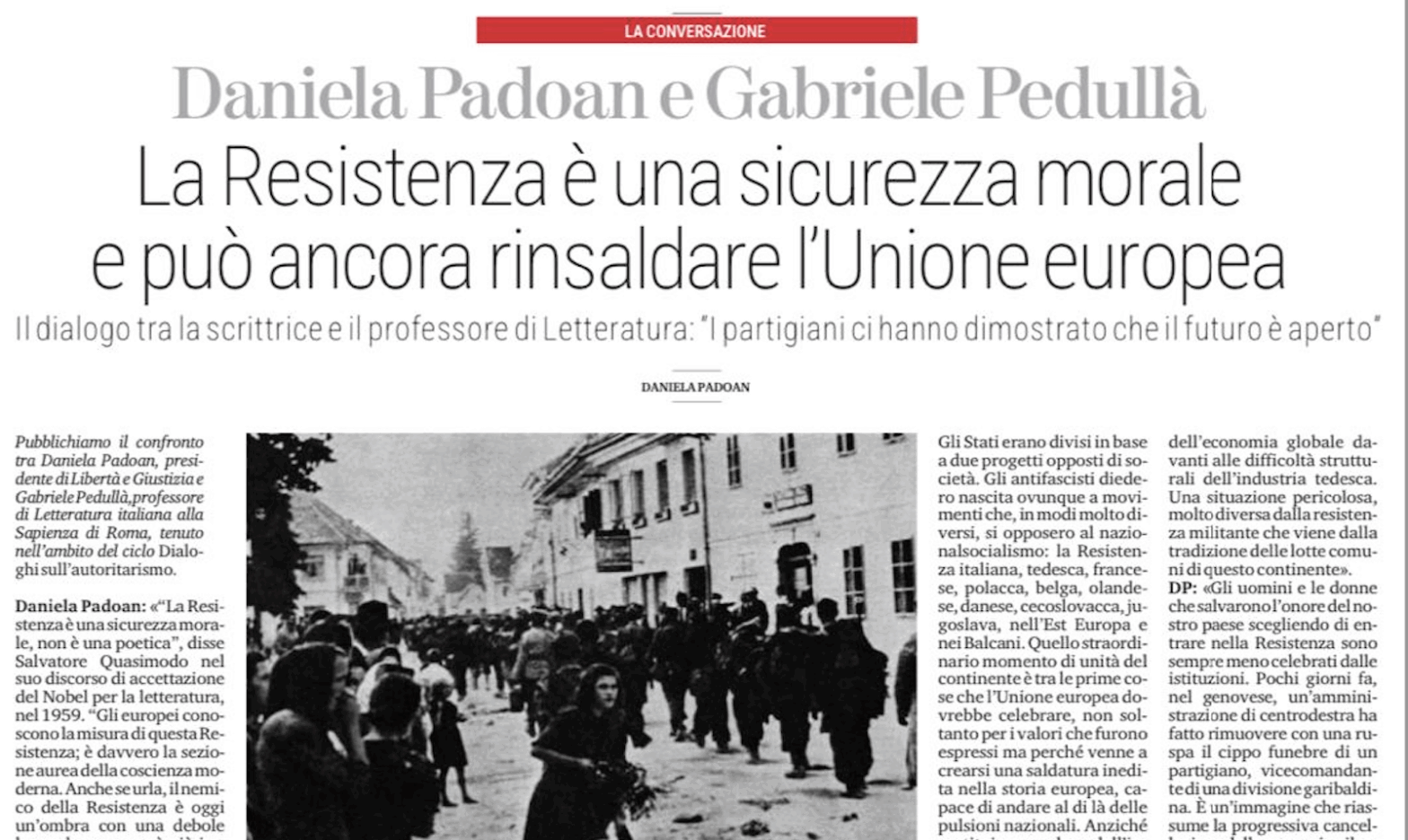Daniela Padoan: «L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento», recita l’articolo 33 della Costituzione, in cui è chiara la volontà dei costituenti, che non avevano dimenticato l’adesione in massa dei docenti universitari al fascismo, nel 1931, né la solerzia con cui i rettori avevano accolto, nel 1938, l’invito del ministero dell’Educazione a creare cattedre intese ad alimentare negli studenti una più salda “coscienza razziale”. L’università, nella sua funzione di semina di pensiero critico, è essenziale per la tenuta democratica di un paese. Per questo allarma vedere che sempre più gli atenei sembrano rispondere a logiche aziendali, dando spazio a una nuova declinazione di quel Tradimento dei chierici in cui Julien Benda – il filosofo francese che durante il regime di Vichy visse in clandestinità – vide, nel 1927, il declino dell’intellettuale e il suo asservimento al potere.
Anna Simone: È un “tradimento” che risale ai grandi mutamenti avvenuti tra la fine degli anni Ottanta e Novanta, con il passaggio dal neoliberismo alla neoliberalizzazione. Il progetto neoliberista voluto dai “Chicago Boys” non è mai approdato alla cultura anarco-capitalista e libertaria propugnata da Von Hayeck e Von Mises, fondata sul mercato e sull’individuo. Il disegno originario di eliminare il ruolo dello Stato e depotenziare il diritto pubblico, visto come limitazione del potere dei mercati, è stato presto soppiantato da un processo di neoliberalizzazione, che ha comportato una mercatizzazione dello Stato e delle sue istituzioni, e non certo la sua eliminazione. L’università ne è stata investita in pieno, venendo gradualmente aziendalizzata attraverso una serie di riforme, sino a quella, definitiva, dell’ex ministra Mariastella Gelmini.
DP: Sono passati quindici anni da quella riforma che, durante il quarto governo Berlusconi, impose la parola “meritocrazia” e un controllo tecnico-finanziario sulla didattica e sulla ricerca. In che modo, secondo lei, l’università è stata piegata alle logiche del mercato?
AS: Le università pubbliche hanno dovuto interiorizzare gli stessi principi delle imprese: concorrenza, iper-burocratizzazione, finanziamenti esterni per sostenere la ricerca, public management, precarietà come norma per i ricercatori, principio di efficienza e di performance, rendicontazione e valutazione permanente della ricerca, internazionalizzazione, mito dell’eccellenza… Tutto questo va nella direzione di una misurazione quantitativa e standardizzata che nulla ha a che fare con la libertà di ricerca e l’autonomia politica dei singoli atenei e dei singoli docenti, nell’esercizio della loro libertà di insegnamento. Oggi un saggio scritto da un accademico viene definito “prodotto della ricerca”, noi docenti siamo diventati “capitale umano” e il classico lavoro intellettuale svolto fuori dalle università viene nominato come “terza missione” o “public engagement”. La neoliberalizzazione ha inventato una neolingua accademica fatta di acronimi e determinata dai dispositivi del mercato.
DP: In buona parte del mondo assistiamo a una guerra culturale scatenata dalle destre contro le università e i principi di libertà accademica. Quel che avviene negli Stati Uniti, con la proibizione dell’applicazione dei principi di diversità, equità e inclusione, con il blocco dei fondi federali per la ricerca e con la revoca del visto a studenti, ricercatori e docenti, apre le porte alla prospettiva che anche in Italia si proceda con più forza a marginalizzare e gettare discredito sugli intellettuali e sulla cultura tout court.
AS: Trump vede le università come roccaforti della cultura “woke” e dei valori liberali – non diversamente da Viktor Orbán in Ungheria, Recep Tayyip Erdogan in Turchia, Javier Milei in Argentina – perché l’ideologia della libertà dei mercati si è trasformata in un approccio conservatore, disciplinante e autoritario nei confronti del dissenso dei cittadini, degli studenti e dei docenti. In Italia già viviamo in un clima di cupezza, ingerenza politica nell’autonomia accademica e intimidazione. Abbiamo una buona casistica di colleghi puniti con provvedimenti disciplinari per il solo fatto di aver espresso il proprio pensiero, e di colleghi che non superano le abilitazioni scientifiche perché i loro lavori di ricerca vengono aprioristicamente etichettati come “ideologici” o “troppo critici”. Le università riproducono le dinamiche competitive tipiche della società prestazionale e meritocratica: una misurazione continua in cui tutti soffrono, ma al contempo tutti tacciono, perché temono l’emarginazione, se non addirittura la censura.
DP: Forse per questo molti docenti sono sempre più presenti nei talk show televisivi e si rivolgono ai social cercando un varco di comunicazione. Anche se l’impressione è che questo contribuisca a un’ulteriore esautorazione dei saperi.
AS: Ci chiamano “professoroni”, accademici chiusi nella “torre d’avorio”, ed è vero che le università sono spesso un sistema chiuso su sé stesso, incapace di mettere a valore le conoscenze, ma quando proviamo a uscire dall’accademia per confrontarci e trasmettere a pubblici più vasti i nostri saperi – e questo non può che avvenire tramite il web – scopriamo che non è facile attraversare i social senza tradire il nostro spirito critico. Si tratta di un fenomeno insidioso che genera un processo di disattenzione e deculturazione permanente, fatto di semplificazioni che vanno a inscriversi nei processi di depoliticizzazione di massa, con i risultati che abbiamo sotto gli occhi ogni giorno. Oggi la cultura si trasmette essenzialmente tramite “eventi”, festival e kermesse; a parlare non sono più gli intellettuali ma gli opinionisti, e nel marasma dei talk show e degli incontri che cominciano e finiscono nello stesso giorno senza depositare niente, per i cittadini è sempre più difficile formarsi un’opinione. Cosa resta, oltre a “postare” compulsivamente sui social quanto detto da questo o quell’influencer o guru? Di qui al qualunquismo il passo è assai breve.
DP: Cosa si potrebbe fare, di diverso?
AS: Difendere i saperi critici, che dovrebbero essere stratificati, qualificati, frutto di ricerche approfondite. Noi accademici abbiamo molte responsabilità rispetto a questa degenerazione collettiva, ma molta responsabilità la condividono tutti coloro che lavorano nel giornalismo, nell’informazione e nella comunicazione. Da questo punto di vista, aprire le università alla cittadinanza, come vuol fare l’Osservatorio Autoritarismo, è un modo per tornare al libero insegnamento, come chiede la Costituzione.
Osservatorio Autoritarismo
Il luogo dove agire insieme per comprendere e fermare il processo di svuotamento della democrazia costituzionale e il progressivo attacco alla libertà di espressione e manifestazione.
Sostieni il progettoL’Osservatorio Autoritarismo nasce per iniziativa dell’associazione di cultura politica Libertà e Giustizia e della casa editrice Castelvecchi con l’impegno condiviso da più di duecento docenti e studiosi italiani e stranieri di progettare incontri e seminari sull’autoritarismo aperti alla cittadinanza nelle principali università italiane.
Tra i primi firmatari Alessandro Barbero, Judith Butler, Nancy Fraser, James Galbraith, Luigi Manconi, Vito Mancuso, Michela Marzano, Giorgio Parisi, Gustavo Zagrebelsky.
Per informazioni e adesioni stai sul nostro sito e vai alla sezione dell’Osservatorio Autoritarismo
Per sostenere l’Osservatorio Autoritarismo clicca qui