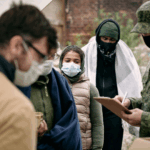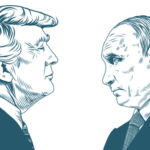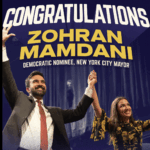Dal caso Moro ai Georgofili cercando un filo tra troppi segreti. In tempi di pandemia l’importanza della memoria, del ricordo di servitori dello Stato come Vigna e gli altri magistrati fiorentini che indagarono su terroristi rossi e neri e sulle stragi volute da Cosa Nostra
Tornata in redazione a Roma dopo le terribili giornate di Firenze, Scalfari mi disse: «Sai che mi hai fatto piangere con il tuo articolo sulla bambina dei Georgofili?». Ricordo l’imbarazzo in quel momento. Il direttore non era solito esibire i suoi sentimenti e aveva una maschera di uomo forte che lo proteggeva dai casi della vita. Si era commosso per quell’articolo sulla poesia Il tramonto, che Nadia Nencioni aveva scritto tre giorni prima di esser dilaniata dall’esplosione dei Georgofili. Per molti anni della mia vita, maggio è stato un mese duro, con gli anniversari da celebrare, la memoria da tener sempre viva. Cominciava il 9 col ricordo dell’ uccisione di Aldo Moro, nel 1978: la Renault rossa a via Caetani, e le cronache difficilissime, amare, 55 giorni di giornalismo investigativo (si direbbe oggi) sempre pieno di ombre, rischi, minacce, trappole, piste che svanivano nel nulla.
E poi il 23 maggio del ’92, con il ricordo della strage di Capaci e l’uccisione di Giovanni Falcone col quale avevo parlato pochi giorni prima a Roma. Del suo argomento preferito: la P2. E infine, il 27 maggio del ’93, la strage a Firenze.
Ma oggi che siamo impegnati nella fatica di decifrare il senso di quella vita che avevamo prima della pandemia, questi anniversari hanno ancora posto nella nostra storia privata e in quella più grande del nostro Paese? E quanto è grande lo spazio che siamo disposti a ridiscutere, mettendo alla prova la realtà di quello che accadde allora?
Per un tempo molto lungo il volto della giustizia a Firenze e non solo è stato quello del sorriso drammaticamente ironico (non riesco a definirlo altrimenti) di Piero Luigi Vigna. Negli anni ero venuta spesso a trovarlo da Roma, insieme a Maurizio De Luca, vicedirettore dell’Espresso, bravissimo giornalista fiorentino e suo vecchio amico. Firenze per Vigna non aveva segreti che non avesse cercato di aggredire. Sul sequestro di Aldo Moro, ad esempio, era convinto che in quei 55 giorni la direzione strategica delle Brigate Rosse si riunisse a Firenze. Ma dove?
«Noi sapevamo che il Comitato rivoluzionario toscano delle Brigate Rosse disponeva a Firenze di ben tre appartamenti: in viale dell’Unione Sovietica, a Firenze Nova e in via Pisana e la storia di questi tre covi e del loro utilizzo, soprattutto durante il sequestro Moro, non è mai stata del tutto chiarita »: cito dalla lunga e molto nota intervista che Giorgio Sturlese Tosi fece a Vigna nel 2011 (un anno prima della sua morte).
Vigna non aveva rinunciato a indagare i silenzi e i depistaggi del mondo politico. Tutti ricordiamo la celebre seduta spiritica con l’indicazione di Gradoli come luogo della prigionia di Moro, alla quale si diceva avesse partecipato anche Romano Prodi. « È evidente » diceva invece Vigna « che quella seduta spiritica non ci fu mai e che i politici che erano al corrente di quell’informazione volevano soltanto coprire la loro fonte; senza quel ritardo, chissà, forse Aldo Moro avrebbe potuto esser liberato ».
Ma il vero successo di Vigna e della magistratura fiorentina, a mio avviso, fu proprio l’inchiesta sulla strage dei Georgofili, il 27 maggio del 1993. Quella notte era di turno il pubblico ministero Gabriele Chelazzi. Capirono subito, Chelazzi e Vigna, che l’esplosione era stata un attentato. « Disposi che le indagini le avrei coordinate personalmente e, data la mole di lavoro da fare, a Gabriele affiancai l’altro sostituto Francesco Fleury e Giuseppe Nicolosi, siciliano ed esperto di mafia » . Vigna e Chelazzi avevano capito sin dalle prime ore che l’ nchiesta li avrebbe portati in Sicilia, « al cuore di Cosa Nostra » . Ci volle quasi un anno di lavoro prima che il pool fiorentino giungesse, seguendo tracce telefoniche, a un numero utilizzato da Gaspare Spatuzza, del clan di Brancaccio. Quella era stata ” la strada”, il filo che li avrebbe portati anche a individuare in Paolo Bellini (ex Avanguardia Nazionale) un personaggio chiave dell’eversione, fondamentale protagonista della nuova inchiesta della procura di Bologna sulla strage alla stazione il 2 agosto 1980.
Una vita « in difesa della giustizia », quella di Vigna ( e della magistratura fiorentina). Un uomo senza tante illusioni.
Nel tirare le fila del mondo di terroristi neri e rossi che aveva studiato e indagato, di tutti quei collegamenti con i servizi segreti e con gli uomini dello Stato, di quel silenzio inquietante per l’assenza totale di « pentiti istituzionali », rifletteva sulla storia tormentata del nostro Paese, e pareva rassegnato. « Credo che la scarsità di pentiti tra i militanti dell’ eversione nera si possa spiegare con l’attesa di impunità di questi terroristi. Dovuta forse alla constatazione che, nel passaggio dal fascismo alla Repubblica, la struttura burocratica dello Stato è rimasta pressoché immutata, provocando una sorta di aspettativa di indulgenza ».
Ecco, nei giorni del coronavirus, il ricordo di una storia di servitori dello Stato, a Firenze. E nei giorni degli alterchi televisivi fra un ministro e un magistrato, membro del Csm, nei giorni della giustizia “infettata”, consola ricordare che non è stato sempre così, nel nostro Paese. Gli esempi e forse l’energia per imboccare un’ altra strada ci sarebbero. Proprio a partire da Firenze, la città che forse più di tutte in Italia ha prediletto e predilige ancora il tempo dei silenzi e l’ombra dei segreti.
Rinascere, allora, alla luce del sole.
la Repubblica Firenze, 8 maggio 2020