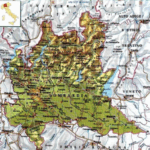Sebbene sia forte la tentazione di dire che le bufale sono sempre esistite, che la menzogna è un ingrediente imprescindibile della politica e della vita, e che dunque non c’è niente di nuovo sotto il sole di ciò che si chiama “post-verità”; sebbene si abbia voglia di tagliar corto dicendo che – al massimo – si tratta di fare attenzione a quel che si legge così come si fa attenzione a quel che si mangia e si beve, sono convinto, invece, del fatto che la post-verità sia un concetto distinto da quelli di bufala o di menzogna, e che la sua emergenza (perché nessuno ha deciso in qualche stanza “oggi lanciamo la post-verità”) metta in luce questioni che riguardano tutti, e che ci possono insegnare almeno tre cose.
Dal postmoderno al populismo. La prima riguarda la responsabilità degli intellettuali rispetto al mondo. Siamo abituati a pensare che siano una frangia irrilevante e ornamentale, eppure, in qualche modo, talvolta perverso, le idee possono realizzarsi nel mondo, spesso in maniera imprevista e indesiderata, ma si realizzano, in altre forme e contesti, e magari con esiti catastrofici. La post-verità politica come compimento del postmoderno filosofico è un esempio luminoso di questo principio.
In tanti seminari e dibattiti sulla post-verità a cui ho partecipato negli Stati Uniti molti mi attribuivano una facoltà profetica rispetto all’era di Trump, ma facevo notare che se uno si è formato nel postmoderno degli ultimi quarant’anni, e se ha conosciuto vent’anni di populismo mediatico italiano, ciò che appare come profezia è, pianamente, autobiografia. Come già nel caso italiano, la post-verità è il risultato della massificazione di un atteggiamento di avanguardia. Il che è una bella cosa, ma comporta effetti scalari del tutto imprevisti: quando Baudelaire e Théophile Gautier si trovavano in un nobile palazzo decaduto sull’Île Saint-Louis a fumare hashish, era pittoresco; ma se sospettate che lo abbia appena fatto il pilota del vostro aereo, lo è molto di meno. Nel passaggio dal postmoderno al populismo e di qui alla post-verità è andata pressappoco così.
Incominciamo con un po’ di storia. Il ” New York Times è pura propaganda”, ha scritto Noam Chomsky il 20 maggio 2015. E, meno di due anni dopo, il 17 febbraio 2017, Donald Trump ha scritto che le fake news (con il New York Times in testa) “non sono il mio nemico, sono il nemico del popolo americano”. Tra le due posizioni – in apparenza identiche – c’è una differenza essenziale.
Nel criticare il New York Times, Chomsky si comporta come Socrate ed enuncia un principio di origine illuministica e idealistica: la scienza è la garanzia di una verità che rende liberi (illuminismo) ed è disinteressata, cioè al di sopra delle parti e priva di interessi pratici (idealismo). Dunque lo scienziato è il guardiano della verità, e da questa posizione può giudicare le verità altrui, per esempio quelle della stampa borghese, asservita agli interessi del capitale e della politica imperialistica.
Niente di ciò che scrivo va preso in senso ironico: sono convinto che Chomsky la pensasse proprio così, e che dicesse tutto questo in nome della verità. Trump invece è l’espressione del popolo americano in quanto portatore di verità, una verità che non ha niente a che fare con l’oggettività ma che riguarda piuttosto la solidarietà di un popolo contro le macchinazioni di una élite. È un atteggiamento che si è presentato in tante occasioni nella storia otto-novecentesca, ma che nel post-truismo ha un colorito tipicamente postmoderno. Con il postmoderno si è infatti imposta una prospettiva molto diversa da quella dell’ illuminismo chomskyano.
La scienza è un istituzione, tanto quanto lo è la politica o il capitale, dunque può essere criticata, e si può far ricorso a verità alternative. Di questa preistoria della post-verità abbiamo due versioni, una nichilista e una pragmatista. Quella nichilista è esemplificata da Michel Foucault. La volontà di sapere, la volontà di verità, non sono altro (ce lo ha insegnato Nietzsche) che volontà di potenza. Sono parte di un gioco, o meglio di un conflitto, dunque non hanno alcuno statuto privilegiato rispetto, poniamo, al potere politico. La versione pragmatista è proposta da Richard Rorty, e suona: la scienza e l’ oggettività non sono la vera, né meno che mai la sola, misura della realizzazione e della felicità umana, l’ intellettuale non ha un rapporto privilegiato con la realtà. Ciò che l’ esperienza storica del Novecento e delle sue catastrofi ci ha insegnato è che la solidarietà è più importante dell’oggettività, e che la democrazia è più importante della filosofia. Dobbiamo dunque dire addio al culto tutto sommato superstizioso per la verità, e cercare di promuovere il dialogo e l’intesa sociale.
A questo punto, arriva Trump. In realtà ha degli antecedenti, per esempio nell’ amministrazione Bush che aveva elaborato la teoria delle “comunità basate sulla realtà” (i comuni mortali che credono nell’ oggettività) e difeso la possibilità, per i detentori del potere, di creare una loro realtà. In proprio, Trump si limita a dare del bugiardo agli altri, ma quando gli altri danno del bugiardo a lui, il che avviene in ragione direttamente proporzionale alle accuse di bugiarderia rivolte agli altri, delega ai propri portavoce il compito di spiegare che si trattava di “verità alternative”. Il conio linguistico è una reminiscenza della critica postmoderna alla scienza: pretendere che la verità sia una è dogmatismo, bisogna ammettere che ci sono verità alternative proprio come ci sono medicine alternative ed energie alternative.
Sbaglia dunque – me la prendo anch’io con la stampa – quando (nell’edizione del 3 aprile 2017) titola “La verità è morta?”. Piuttosto, abbiamo a che fare con una inflazione della verità. Né Chomsky, né Trump, né il intendono dire niente di diverso dalla verità. Anzi: vogliono dire la verità, nient’ altro che la verità: il Professore e il Presidente dicono che il Giornale Per Eccellenza mente (manifestando entrambi un disprezzo, rispettivamente di sinistra e di destra, rispetto alla stampa borghese), e il Giornale Per Eccellenza, a sua volta, senza curarsi dell’ irrilevante Professore, si impegna a segnalare tutte le bugie del Presidente, che però non sono considerevolmente più elevate di quelle di Kennedy o di Roosevelt. E anche Foucault, nel sostenere che la verità è volontà di potenza, o Rorty, nel dire che bisogna sostituire la verità con la solidarietà, ritenevano di dire la verità. Il grande gioco della post-verità è tutto qui: se Cartesio asseriva che la verità è indice di se stessa e del falso, i sostengono che il modo migliore per affermare la propria verità è dare del bugiardo al prossimo, sia esso il nel caso di Chomsky e Trump, o Socrate, questo incurabile malato di verità, nel caso di Foucault e Rorty.
La seconda illuminazione della post- verità riguarda l’ importanza della tecnica nell’ emergere delle idee e dei comportamenti. Siamo abituati a pensare alla tecnica come alla realizzazione di un progetto con scopi deliberati e circoscritti (ho bisogno di aprire un tappo, invento il cavatappi) ma non è così. La tecnica non è orientata dal proprio scopo, come altri saperi umani. Essa è al contrario autonoma e creativa: chi ha inventato la macchina a vapore non pensava che ne sarebbe nato un intero ordine sociale che ha regolato la vita degli esseri umani per quasi tre secoli: il capitalismo. E chi ha inventato il web non immaginava che avrebbe dato luogo a un apparato ancora più potente di quello che lo aveva preceduto, un apparato complesso che propongo di chiamare “documedialità”, termine composto che designa la fusione tra la forma vincolante e costitutiva dei documenti nel mondo sociale e la forza mobilitante dei media. La documedialità ha posto (insieme a tante altre cose, buone e cattive) le premesse materiali della post-verità esattamente come il postmoderno ne aveva elaborato le premesse ideali.
L’assetto tecnico offerto dalla documedialità risponde a una domanda inevitabile: vuoi dire che i populisti hanno letto i postmoderni, si sono alimentati delle gesta dei primi e sui tomi dei secondi? No. Voglio dire che Trump non ha avuto bisogno di leggere Rorty o Foucault per attuare il mondo post-veritativo più di quanto Vanderbilt abbia avuto bisogno di leggere Marx per attuare il mondo capitalistico. Sugli uni come sugli altri gravava un orizzonte tecnico vincolante: il modo di produzione capitalistico nel caso di Vanderbilt e di Marx, il modo di produzione documedialistico nell’ arco che da Rorty e Foucault conduce a Trump, e che consiste nella produzione non più di artefatti, bensì di oggetti sociali, di documenti, con quello che, del tutto riduttivamente, è stato reso attraverso il concetto di finanziarizzazione del capitale, mentre è – in effetti – la sostituzione del capitale da parte della documedialità.
Ecco la vera trasformazione silenziosa. Tutti parlano di una rivoluzione, a proposito del web, ma – e qui sta il vero problema – non è chiaro di che si tratti, come avvenga e quali conseguenze comporti. Per comprenderlo, il ricorso al concetto di “documedialità” propone anzitutto di concepire la rivoluzione tecnologica come una rivelazione socio-antropologica. Per quanto grandi siano le trasformazioni apportate dal web – ampiamente analizzate negli ultimi decenni – resta che il suo merito maggiore sta nel rivelare le strutture profonde della realtà sociale, strutture ben precedenti il web. Ha mostrato che la realtà sociale non ha bisogno solo di comunicazioni, ma, ancor più, di registrazioni, mettendoci sotto gli occhi, per l’ appunto con l’ esplosione della scrittura a cui assistiamo da tre decenni a questa parte, il ruolo non accessorio, ma costitutivo, che i documenti svolgono nella costruzione della realtà sociale.
Grazie a queste proprietà, il web si candida a essere, ben più che il capitale, che ne è semplicemente una preforma, l’assoluto del nostro tempo: il sapere assoluto, sul mondo e su noi stessi (conosce le nostre abitudini e i nostri pensieri meglio di noi), il non-sapere assoluto (quante falsità o idiozie circolano sul web, e circolano regolarmente sotto la forma di post-verità o di verità alternative), il potere assoluto (fuori del web non c’ è potere economico, politico o militare: chi avrebbe pensato che il Presidente americano si sarebbe espresso a colpi di tweet?), e anche il dovere assoluto, l’ imperativo categorico, una motivazione che sta alla base di una mobilitazione di risorse e di energie che non ha precedenti nella storia umana e che ha di mira un’ unica aspirazione: esprimiti, sii te stesso, anche a costo di mostrare il peggio.
Così, l’Ottantanove non ha segnato semplicemente la fine delle due verità contrapposte che si guardavano dai due lati di un muro, ha anche visto i primi passi di uno strumento, il web, che avrebbe dato voce (e, soprattutto, scrittura, permanenza, viralità) a milioni di verità individuali, di deliri della presunzione ( avrebbe detto Hegel) o, se preferiamo, di post- verità. Ogni ricettore dei tetri e concettosi messaggi ideologici di quarant’ anni fa, e dei più suadenti e ironici messaggi populistici di vent’ anni fa è ora produttore di messaggi post-veritativi, e il problema della post- verità non sono tanto le dichiarazioni di Trump, ma le viralità del web, gli effetti che producono e insieme gli intensi piaceri che generano, sia pure sui temi più futili.
Dall’alienazione al riconoscimento La terza rivelazione della post-verità, che è il risultato delle prime due, riguarda l’ idea di democrazia che emerge dall’incontro fra post-verità e documedialità. E si riassume in una considerazione molto semplice: la post-verità costituisce un momento di mobilitazione di massa con pochi precedenti. Ogni utente del web esprime la propria verità, con una libertà che tecnicamente è sovrana rispetto a ogni altra istanza – uno vale uno, in politica come nel sapere, e se io sostengo che la luna è fatta di formaggio è indemocratico obiettarmi che forse non è così. Ma la domanda, a questo punto, è molto semplice: può esserci una democrazia senza verità condivisa? E, inversamente, quali possono essere i caratteri della democrazia nell’epoca della post-verità?
Bisogna partire da un punto decisivo. Il mondo documediale genera consenso esattamente come lo generava il mondo capitalistico prima che nascesse la lotta di classe, la quale peraltro si è rivelata alla lunga perdente, e dopotutto si capisce il motivo: il capitale dava mezzi di sussistenza e in cambio chiedeva alienazione, la cessione del proprio tempo da destinarsi ad attività meccaniche e ripetitive. Ma la documedialità che cosa dà in cambio?
Qui la mia ipotesi è che offra – e lo si vede benissimo guardando al web, e ai movimenti politici che ha generato – la più grande (anche se spesso rovinosa) speranza che possa animare un essere umano: quella di essere riconosciuto dai suoi simili, fosse pure soltanto con un like, e di sentirsi dar ragione, magari da qualcuno matto come te e convinto che la Terra è concava e non convessa, che i vaccini causano l’ autismo, che gli attentati dell’ 11 settembre li ha voluti la Cia e, ovviamente, che la Luna è fatta di formaggio.
Che l’umanità sia intenta a pensare con la propria testa più di quanto non sia avvenuto in qualunque altro periodo della storia è comunque una grande conquista. Resta da fare ancora uno sforzo, quello che ci ricordava Kant quando sosteneva che l’ Illuminismo non è solo pensare con la propria testa, ma anche nell’ essere capaci di mettersi nella testa degli altri. L’ analisi della reputazione ( quella che i filologi chiamavano critica delle fonti) e il ossia il controllo delle informazioni, sono rimedi ovvi ma insufficienti alla post-verità, perché suppongono una umanità interessata a sapere il vero, laddove la situazione è molto più complicata e, di nuovo, perversa. L’umanità, infatti, non è interessata a sapere il vero, ma ad avere ragione e a trovare conferma delle proprie convinzioni, ossia si è appropriata, in un momento di intensa democratizzazione, delle prerogative delle élite. Quando si parla di post-verità si pensa sempre a Trump, ma si dimenticano due cose essenziali. La prima è che gli elettori di Trump la pensano esattamente come lui, altrimenti non lo avrebbero eletto, e che tutti insieme sono convinti non di dire cose post- vere, bensì di affermare la pura e semplice verità, e che i bugiardi sono gli Altri, cioè tutti coloro che non gli danno ragione.
L’ideologia che anima la post-verità è l’atomismo di milioni di persone convinte di aver ragione non insieme (come credevano, sbagliando, le chiese ideologiche del secolo scorso) ma da sole. Il centro di questa nuova ideologia è la pretesa di esser nel vero a prescindere, e nel cercare riconoscimento attraverso un apparato tecnico, il web, che permette l’ espressione delle idee dei singoli rendendole irrilevanti (appunto perché uno vale uno) e realizza invece la microfisica del potere, canalizzando tutte quelle idee – diverse, ma tutte equivalenti – in un gigantesco I like, un apparato che conta per i numeri che esprime e che, insieme, manifesta una opinione pubblica totalmente monadica. Io sono io, ecco il refrain che sta alla base di una inflazione di verità fai da te (proprio come, invece, al tempo delle ideologie, c’era una sola verità che costituiva un articolo di fede per immense comunità).
Che fare? Il miglior correttivo alla post-verità è la verità, cioè la cultura. La consapevolezza del fatto che verità non sta all’inizio, ma alla fine, quando c’è, e quando ci si arriva, magari per dispetto nei confronti della post-verità: basti pensare che è stato lo smascheramento di un fashionable nonsense come la Donazione di Costantino – il falso che sanciva il potere temporale dei Papi – a determinare la nascita della filologia umanistica.
Insomma, sebbene la verità prima o poi venga a galla, la ricerca della verità difficilmente si può svolgere a mani nude e senza un addestramento culturale. Lo dice Agostino nelle Confessioni: voglio fare la verità, non solo nel mio cuore, ma anche per iscritto e di fronte a molti testimoni. Che cosa intende? Che si fa la verità così come si fa il caffè? No. Proporrei di interpretare questa frase così: la verità non è nulla di autoevidente, e richiede un addestramento tecnico, oltre che una buona dose di buona volontà e alle volte persino di coraggio personale.
Le idee sono a buon mercato come le mele, diceva Hegel, e l’esplosione documediale del web lo dimostra come meglio non si potrebbe. Come distinguere le buone idee? Sottoponendole non a un asfittico fact-checking, bensì – con uno sguardo filosofico e politico – all’ impegnativo test proposto da William James: “Vere sono quelle idee che possiamo assimilare, convalidare, corroborare e verificare. Le idee cui non è possibile fare tutto questo sono false”.
la Repubblica, 30 aprile 2017