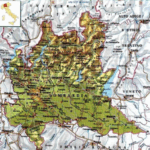Giovedì 13 aprile 1967, primo pomeriggio. Il principe Antonio de Curtis rincasa dal set molto presto, più presto del solito, a bordo della Mercedes grigia guidata dal fido autista Carlo Cafiero. Proprio quel giorno ha cominciato le riprese de “Il padre di famiglia” di Nanni Loy. “Cafie’, mi sento ‘na schifezza”, dice entrando nell’ascensore della sua casa di via Monte Parioli 4 a Roma. Ad attenderlo c’è Franca Faldini, la giovane attrice dagli occhi azzurrissimi, sua compagna da 14 anni. Il medico assicura che non è nulla, ma la sera seguente Franca lo trova appoggiato al tavolo, pallidissimo. “Chi mi ha tirato questa fucilata al petto?”. Attacco alle coronarie. Tre infarti in due ore. Poi l’ultimo attimo di lucidità e le ultime parole sulle quali, come per tutti i grandi, si litiga da 50 anni. “Lasciatemi in pace, fatemi morire”. Oppure: “Sto male, portatemi a Napoli”. O ancora: “Ricordatevi che sono cattolico, apostolico, romano”. O forse tutt’e tre le frasi insieme. Spira alle 3 di notte di sabato 15 aprile. Qualche ora dopo iniziano a piovere le telefonate, i telegrammi. Poi la processione nella camera ardente di parenti amici, colleghi, attori, registi, autorità, semplici cittadini e critici. Quei critici che fino al giorno prima non avevano fatto che disprezzarlo.
La salma parte per Napoli. Esequie solenni nella chiesa del Carmine, una folla immensa accorsa ad accogliere la bara fin dallo svincolo dell’autostrada. Nino Taranto, la voce spezzata dal pianto, pronuncia la breve l’orazione funebre: “Hai regalato a Napoli il sorriso al posto della malinconia… Il tuo pubblico è qui e ha voluto che il suo Totò facesse a Napoli l’ultimo esaurito della sua carriera…”. Ma due giorni dopo il suo rione Sanità gli regala un secondo funerale. Lo organizza Nicola Campoluongo, detto “Nase ‘e cane”, il vecchio guappo della mala che, conosciuto Totò in gioventù, se n’era autoproclamato il protettore: “’O principe ha da turna’ a casa”. La bara vuota viene portata sulle spalle dai gorilla del guappo, tra gli stessi napoletani piangenti e acclamanti di due giorni prima. E dire che, poco prima di morire, ‘O Principe aveva detto nell’ultima intervista: “Chiudo in fallimento, nessuno mi ricorderà…”.
Antonio nasce a Napoli, rione Sanità, il 15 febbraio 1898. Figlio naturale di Anna Clemente, popolana di umilissime origini, e del marchesino Giuseppe de Curtis, rampollo di una nobile casata decaduta. Che, per il divieto degli aristocratici genitori, è costretto ad abbandonare la ragazza col bebè in fasce. Anna lo tira su con mille sacrifici lavorando giorno e notte e affidandolo alla nonna. Totò passa il tempo a giocare con gli amici del rione, detesta la scuola, non spiccica una parola d’italiano. E, quando rischia di finire malamente, viene spedito per tre anni in un collegio per ragazzi poveri, fino al termine delle elementari. Qui, mentre si allena alla boxe con un istruttore, si procura quella deviazione cronica del setto nasale che farà la sua fortuna (l’altra metà della sua maschera comica se la procurerà lui stesso, prendendosi a pugni la mascella fino a sganciarla dalla sua sede naturale). Tornato a casa, ripiomba nei vicoli, bazzicati anche da Eduardo De Filippo, di due anni più giovane, ma di famiglia meno misera. Lo chiamano “Totò ‘o spione” per l’abitudine di pedinare i personaggi più stravaganti del rione facendone il verso. Il suo primo palcoscenico è proprio la strada: improvvisa imitazioni, scenette, spettacolini, che poi replica in casa davanti ai parenti. Ma la madre sogna per lui una carriera da ufficiale di Marina. E lui, anche per sfuggire dall’asfissiante tutela materna, parte volontario per la Grande Guerra.
È il 1915. Lo destinano a Pisa, poi in Francia. E mentre già sta sulla tradotta verso il confine, capisce che la guerra è una cosa seria. E riesce a farsi riformare in extremis simulando una raffica di attacchi epilettici. L’ufficiale medico abbocca e nel ’18 lo rispedisce a Napoli. Ha quasi vent’anni e deve decidere cosa fare da grande. Ma combina poco. Nel 1922 il marchese suo padre si rifà vivo con la madre per sposarla. Ad Antonio, vissuto da sempre nell’onta del figlio bastardo, non par vero di scoprirsi figlio di un marchese, per quanto spiantato. Ma non si accontenta e si fa adottare dal principe Francesco Gagliardi, che gli regala una sfilza di titoli araldici: Focas Flavio Angelo, Ducas Comneno de Curtis di Bisanzio Gagliardi Antonio Giuseppe di Luigi Napoli, Principe Conte Palatino, Cavaliere del Sacro Romano impero, Nobile Altezza Imperiale. Il padre, piccolo impresario teatrale, lo fa ben sperare per la carriera artistica. Lui intanto segue come un’ombra il re dell’avanspettacolo napoletano Gustavo De Marco. Ma Napoli non offre sbocchi. E la famiglia De Curtis finalmente riunita si trasferisce a Roma. Antonio bussa a tutte le porte della capitale, invano. Soffre la fame, recita per un tozzo di pane nelle compagnie più malfamate, conosce persino l’abiezione della droga (una boccetta di etere che, scoperta dalla madre, gli vale una scarica di botte). In teatro ci entra, alla fine, ma come maschera: accompagna la gente ai posti prima degli spettacoli, al teatro del varietà, il Jovinelli, fondato dall’omonimo impresario casertano Peppe.
Poi, una sera, il colpo di fortuna: De Marco, approdato a Roma sulle ali del successo, litiga con l’impresario e dà forfait. Si fa avanti Antonio: “Don Peppe, saccio fare il repertorio di De Marco. Se volete, stasera recito io”. Jovinelli lo mette alla prova. Funziona. Il contratto, da giornaliero, diventa settimanale, poi mensile, poi annuale. Nel 1931 già guadagna mille lire a serata, proprio mentre un cantante in voga, Gilberto Mazzi, sogna “mille lire al mese”. In cartellone “Totò imitatore di De Marco” diventa semplicemente “Totò”: serata dopo serata, abbandona le macchiette demarchiane e crea un personaggio tutto suo: sciamméria (una specie di frac) larga e lunga, pantaloni “a saltafosso”, calzini a rigoni colorati, bombetta nera, laccio da scarpe a mo’ di cravatta.
Totò, appunto: marionetta in carne e ossa, povera e surreale, snodata e scattante, l’ultima maschera della commedia dell’arte. Successo clamoroso, tournée sold out in tutta Italia, ingaggi da favola, avventure galanti. Travolgente quella intrecciata nel ’29 con la soubrette più famosa d’Italia, Liliana Castagnola: dura un anno, poi la diva abbandonata si suicida con due flaconi di sonnifero. Totò non riuscirà mai a perdonarselo. E non sarà più lo stesso. Disperato, poi triste, infine malinconico. Per qualche mese medita di mollare tutto. Ma nell’estate del ’31 conosce Diana Baldini Rogliani, 16 anni, bella e innamorata pazza di lui. Prima la “rapisce”, poi la sposa e due anni dopo nasce Liliana (come la Castagnola), l’unica figlia. Ben presto però la morbosa gelosia di lui guasta i rapporti dei coniugi. I due si separano di fatto nel 1940, ma per non turbare l’infanzia della figlia decidono di vivere insieme fino ai suoi 18 anni. Diana però se ne va prima per risposarsi, stufa delle infedeltà del marito che per questo le dedicherà Malafemmena, la canzone struggente su cui si favoleggerà tanto (secondo alcuni, smentiti da Liliana, era dedicata a Silvana Pampanini che aveva rifiutato la sua proposta di nozze).
Sono gli anni ruggenti del varietà e Totò ne è il primattore assoluto. Gira l’Italia con la rivista e le commedie di Eduardo Scarpetta (che porterà poi al cinema, da “Miseria e nobiltà” a “Il medico dei pazzi”), recita nella grande compagnia di Michele Galdieri, fa coppia con Anna Magnani e terzetto con Eduardo e Peppino De Filippo (capolavori di cui purtroppo non resta traccia filmata, a parte qualche sketch ripreso nei suoi film, a cominciare dal collage “Totò a colori”). Incappa persino nelle maglie della censura per il suo vezzo di parodiare il Duce e il Fuhrer. Si becca una denuncia per un’innocua battuta su “Galileo Gali-lei/Gali-voi”, che prende in giro la campagna del regime per il “voi” contro il “lei”. Nel marzo del ’44, in una Roma pullulante di nazisti dopo la strage delle Ardeatine, il coprifuoco sbarra tutti i locali, compresi i teatri. Anche il Valle, dove Totò è in cartellone con la Magnani nella rivista “Che ti sei messo in testa?”. Il questore Pietro Caruso – lo racconterà lo studioso Francesco Canessa su La Repubblica-Napoli – avverte il principe che i tedeschi vogliono arrestarlo per le sue imitazioni di Mussolini, più esplicite in privato, solo accennate sul palco. E con lui rischiano la galera Peppino ed Eduardo, impegnati in quei giorni alla Sala Umberto. Totò avverte Peppino tramite un macchinista del teatro, poi corre a nascondersi nel casale di un contadino a Valmontone, mentre i De Filippo si rintanano in casa di amici in città. Fino al 4 giugno, quando gli Alleati entrano nella Capitale. Tre giorni dopo riapre il Valle: Totò e la Magnani tornano sul palco, con la stessa rivista intitolata però “Con un palmo di naso” e aperta da una nuova “sortita” liberatoria del principe che, sulle note accelerate di Lili Marleen, marcia al passo dell’oca sbeffeggiando Hitler con baffetti, divisa militare e un telefono in mano: “Tutte le sere al general quartier / arriva una telefonata per me il Furier! / si rincula al sud, dice ma / ma si avanza verso il nord! / Si rincula a sud, ma si avanza al nord!… Eins-zvei-eins-zvei…”.
Intanto nel 1937 Totò ha debuttato al cinema in “Fermo con le mani”, scritto dal futuro leader dell’Uomo Qualunque, Guglielmo Giannini. Un mezzo fiasco. Ci riprova con “Animali pazzi” di Achille Campanile, diretto da quello che diverrà uno dei suoi registi preferiti, il futurista Carlo Ludovico Bragaglia. Altro insuccesso. Il terzo tentativo però va meglio: “San Giovanni Decollato” di Cesare Zavattini. E’ il 1940, l’anno dell’entrata in guerra. Di film Totò ne girerà 97 in 30 anni. “Papà non amava il cinema – racconterà la figlia Liliana – ma lo faceva perché gli dava la possibilità di guadagnare molto di più con minore fatica. Soprattutto da quando cominciò a perdere la vista, fino alla cecità pressoché totale. Un occhio lo perse da giovane per distacco della retina, l’altro nel ’56 per una polmonite virale trascurata, e da allora non vide che ombre confuse”. Ma poi l’adrenalina da palco e da ciak faceva ogni volta il miracolo.
All’uscita di ogni pellicola, i critici storcono il naso e stroncano il Principe, siglano le recensioni “Vice” per non sminuirsi con la propria firma e coniano per i suoi film un neologismo spregiativo: “totoate”. In effetti molti soggetti sono deboli, canovacci da commedia dell’arte, e meno male perchè il resto lo aggiunge lui, il Principe, col tocco del suo genio, riuscendo a rendere appetitose le trame più sciape, irresistibili i copioni più insulsi con invenzioni pirotecniche, improvvisazioni fulminanti, gag esilaranti, giochi di parole, mimiche da marionetta umana anzi sovrumana (le scene della lettera alla malafemmina e del treno inizialmente duravano 30 secondi). Comunque lavora con signori registi come Mattoli, Steno, Mastrocinque, Corbucci, su su fino a Lattuada, Comencini, Monicelli, Risi, Rossellini e Pasolini. E duetta con Peppino, Eduardo e Titina De Filippo, Taranto, Fabrizi, De Sica, Macario (il prediletto, per la sua stralunatezza), Magnani, Fernandel, Sordi, Mastroianni, Gassman, Tognazzi, Manfredi, Franca Valeri, Sophia Loren, Virna Lisi, oltre alla fedele spalla di sempre, Mario Castellani (l’onorevole Trombetta nello sketch del treno).
Le sale sono sempre strapiene, il popolo lo adora da un capo all’altro d’Italia. Ma la puzza sotto il naso della critica fighetta e impegnata, che non riesce a cogliere la profondità tridimensionale del suo lavoro di vero intellettuale e poeta, inventore di una neolingua che gli sopravviverà in eterno, non gli perdona il disimpegno politico, né coi governi Dc né con le opposizioni socialcomuniste. Infatti il commovente “Totò e Carolina” di Monicelli si guadagna il record di film più tartassato dalla censura di Stato: “Hanno fatto 82 tagli – ricorderà Totò – e hanno persino preteso la soppressione del nome del mio personaggio che si presentava dicendo: Caccavallo, agente dell’Urbe” (“dell’Urbe” suonava, per gli ottusi censori, troppo nostalgica e fu sostituita con “di Roma”, rovinando la battuta). Di politica capisce poco e s’interessa ancor meno. E’ iscritto alla massoneria, eppure cattolico osservante. E monarchico, forse per la passione araldica, ma soprattutto per la sua natura di uomo fuori dallo spazio e dal tempo. Una sera del 1958, al Musichiere di Mario Riva, si lascia sfuggire un “Viva Lauro!” (Achille, l’armatore monarchico). Riva, spaventato, lo rimbrotta: “Ma Totò…”. E lui: “A me piace Lauro, che vuo’ fa’?”. Non lo si rivedrà più in tv, fino al celebre duetto del 1965 con Mina a Studio Uno.
“Ho fatto un ammasso di schifezze”, ripete negli ultimi anni sempre più cupo, amareggiato e menomato della cecità. Riservato e malinconico, mai mondano, ma sempre gentile e generoso con tutti i bisognosi come lo era stato lui: elargisce biglietti da 10mila ai poveri che l’aspettano sul portone di casa, regala moto agli operai della troupe, dona auto come regali di nozze agli amici e la notte si fa portare nei quartieri popolari per infilare sotto usci buste anonime gonfie di banconote per garantire risvegli da favola a gente che non saprà mai chi ringraziare. Adotta anche 150 cani abbandonati, mettendo su un canile sulla Cassia.
Ricco, famoso, mai felice. Tutto il contrario della sua maschera. I grandi registi “seri” lo snobbano (a parte Rossellini e poi Pasolini: Fellini risponde ai suoi appelli facendosi beffe di lui). E negli ultimi anni anche alcuni colleghi, come Peppino, iniziano a rifiutare di recitargli accanto per non “sminuirsi”.
Un giorno gli assegnano un premio minore. Lui, serissimo, va a ritirarlo, sale sul palco e si accorge, con quel po’ di vista che gli è rimasta, che in sala a festeggiarlo non c’è quasi nessuno. Se ne va piangendo, con la sua statuetta di latta sotto il braccio. Solo quando Pasolini lo chiama per “Uccellacci e uccellini” la critica “impegnata” sembra ricredersi. Ma è tardi. Anzi quel successo tardivo lo deprime vieppiù, come se dei suoi quasi cento film non si fosse accorto nessuno. “Sarei potuto diventare un grande attore e invece non ho fatto nulla di buono”, dice sconsolato pochi mesi prima del passo d’addio. Non sa che, a funerali avvenuti, persino Fellini proporrà addirittura di farlo santo. E che saranno i suoi critici a essere dimenticati, non lui. Chissà le risate lassù su quella nuvoletta nel paradiso dell’incanto e della fantasia, della tenerezza e dell’ironia. Là dove si pasteggia a Moet Chandon. E lui: “Mo’ esce Antonio”.
Il Fatto Quotidiano, 3 aprile 2017