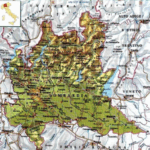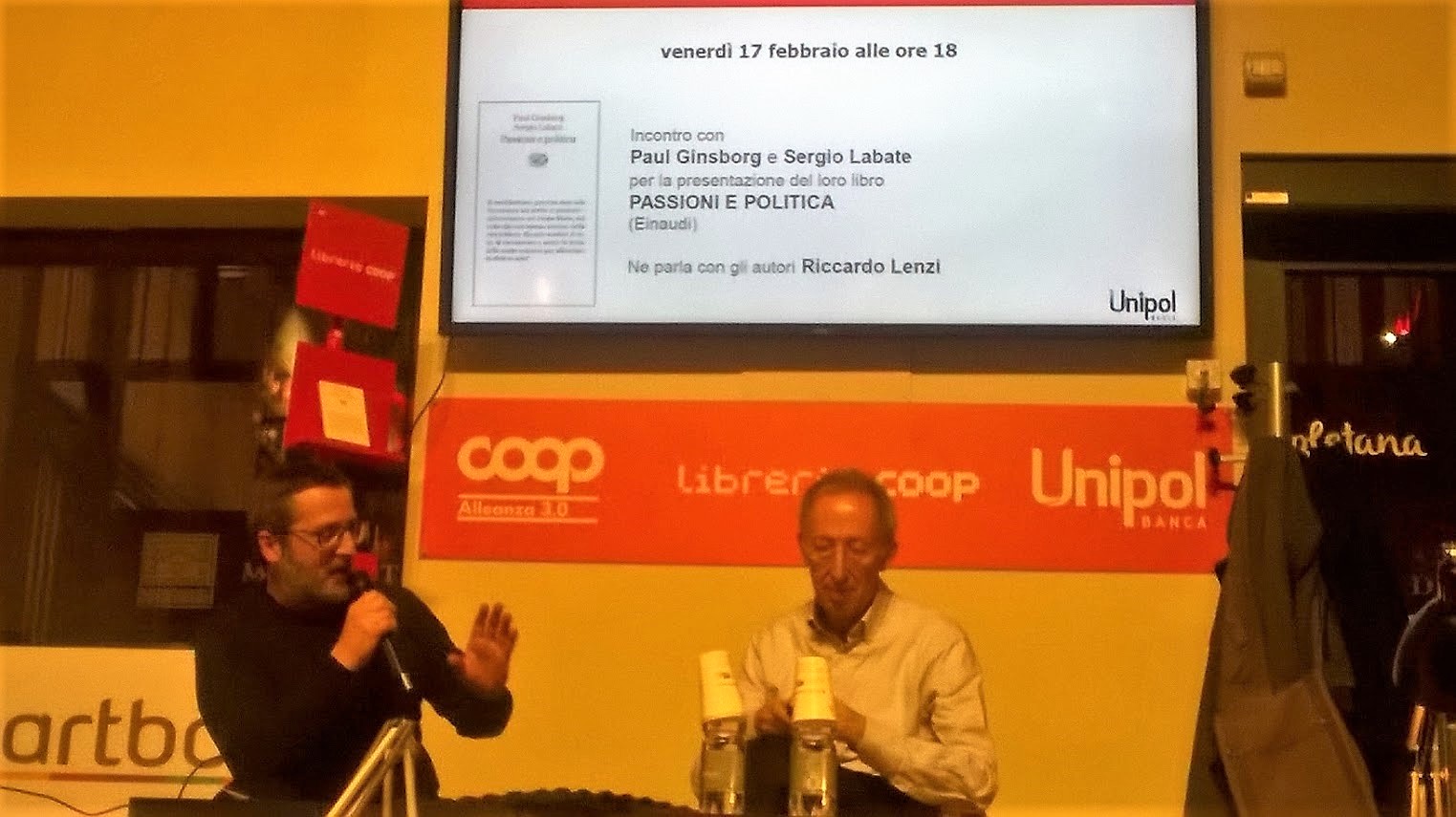Com’era prevedibile, il 25° anniversario di Tangentopoli ha riportato a galla i vecchi rancori e le solite, superficiali e smemorate, interpretazioni di comodo di quella turbolenta tappa dell’eterna transizione italiana. Restano drammaticamente attuali le parole del sociologo Giovanni Moro, scritte dieci anni fa in quel magnifico libricino dedicato agli “Anni Settanta”: «Il fatto che si dimentichi che le inchieste della magistratura sulla corruzione politica seguirono e non precedettero eventi come l’inatteso successo della Lega Nord alle elezioni o il referendum sulla preferenza unica, e soprattutto che si interpreti Tangentopoli come un complotto di magistrati, comunisti e capitalismo delle grandi famiglie con una spruzzatina di potenze straniere, dice proprio che ancora non si è, non dico accettato, ma nemmeno capito che il rapporto tra politica e cittadini è definitivamente cambiato. Lo stesso abuso del termine antipolitica è una spia della persistenza di questa sopravvivenza». Abuso, va detto, che negli ultimi anni ha avuto una crescita esponenziale, dettata dalla ricerca di un capro espiatorio più che da una sincera preoccupazione dei “politici seri”.
La crisi della politica, non solo in Italia, ha radici ben più remote della crisi economica globale emersa nel 2007/2008. È una crisi che accomuna sia i soggetti della rappresentanza (partiti, sindacati), sia quelli della partecipazione (movimenti, associazioni). Negli ultimi quindici anni, anche grazie alla diffusione virale di potenti mezzi di comunicazione alla portata di quasi tutti, abbiamo assistito ad un fiorire di manifesti, appelli, petizioni, anatemi, ecc. Un assordante rumore di fondo che non ha modificato di un millimetro i rapporti di forza nella società, rafforzando altresì la sensazione di irreversibile decadimento delle democrazie. Nel 1938 Benedetto Croce notava come questo tipo di percezioni siano in realtà dettate dalla paura di lasciare il certo per l’incerto: «Di decadenza si può bensì parlare e se ne parla, ma per l’appunto in riferimento a certe guise di opere e di ideali che ci sono cari… Ma in senso assoluto, e in storia, non c’è mai decadenza che non sia insieme formazione o preparazione di nuova vita, e, pertanto, progresso» [La storia come pensiero e come azione].
Nel marzo 2012, quando al governo c’era Mario Monti, venne divulgato un lungo appello intitolato “Non c’è più tempo. Manifesto per un soggetto politico nuovo. Per un’altra politica nelle forme e nelle passioni”*. A distanza di qualche anno da quella proposta – come altre caduta nel vuoto -, mentre lo scontro politico si concentrava sulla infinita e logorante campagna referendaria terminata lo scorso 4 dicembre, è uscito un libro che sviluppa un ragionamento proprio a partire dai temi contenuti in quell’appello. Mi riferisco al saggio “Passioni e politica” (Einaudi, 2016), scritto a quattro mani dallo storico Paul Ginsborg – tra i firmatari del suddetto manifesto – e dal filosofo Sergio Labate. Un libro – gli autori lo definiscono «uno strumento» – che evidentemente non ha fatto tesoro solo di una lunga ed approfondita ricerca, ma anche di un’attenta analisi critica dei più o meno recenti tentativi di rigenerazione della politica italiana; tutti sostanzialmente falliti, di solito a causa del narcisismo dei leader e/o delle ritualità stantie che hanno caratterizzato (caratterizzano?) l’agire politico. Tentativi spesso generosi e dettati dalle migliori intenzioni ma che, strada facendo, hanno esaurito la loro già debole “spinta propulsiva”, fino a generare frustrazioni e malinconici abbandoni (chi scrive è uno dei numerosi testimoni di queste dinamiche).
La storia ci insegna però che anche attraverso i fallimenti si producono nuove e rivitalizzanti energie. Da questo bicchiere mezzo pieno – o, se preferite, da questa speranza – gli autori prendono le mosse per condurci in un viaggio storico-filosofico da Confucio a Facebook, passando per Machiavelli. Una lettura arricchente, a tratti impegnativa, che propone uno sforzo individuale e collettivo decisamente inattuale: ripensare alle forme e alle pratiche della politica a partire da un autogoverno individuale delle proprie passioni volto a realizzare un cambiamento concreto del nostro approccio alla realtà e, a maggior ragione, alla politica. Gli autori sono convinti che un sano “realismo politico”, troppe volte evocato a sproposito quale alibi di scelte indifendibili (penso all’indulto del 2006), debba avere due precondizioni: «lo sviluppo di una saggezza affettiva», presupposto ineludibile per generare un approccio alla politica alternativo all’arrendevole e crescente fatalismo che ci circonda; l’adozione da parte dei soggetti politicamente impegnati di un decentramento metodologico, ossia una pratica di autonalisi basata sull’attenzione costante alle proprie passioni («Decentrarsi vuol dire uscire dall’effetto individualizzante del leaderismo, per cui oggi la discussione sulla politica è diventata quasi sempre una discussione sui politici»). Questa proposta, che ad alcuni può apparire velleitaria, si basa sulla convinzione che «ogni educazione politica è anche un’educazione sentimentale».
Ginsborg e Labate ci invitano poi a immedesimarci in una giovanissima ragazza che volesse avvicinarsi, oggi, alla politica: partecipando ad una qualunque assemblea, si troverebbe catapultata in un ambiente respingente, fatto di vezzi ancor più che di vizi. I professionisti della politica sono infatti «incapaci di riconoscere che i riti consolidati cui sono abituati sono ormai insostenibili per coloro che hanno visto stravolti dalla riorganizzazione neoliberista i loro ritmi di vita quotidiani. (…) Quali sono le forme, i linguaggi e le passioni capaci di permettere a un lavoratore senza lavoro di associarsi liberamente e impegnarsi in politica?». In sostanza si tratta di guarire dalla sindrome del leader salvifico, espellendo ovunque possibile il narcisismo e le altre “passioni malate” troppo a lungo tollerate ed incoraggiate. Non si tratta di distinguere tra passioni buone e cattive: le passioni sono tutte ambivalenti. Si tratta invece di rielaborarle, lasciandole interagire tra esse e con i nostri stati d’animo, creando una “polifonia delle passioni”. Solo così potranno essere sottratte al dominio dispotico del romanticismo neoliberista, ideologia finora vittoriosa che, dopo aver gettato alle ortiche le istanze più condivisibili del romanticismo politico ottocentesco, ha gradualmente tramutato i dirigenti, i militanti (non solo dei partiti) e, in generale, gli internauti compulsivi in tante scimmie machiavelliche: primati innaturali, affetti da un’autodistruttiva, patologica ed «implacabile pretesa del riconoscimento di sé».
Senza accorgercene, siamo passati dall’alienazione del lavoro a un’alienazione provocata dalla precarietà e dalla disoccupazione. Una sorta di autismo di massa. L’habitat prediletto da queste scimmie interinali sono i social network, dove la politica è ridotta ad oggetto di contemplazione, perdendo la sua funzione di paziente costruzione di alternative all’esistente. Il tempo stringe, eppure sembra sfuggirci di mano: «l’accelerazione tecnologica– che ha trasferito la corrispondenza orale e scritta nella prossimità sempre a portata di mano delle nostre caselle di posta elettronica – ha avuto come suo esito perverso la sensazione della carestia di tempo. Quest’accelerazione avrebbe dovuto rappresentare l’occasione per un surplus di partecipazione, ha finito col mostrare invece una sua impasse».
Non si tratta dunque di “cambiare verso”, ma di cambiare occhiali ed aprire le orecchie. Perché se la storia non finisce, le democrazie possono invece finire all’improvviso. Tra una chat e l’altra.
(*) L’autore dell’articolo è il giornalista che ha presentato il libro di Paul Ginsborg “Passioni e Politica” (2016. Einaudi) e presidente Associazione Piantiamolamemoria