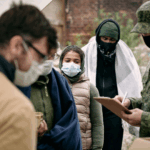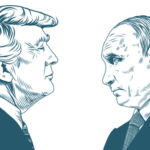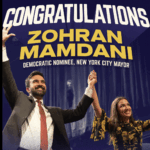Tutti i concetti generali della politica — libertà, uguaglianza, giustizia, nazione, stato, per esempio — sono usati in significati diversi, con la conseguenza di confusioni inconsapevoli e di inganni consapevoli.

Tutti i concetti generali della politica — libertà, uguaglianza, giustizia, nazione, stato, per esempio — sono usati in significati diversi, con la conseguenza di confusioni inconsapevoli e di inganni consapevoli. Gaetano Salvemini, lo storico antifascista che Bobbio include nel pantheon dei suoi “maestri nell’impegno”, ha scritto: «La parola democrazia è adoperata per indicare dottrine e attività diametralmente opposte a una delle istituzioni essenziali di un regime democratico, vale a dire l’autogoverno. Così noi sentiamo [parlare] di una cosiddetta “democrazia cristiana” che, secondo la Catholic Enciclopedia, ha lo scopo di “confortare ed elevare le classi inferiori escludendo espressamente ogni apparenza o implicazione di significato politico”; questa democrazia esisteva già al tempo di Costantino, quando il clero “dette inizio all’attività pratica della democrazia cristiana”, istituendo ospizi per orfani, anziani, infermi e viandanti.
I fascisti, i nazisti e i comunisti hanno spesso dato l’etichetta di democrazia, anzi della “reale”, “vera”, “piena”, “sostanziale”, “più onesta” democrazia ai regimi politici d’Italia, della Germania e della Russia attuali [siamo nel 1940], perché questi regimi professano anch’essi di confortare ed elevare le classi inferiori, dopo averle private di quegli stessi diritti politici senza i quali non è possibile concepire il “governo dei popoli”».
Invito al colloquio è il titolo del primo saggio di Politica e cultura ( Einaudi), un’espressione che riassume l’intera attività politico-intellettuale di Bobbio. Ma, il colloquio, affinché non si svolga in acque torbide, deve sapere qual è l’oggetto e che cosa, per non intorbidirle, ne deve stare fuori. Per questo, una definizione è necessaria, ma una definizione troppo pretenziosa non aprirebbe, bensì chiuderebbe il confronto. Ecco l’attaccamento di Bobbio alle “definizioni minime”. Sono minime le sue definizioni di socialismo, liberalismo, destra e sinistra, ad esempio. Ed è minima la definizione di democrazia; potremmo anzi dire minimissima: a) tutti devono poter partecipare, direttamente o indirettamente, alle decisioni collettive; b) le decisioni collettive devono essere prese a maggioranza. Tutto qui. Oltre che minima, questa definizione è anche solo formale: si riferisce al “chi” e al “come”, ma non al “che cosa”. Riguarda soltanto — come si usa dire per analogia — le “regole del gioco”.
In uno scambio epistolare con Pietro Ingrao sul tema della democrazia e delle riforme costituzionali che ebbe luogo tra il novembre 1985 e il gennaio 1986 (P. Ingrao , Crisi e riforma del Parlamento , Ediesse), troviamo una dimostrazione di ciò a cui serve il “concetto minimo”. Serve, da una parte, a includere, e dall’altra, a escludere e, così facendo, a chiarire. I punti del contrasto riguardano quello che allora era il progetto d’Ingrao, descritto in un libro dal titolo significativo: Masse e potere ( Editori Riuniti, 1977) che allora ebbe grande successo e che ora — mi pare — è dimenticato: la democrazia di massa o di base, unitaria e capace di egemonia. Ma gli argomenti chiamati in causa possono riguardare, in generale, tutte quelle che Bobbio avrebbe considerato degenerazioni della democrazia, alla stregua della sua definizione minima, come ad esempio, la “democrazia dell’applauso” di cui egli parla nel 1984, a proposito della conquista del Partito socialista da parte del suo segretario di allora), o la democrazia dell’investitura plebiscitaria e populista dei tempi più recenti.
Si prenda la “massa”. Bobbio chiede «che cosa si possa intendere mai per democrazia di massa di diverso da quel che s’intende per democrazia fondata sul suffragio universale»; che cosa si dica di più e di meglio «rispetto a quel che s’intende quando si parla di un sistema politico in cui tutti i cittadini maggiorenni hanno il diritto di voto »? Se non s’intende nulla di diverso, la democrazia di massa è perfettamente compatibile, anzi è la definizione formale della democrazia nella quale i cittadini possono riunirsi e associarsi per svolgere attività politica. Ma non è tutto. Introdurre le masse al poa sto dei cittadini non lascia capire esattamente di che cosa si stia parlando e nella zona grigia dell’incertezza entrano atteggiamenti emotivi che difficilmente diremmo democratici. Ingrao usa espressioni come «irruzione delle masse nello Stato», «un fiume tumultuoso che rompe gli argini e spazza e travolge ciò che trova nel suo corso», all’azione diretta della folla. Massa può alludere a un corpo collettivo amorfo e indifferenziato, mentre il soggetto principe di un regime democratico è il singolo individuo. «In democrazia non ci possono essere masse: ci sono o individui, oppure associazioni volontarie di individui, come i sindacati e i partiti». In ogni caso, in democrazia gli individui pensano e vogliono a partire dalla propria autonomia morale. Sanno affrancarsi dalla “psicologia della massa” sulla quale si appoggiano e si sono appoggiati tutti i demagoghi d’ogni tempo e luogo.
E l’unità? Che senso ha l’appello all’unità che il Partito comunista di quegli anni insistentemente faceva proprio: compromesso storico, alternativa democratica, oggi Pd o, addirittura, Partito della Nazione? La democrazia è un regime d’insieme e «non può essere chiamato democratico [si può aggiungere: nazionale] in una delle sue parti se non costo di creare una notevole confusione. Se una di queste parti viene chiamata “democratica” [o nazionale] è segno che la si considera una parte che tende a identificarsi col tutto». L’unità sconfina nella unicità. La democrazia richiede “distinzioni”, cioè pluralismo. «Senza pluralismo non è possibile alcuna forma di governo democratico e nessun governo democratico può permettersi di ridurre, limitare, comprimere il pluralismo senza trasformarsi nel suo contrario». La sintesi è espressa da Bobbio in termini assai forti, perfino scandalosi: «La discordia è il sale della democrazia, o più precisamente della dottrina liberale che sta alla base della democrazia moderna (per distinguerla dalla democrazia degli antichi). Resta sempre a fondamento del pensiero liberale e democratico moderno il famoso detto di Kant: “L’uomo vuole la concordia, ma la natura sa meglio di lui ciò che è buono per la sua specie: essa vuole la discordia”».
E l’egemonia? Qui Bobbio confessa che si tratta d’un concetto che gli è “meno familiare”, ma ciò non gli impedisce di porre una domanda analoga a quella posta a proposito della “massa”: «Mi piacerebbe che qualcuno mi spiegasse in che cosa consista l’egemonia in un sistema democratico se non nella capacità di ottenere il maggior numero di voti […] Se qualcuno mi sa dire che cosa significhi in democrazia, entro il sistema di certe regole del gioco, conquistare l’egemonia, oltre al conquistare il consenso degli elettori, lo prego di farsi avanti».
Insomma: egemonia, massa, unità non appartengono al sistema concettuale del pensiero liberal-democratico e appartengono invece alla tradizione del pensiero marxista. Tutto si tiene in una concezione della democrazia che contraddice l’universo politico che, in fin dei conti, era anche quello di Ingrao de Partito comunista. La forza elementare delle argomentazioni di Bobbio porta, alla fine, a una certa convergenza. Dice Ingrao e certo Bobbio avrebbe concordato (cito dalla lettera che conclude lo scambio): «”Democrazia minima”: dici tu. Ma anche quel livello minimo (eguaglianza formale nella libertà di voto) può realizzarsi senza chiamare in causa tutta una serie di condizioni, che riguardano libertà di voto, modalità di voto, contenuti del voto, conseguenze del voto, attuazione del voto? L’atto è quello. Ma il quadro — sociale, politico, statuale — entro cui esso si svolge è decisivo, perché esso possa essere non dico esaustivo (?), ma significante. Per “minima” che sia la democrazia, quel voto ha bisogno di un prima e di un poi che gli diano verità. Altrimenti la forma dell’uguaglianza rivela il suo limite, la sua debolezza di contenuto». Questo dice Ingrao. Ma, chi potrebbe dissentire? Chiunque s’ispiri a una concezione liberale della democrazia — Bobbio in primis — non potrebbe non essere d’accordo.
Non è questa la sede per distribuire le ragioni e torti, anche se a me pare, sommessamente, che sia stato Bobbio a condurre Ingrao sulla sua strada, e non viceversa. In ogni caso, la definizione minima del primo si è dimostrata feconda di dialogo con il secondo.
 Tutti i concetti generali della politica — libertà, uguaglianza, giustizia, nazione, stato, per esempio — sono usati in significati diversi, con la conseguenza di confusioni inconsapevoli e di inganni consapevoli. Gaetano Salvemini, lo storico antifascista che Bobbio include nel pantheon dei suoi “maestri nell’impegno”, ha scritto: «La parola democrazia è adoperata per indicare dottrine e attività diametralmente opposte a una delle istituzioni essenziali di un regime democratico, vale a dire l’autogoverno. Così noi sentiamo [parlare] di una cosiddetta “democrazia cristiana” che, secondo la Catholic Enciclopedia, ha lo scopo di “confortare ed elevare le classi inferiori escludendo espressamente ogni apparenza o implicazione di significato politico”; questa democrazia esisteva già al tempo di Costantino, quando il clero “dette inizio all’attività pratica della democrazia cristiana”, istituendo ospizi per orfani, anziani, infermi e viandanti.
Tutti i concetti generali della politica — libertà, uguaglianza, giustizia, nazione, stato, per esempio — sono usati in significati diversi, con la conseguenza di confusioni inconsapevoli e di inganni consapevoli. Gaetano Salvemini, lo storico antifascista che Bobbio include nel pantheon dei suoi “maestri nell’impegno”, ha scritto: «La parola democrazia è adoperata per indicare dottrine e attività diametralmente opposte a una delle istituzioni essenziali di un regime democratico, vale a dire l’autogoverno. Così noi sentiamo [parlare] di una cosiddetta “democrazia cristiana” che, secondo la Catholic Enciclopedia, ha lo scopo di “confortare ed elevare le classi inferiori escludendo espressamente ogni apparenza o implicazione di significato politico”; questa democrazia esisteva già al tempo di Costantino, quando il clero “dette inizio all’attività pratica della democrazia cristiana”, istituendo ospizi per orfani, anziani, infermi e viandanti.