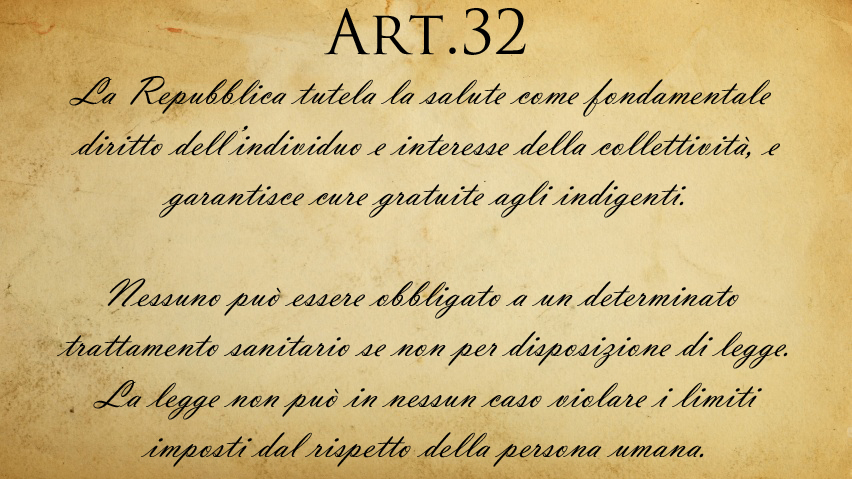LA SOCIETÀ non è la mera somma di molti rapporti bilaterali concreti, di persone che si conoscono reciprocamente. È un insieme di rapporti astratti di persone che si riconoscono come facenti parte d’una medesima cerchia umana, senza che gli uni nemmeno sappiano chi gli altri siano. Come può esserci vita comune, cioè società, tra perfetti sconosciuti? Qui entra in gioco la cultura. Consideriamo l’espressione: io mi riconosco in… Quando sono numerosi coloro che non si conoscono reciprocamente, ma si riconoscono nella stessa cosa, quale che sia, ecco formata una società. Questo “qualche cosa” di comune è “un terzo” che sta al di sopra di ogni uno e di ogni altro e questo “terzo” è condizione sine qua non d’ogni tipo di società, non necessariamente società politica. Il terzo è ciò che consente una “triangolazione”: tutti e ciascuno si riconoscono in un punto che li sovrasta e, da questo riconoscimento, discende il senso di un’appartenenza e di un’esistenza che va al di là della semplice vita biologica individuale e dei rapporti interindividuali. Quando parliamo di fraternità (nella tradizione illuminista) o di solidarietà (nella tradizione cattolica e socialista) implicitamente ci riferiamo a qualcosa che “sta più su” dei singoli fratelli o sodali: fratelli o sodali in qualcosa, in una comunanza, in una missione, in un destino comune. Noi siamo immersi in una visione orizzontale dei rapporti sociali. Ma, ciò significa forse che non abbiamo più bisogno di un “terzo unificatore”, nel senso sopra detto? Per niente. Anzi, il bisogno si pone con impellenza, precisamente a causa dei suoi presupposti costituzionali: la libertà e l’uguaglianza, i due pilastri delle concezioni politiche del nostro tempo, che se lasciati liberi di operare fuori di un contesto societario, mettono in moto forze egoistiche produttive di effetti distruttivi della con-vivenza.
LA SOCIETÀ non è la mera somma di molti rapporti bilaterali concreti, di persone che si conoscono reciprocamente. È un insieme di rapporti astratti di persone che si riconoscono come facenti parte d’una medesima cerchia umana, senza che gli uni nemmeno sappiano chi gli altri siano. Come può esserci vita comune, cioè società, tra perfetti sconosciuti? Qui entra in gioco la cultura. Consideriamo l’espressione: io mi riconosco in… Quando sono numerosi coloro che non si conoscono reciprocamente, ma si riconoscono nella stessa cosa, quale che sia, ecco formata una società. Questo “qualche cosa” di comune è “un terzo” che sta al di sopra di ogni uno e di ogni altro e questo “terzo” è condizione sine qua non d’ogni tipo di società, non necessariamente società politica. Il terzo è ciò che consente una “triangolazione”: tutti e ciascuno si riconoscono in un punto che li sovrasta e, da questo riconoscimento, discende il senso di un’appartenenza e di un’esistenza che va al di là della semplice vita biologica individuale e dei rapporti interindividuali. Quando parliamo di fraternità (nella tradizione illuminista) o di solidarietà (nella tradizione cattolica e socialista) implicitamente ci riferiamo a qualcosa che “sta più su” dei singoli fratelli o sodali: fratelli o sodali in qualcosa, in una comunanza, in una missione, in un destino comune. Noi siamo immersi in una visione orizzontale dei rapporti sociali. Ma, ciò significa forse che non abbiamo più bisogno di un “terzo unificatore”, nel senso sopra detto? Per niente. Anzi, il bisogno si pone con impellenza, precisamente a causa dei suoi presupposti costituzionali: la libertà e l’uguaglianza, i due pilastri delle concezioni politiche del nostro tempo, che se lasciati liberi di operare fuori di un contesto societario, mettono in moto forze egoistiche produttive di effetti distruttivi della con-vivenza.
Non si può convivere stabilmente in grandi aggregati di esseri umani che nemmeno si conoscono facendo conto solo su patti degli uni con gli altri, come pensano i contrattualisti. A parte ogni considerazione realistica, una volta stabilita una regolazione contrattuale degli interessi in campo, a chi o a che cosa ci si potrebbe richiamare per richiedere l’adempimento degli obblighi assunti, ogni volta che l’interesse mutato spingesse qualcuna delle parti a violarli? Ogni contratto, senza una garanzia terza, sarebbe flatus vocis.
Per molti secoli, questa garanzia era riposta nella religione; oggi, nell’età della secolarizzazione, non può che essere la cultura.
«L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento », dice l’art. 33, primo comma, della Costituzione. Questa norma di principio è da considerare la base della “costituzione culturale”, così come esiste una “costituzione politica” e una “costituzione economica”, ciascuna delle quali contribuisce, per la sua parte, alla costruzione della “tri-funzionalità” su cui si regge la società, secondo quanto già detto. La Costituzione,
senza aggettivi, è la sintesi di queste costituzioni particolari. Innanzitutto, dicendosi che l’arte e la scienza sono libere e che libero ne è l’insegnamento si dà una definizione. L’attività intellettuale non libera, cioè asservita a interessi d’altra natura non è arte, né scienza: è prosecuzione con altri mezzi di politica ed economia. Si dirà, tuttavia: non è arte la scultura di Fidia, perché al servizio della gloria di Pericle? Non è arte la poesia di Virgilio, perché celebrativa della Roma di Cesare Augusto? E non è arte quella di Michelangelo, commissionata da Giulio II e Paolo III? La loro non è arte perché voluta, comandata, perfino imposta da altri, che non l’artista? Naturalmente no. Ma non è arte per la componente priva di libertà, esecutiva del volere del committente; è arte, per la parte che l’artista riserva alla sua libera creazione.
Cose analoghe si possono dire per le opere dell’ingegno al servizio dell’economia, cioè della pubblicità di prodotti commerciali. Anche a questo proposito, l’impasto di attività esecutiva e di attività creativa è evidente. Il rapporto tra l’una e l’altra è variabile. Normalmente, prevale l’aspetto strumentale: far nascere bisogni, orientare il consumo, combattere la concorrenza, promuovere le vendite: tutte cose che riguardano gli stili di vita, le aspettative, i sogni, ecc. In certo senso, formano cultura, e nel modo più efficace possibile. Ma, per questo aspetto, non sono esse stesse espressione della libertà della cultura; sono invece funzione dell’economia. Non rientrano nella definizione costituzionale. Vale anche qui, però, la forza purificatrice del tempo. A distanza d’anni, quando s’è persa la nozione dell’interesse originario, anche le opere di pubblicità possono depurarsi dal loro aspetto strumentale ed essere rivalutate e apprezzate nel loro valore artistico.
Non si tratta, comunque, di teorizzare una “cultura per la cultura”, senza contenuto, come pura evasione. La cultura come cultura ha una sua funzione e una sua responsabilità sociale, come s’è detto: una funzione che esige libertà. Sotto questo aspetto, il verbo “essere” che troviamo nella norma costituzionale assume il significato non d’una definizione, ma d’una prescrizione: “la cultura deve essere libera”. La difficoltà nasce dal fatto che deve essere libera, ma non può vivere isolata.
La prima insidia, qui, sta nella tentazione della consulenza. Il nostro mondo è sempre più ricco di consiglieri
e consulenti e sempre meno d’intellettuali. Questa – del consulente – è la versione odierna dell’“intellettuale organico” gramsciano, una figura tragica che si collegava alle grandi forze storiche della società per la conquista della “egemonia”: un compito certo ambiguo, ma indubbiamente grandioso. I consiglieri di oggi sono gli imboscati nell’inesauribile miniera di ministeri, enti, istituti, fondazioni, aziende, ecc., che si legano al piccolo o grande potere, offrendo i propri servigi intellettuali e ricevendo in cambio protezione, favori, emolumenti. La stessa cosa può ripetersi per i consulenti che vendono le proprie conoscenze alle imprese, per testarne, certificarne, magnificarne e pubblicizzarne i prodotti. Naturalmente, consiglieri e consulenti non sono
affatto cosa cattiva in sé, ma lo sono quando sono essi stessi che si offrono e accettano di entrare “nell’organico” di questo o quel potentato. L’uomo di cultura diventa uomo di compiacenza.
La seconda insidia all’autonomia della funzione intellettuale è la tentazione di cercare il successo in questa, per poi spenderlo nelle altre funzioni. Ciò che è giusto in una sfera, può diventare corruzione delle altre sfere. Così, l’affermazione nella sfera dell’economia non deve essere usata strumentalmente per affermarsi nel campo della politica o in quello della cultura; l’affermazione nella sfera politica non deve essere il ponte per conquistare posizioni di potere nella sfera economica o in quella culturale; l’attività nella sfera culturale non
deve corrompersi cercando approvazione e consenso, in vista di candidature, carriere e benefici che possono provenire dalla politica o dall’economia.
Merita qualche parola anche il binomio “libertà della cultura” e “democrazia”. La società del nostro tempo, dove le conoscenze sono sempre più approfondite e settorializzate; dove, quindi, è inevitabile delegare ad altri la conoscenza che ciascuno di noi, da solo, non può avere: in questa società dove pressoché tutte le decisioni
politiche hanno una decisiva componente scientifica e tecnica, massimo è il bisogno di fiducia reciproca. Per prendere decisioni democraticamente e consapevolmente in campi specialistici, chi non sa nulla deve potersi fidare di chi detiene le conoscenze necessarie. Non in nome della Verità, che non sta da nessuna parte, ma in nome almeno dell’onestà, che può stare presso di noi. Se non ci si potesse fidare gli uni degli altri e, in primo luogo, di coloro che per professione si dedicano a professioni intellettuali, la cultura come indispensabile luogo “terzo” di convergenza e convivenza sarebbe un corpo morto.
Di quali mezzi si avvale oggi la cultura? Semplificando: chat o book? Dov’è la radice della differenza? È nel fattore tempo, un fattore determinante nella qualità di tutte le relazioni sociali. La chat e i suoi fratelli – blog, twitter, social forum, newsgroup, mailing list, facebook, messaggi immediati d’ogni tipo – appartengono al mondo dell’istantaneità; i libri al mondo della durata. I messaggi immediati appartengono alla comunicazione; i libri, alla formazione. La comunicazione vive dell’istante, la formazione si alimenta nel tempo. La comunicazione non ha onere d’argomentazione e non attende risposte. Il suo fine è dire e ridire su ciò che è stato detto, per aderire o dissentire, senza passi in avanti. Il libro – saggio, romanzo, poesia; cartaceo o elettronico – appartiene a un altro mondo. Nasce e vive in un tempo disteso, di studio e riflessione. Se sul bancone d’una libreria incontri
L’uomo senza qualità o Moby Dick, innanzitutto è come se ti chiedessero: sai quanto tempo ho impiegato a essere pensato e scritto? E tu, quanto tempo e quanta concentrazione pensi di potermi dedicare? L’invasione degli
instant books è la conseguenza della medesima risposta a entrambe le domande, rivolte agli autori e ai lettori: poco, molto poco, forse sempre meno tempo e meno concentrazione.
Ma, allora, è chiaro che la sopravvivenza del libro non è una rivendicazione a favore d’una élite di pochi fortunati lettori. La diffusione della lettura non appartiene al superfluo d’una società non solo, com’è ovvio, perché ha a che vedere con la diffusione dell’istruzione. Siamo, infatti, pienamente nel campo della cittadinanza, cioè della condizione di partecipazione attiva, consapevole e responsabile a quanto c’è di più decisivo per la tenuta della compagine sociale, cioè la partecipazione a una delle tre “funzioni sociali”: la funzione politica di fondo, meno visibile ma, in realtà, nel formare mentalità, più determinante della stessa azione politica in senso stretto, la quale, nella prima trova i suoi limiti e i suoi fini. Si tratta, per l’appunto, della cultura.
Difendiamo la Costituzione, i diritti e la democrazia, puoi unirti a noi, basta un piccolo contributo