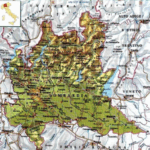DA PELLA a De Gasperi, da Fanfani a Andreotti. Chiunque cerchi precedenti, negli archivi della Storia Repubblicana, non lo troverà. L’Italia vive il passaggio più drammatico del dopoguerra. Abbiamo conosciuto molti «governi d’emergenza », ma non «governi impossibili ». Quello tentato da Pierluigi Bersani, almeno per adesso, lo è. A diradare la nebbia post-elettorale non è bastata una settimana di consultazioni (compresa una presessione con le parti sociali inutile e incomprensibile, se non giustificata dalla necessità di «comprare» tempo o di preparare, senza dirlo, la prossima campagna elettorale).
Nel suo passaggio al Quirinale, il leader del Pd ha dovuto confermare al capo dello Stato l’impossibilità di costruire una maggioranza di legislatura, attraverso la scomposizione e ricomposizione delle tre «minoranze di blocco» uscite dal voto del 24-25 febbraio. Ora il leader del Pd cambia «status ». Da presidente incaricato diventa «presidente congelato». All’anomalia iniziale, quella del «pre-incarico» di venerdì scorso, si somma ora un’altra anomalia, ancora più eclatante: il presidente della Repubblica che scende in campo in prima persona, per verificare se gli ostacoli incontrati da Bersani sono superabili, o se invece si rende necessario cambiare lo schema di gioco, e ovviamente anche il giocatore.
Tutto questo, ancora una volta, conferma ciò che già sappiamo. Viviamo in uno «stato d’eccezione» permanente. E anche stavolta il soggetto che più di tutti lo alimenta e lo esaspera è Silvio Berlusconi. Se il tentativo del leader della coalizione che ha vinto comunque le elezioni è tuttora in stand-by, o verosimilmente fallirà, la responsabilità è del Cavaliere. Del suo avventurismo istituzionale. Del suo titanismo politico. Del suo sfascismo giudiziario. Come ha spiegato lo stesso Bersani al termine del suo colloquio con Napolitano, il suo governo non può nascere non solo perché è limitato numericamente, ma anche perché è ricattato politicamente. Le «condizioni e le preclusioni inaccettabili» poste dal Pdl sono uno scandalo della democrazia. Pur essendo arrivato terzo alle elezioni (con un collasso di 6,5 milioni di voti persi) il Cavaliere si siede alla sua maniera al tavolo della trattativa, cioè con la rivoltella in mano. Pretendendo la poltrona del Quirinale per sé o per Gianni Letta. Subordinando ancora una volta i suoi bisogni personali e processuali agli interessi del Paese. Giocando ancora una volta al tanto peggio tanto meglio: se la minaccia funziona, bene. Altrimenti si torna subito a votare, e lui o vince l’intera posta, o tutt’al più pareggia di nuovo, avendo guadagnato nel frattempo altri mesi preziosi per fuggire dai tribunali.
Detto questo, bisogna essere onesti fino in fondo. Le malefatte politiche dello Statista di Arcore spiegano molto, della rovinosa palude italiana. Ma non bastano a spiegare il «congelamento» di Bersani. Quel «sostegno parlamentare certo» che Napolitano gli aveva chiesto una settimana fa, il segretario non l’ha trovato. E che finisse così era chiaro già dal 26 febbraio. Il leader del Pd aveva due strade. Una più rischiosa dell’altra. La prima strada implicava un viaggio a fari spenti nella notte di Gaia, cioè il tentativo di far convivere dentro una stessa piattaforma programmatica le idee della sinistra neo-progressista e i sogni del grillismo web-populista. La seconda strada comportava una corsa alla luce del sole verso la tana del giaguaro, cioè il tentativo di far coesistere dentro una formula politica da inventare l’istanza legalitaria del Pd e la renitenza giudiziaria di Berlusconi. Per motivi profondamente diversi, due vie già in partenza ugualmente improbabili, se non impercorribili.
Da una parte, come si poteva e si può immaginare un’alleanza con Grillo e Casaleggio, che teorizzano «un Parlamento senza i partiti» e puntano al raggiungimento del «100% dei suffragi» e poi all’autoscioglimento? Cosa si poteva e si può costruire, anche solo sul piano delle singole leggi da approvare, con un leader dispotico e un guru carismatico che mentre stai negoziando ti danno della «mummia» o del «padre puttaniere»? Bersani ci ha provato, per troppi giorni e persino al di là di ogni ragionevole misura, tentando di rispettare la promessa di un «governo da combattimento». Ci ha provato con gli otto punti di programma tagliati inutilmente e tardivamente a misura dei grillini. Con l’elezione a sorpresa degli «alieni» Boldrini e Grasso ai vertici di Camera e Senato. Con il rito umiliante delle consultazioni in streaming. Ma è stato tutto inutile. In cambio ha ottenuto solo insulti e irrisioni. Era prevedibile. Ma allora, prima di avventurarsi su questa strada, sarebbe stato opportuno sondare meglio il terreno. E verificare se esisteva una vera «faglia» interna, dentro un «non-partito» che nel suo «non statuto» prevede espressamente il rifiuto pregiudiziale di qualunque alleanza o coalizione con altre forze politiche.
Dall’altra parte, come si poteva e si può immaginare un accordo con Berlusconi e Alfano, che invocano da un mese la salvifica Grande Coalizione, dopo averne «assassinato» tre mesi prima l’unica prova esistente, cioè il governo Monti? Cosa si poteva e si può costruire, anche solo sul piano delle riforme istituzionali e costituzionali, con un Pdl che scende in piazza contro la magistratura e con un Cavaliere che per trattare pretende per se stesso il Quirinale? Anche qui, Bersani ci ha provato, per una settimana e con qualche ambiguità bizantina da Vecchia Repubblica, tentando di rispettare il «preambolo » auto-imposto del no a un esecutivo di «larghe intese». Ci ha provato con la formula del «doppio binario». Con l’offerta della presidenza della «Convenzione» per le riforme ad Alfano. Con l’escamotage delle «tecniche parlamentari creative» suggerite da Enrico Letta e ventilate da Roberto Calderoli, dall’uscita dall’aula al momento del voto di fiducia alla diserzione vera e propria grazie ai certificati medici fasulli.
Ma di nuovo, è stato tutto inutile. In cambio ha ottenuto solo l’accusa (ridicola e immeritata) di voler «occupare militarmente le istituzioni », formulata proprio da chi pur avendo perso le elezioni rivendica il Colle. Anche in questo caso, era prevedibile. Ma allora, prima di spingersi su questa strada, bisognava (e bisogna tuttora) dirimere una questione di fondo, in modo trasparente e unitario. Il Pd è in grado di dire inequivocabilmente e definitivamente no a qualunque forma di «intelligenza col nemico», respingendo al mittente i veti e i ricatti, senza subire la defezione dei renziani, dei dalemiani, dei veltroniani e di chissà chi altri? Oppure, all’opposto: il Pd è in grado di sopportare una stampella parlamentare del Pdl, cedendo pezzi della sua sovranità e della sua «verginità», senza patire la balcanizzazione del suo apparato e la diserzione del suo elettorato?
Questi nodi restano ancora tutti aggrovvigliati, sul tavolo del leader del Pd e soprattutto su quello del capo dello Stato. Comunque vada questo ulteriore «giro di giostra», una cosa è chiara a tutti. Entro stasera, al termine del nuovo ciclo di consultazioni sul Colle, il Paese ha bisogno di conoscere il suo destino. Di sapere se c’è un premier incaricato, un nuovo «governo del presidente», quali saranno la sua missione e la sua maggioranza. Oppure se non c’è nulla di tutto questo, e si dovrà tornare a votare «sotto la canicola», dopo aver già votato «sotto la neve». Ma non prima di aver affrontato il passaggio-chiave, critico e propedeutico allo scioglimento delle Camere: l’elezione del successore di Napolitano, che a questo punto potrebbe avvenire in un Parlamento trasformato in un Vietnam, dove Pd-Sel e Scelta Civica avrebbero comunque i numeri per far passare un proprio candidato. Mentre a Roma si discute di tutto questo, lo spread schizza oltre quota 350, i rendimenti all’asta dei Btp si impennano e la Borsa cede. È la prova che la tregua concessa all’Italia dai mercati sta finendo. Una Pasqua con la «sede vacante» sarebbe un suicidio. La Chiesa cattolica l’ha evitato. La Repubblica italiana non ancora.