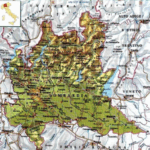Sulle relazioni fra sapere tecnico e azione di governo nell’Italia di inizio millennio
Sulle relazioni fra sapere tecnico e azione di governo nell’Italia di inizio millennio
1. – Signore, signori,
si noterà che ho dato alla mia prolusione un titolo alquanto giornalistico (sebbene temperato da un sottotitolo più accademico).
C’è una ragione, ed è che il tema rimanda alle cronache di oggi, qui. In questa Italia a cavallo fra anno 2011 e anno 2012, che cosa accade sulla scena pubblica, sulla scena del governo? Come mai questa scena si popola di protagonisti atipici e inusuali – i professori? Come mai i tradizionali protagonisti – i politici di professione, i partiti – appaiono relegati sullo sfondo? E quali prospettive, quali sviluppi questa situazione ci promette per il futuro?
Una simpatica coincidenza vuole che queste domande si pongano in presenza di qualcuno che incarna alla perfezione il fenomeno che esse vogliono indagare: Francesco Profumo, professore e ministro. A lui potremmo dire – come dato che rende ancora più significativo il suo essere qui –: ministro Profumo, professor Profumo, de te fabula narratur.
2. – E’ dunque una favola dei nostri giorni. Che però non può essere efficacemente narrata se non si fa – come in ogni buon romanzo d’appendice – un passo indietro. Recuperando per un minimo quella prospettiva storica, senza la quale è difficile decifrare il presente e ancor più difficile immaginare il futuro.
A chi osserva che con il governo Monti i professori si fanno protagonisti dell’azione di governo, e dunque della politica, potrebbe infatti obiettarsi che questa non è una novità: di professori che fanno politica, in parlamento e nel governo, sono piene la storia e la cronaca, vicina e lontana, del nostro paese. Ma qui bisogna applicare l’arte della distinzione, e cogliere i diversi – o anche diversissimi – modi in cui il fenomeno si è presentato in passato, rispetto alle caratteristiche della vicenda che adesso è sotto i nostri occhi.
Aldo Moro, ordinario di diritto penale, o Antonio Segni, ordinario di procedura civile, o Giovanni Leone, ordinario di procedura penale, erano professori impegnati in politica (che come tali si trovarono a svolgere importantissimi ruoli istituzionali: dal governo alla presidenza della Repubblica). Ma il punto è che essi erano organicamente impegnati in politica: erano capi di partito; e agivano sulla scena politica in quanto tali, non in quanto professori. Il loro essere professori era una qualità accessoria, e perfino marginale o addirittura irrilevante, della loro azione pubblica.
In tempi più vicini a noi, incontriamo una seconda generazione di politici–professori, o professori–politici, che incarnano una tipologia molto diversa. Personaggi come Stefano Rodotà, o come Giuliano Amato, o come un altro Giuliano – il politologo Urbani – o ancora come Tiziano Treu o come lo stesso Romano Prodi non sono mai stati propriamente leader politici e nemmeno politici di professione, e il loro essere professori era una componente decisiva della loro immagine pubblica, della loro presenza politica, del loro ruolo di governo: erano, come suol dirsi, professori “prestati” alla politica.
Ma “prestati” come? per quale via? Per quella che a me sembra possa definirsi la via della cooptazione subalterna. La loro immagine, la loro presenza, il loro ruolo pubblico erano per così dire octroyés, “concessi” da un sistema politico–partitico ancora sicuro di sé, che in vario spirito – ora per lungimiranza ora per calcolo di convenienza, ora con entusiasmo ora con degnazione talora perfino con un po’ di fastidio se non di disprezzo – acconsentiva a cooptarli. Talora quel sistema permetteva ai professori di stare in prima linea sulla scena, giocando ruoli anche di grande visibilità pubblica: ma la regìa era ancora – più o meno saldamente – nelle mani dei partiti e dei politici di professione.
3. – Quanto diversa, oggi, la posizione del prof. Monti, del prof. Profumo, della Prof.ssa Fornero, del prof. Giarda, del prof. Balduzzi, del prof. Ornaghi e dei loro colleghi di accademia e di governo!
Questi professori–politici di terza generazione non sono cooptati dal tradizionale sistema politico–partitico, ma piuttosto subìti da esso. Non sono chiamati sulla scena pubblica a giocare ruoli di cui le tradizionali strutture del potere pubblico conservano la regia; bensì fanno irruzione sulla scena pubblica senza il permesso né forse il gradimento di chi un tempo era o si pensava il dominus della politica e dell’azione di governo – cioè appunto i partiti, manovrati dai politici di professione. E quindi è inevitabile che il loro ruolo sia ben diverso da quello dei professori–politici delle generazioni precedenti; e diverso il rapporto con il sistema dei partiti. In breve: non semplici consiglieri del principe, ma in qualche modo principi essi stessi.
Con la conseguenza di un curioso rovesciamento della consueta dinamica relazionale fra tecnici di supporto alla politica e politici di professione: una volta i politici di professione consultavano, ascoltavano i tecnici (se e quando si degnavano di farlo); e poi decidevano. Oggi accade qualcosa che assomiglia all’inverso: i tecnici al governo consultano, ascoltano i politici di professione; ma poi decidono loro. L’immagine è quella di Alfano, Bersani, Casini convocati da Monti a Palazzo Chigi e interrogati su cosa ne pensino dei provvedimenti che il governo intende varare; al che qualcuno fra loro consiglia di non andarci troppo pesante con la patrimoniale o di essere clemente con i taxisti, e qualcun altro suggerisce di non esagerare con la manovra sulle pensioni o di usare molta cautela nella riforma del mercato del lavoro: ma alla fine decide Monti con i suoi ministri, senza necessariamente adeguarsi (più che tanto) agli input dei capipartito.
4. – E’ tutto questo una lesione della democrazia? della sovranità popolare? La risposta deve essere forte e chiara: no, assolutamente no.
La sovranità popolare si esercita – dice il primo articolo della Carta costituzionale – “nelle forme e nei limiti della Costituzione”. Questi limiti e forme definiscono le procedure della democrazia, che fanno tutt’uno con la democrazia stessa. E le procedure della democrazia sono state rigorosamente rispettate nella genesi e negli sviluppi del governo Monti: si è registrata la dissoluzione della precedente maggioranza di governo; si è constatata la possibilità che un governo con differenti caratteristiche fosse sostenuto dalla maggioranza del Parlamento; si è attribuito l’incarico di formarlo; la persona incaricata ha scelto i suoi ministri, e ha presentato il governo così formato al Parlamento, che con ampia maggioranza gli ha votato la fiducia. E’ dunque chiaro che se qualcuno strepita alla democrazia violata, ciò si deve solo a ignoranza o a malafede.
Domandiamoci ancora: è tutto questo un trionfo della non politica, o addirittura dell’antipolitica? La risposta è, nuovamente, no. Intanto perché in questo processo la politica, intesa come sistema dei partiti, ha avuto un ruolo fondamentale: senza la sua decisione di sostenere in Parlamento il governo Monti, nessun governo Monti sarebbe nato. Ma soprattutto perché il governo Monti è oggettivamente politico, nella stessa misura in cui fa politica; e fa oggettivamente politica nella stessa misura in cui governa il paese. Qualunque cosa ne pensino i suoi stessi protagonisti, che certo non sono politici di professione. Valgono le parole di Thomas Mann nelle sue Considerazioni di un impolitico (quel libro che Claudio Magris definisce “sbandato e fallito, ma grandioso e travolgente”, un libro fatto di pensieri che “irritano, stancano, intasano, aggrediscono e urtano senza riguardi”). Dice Mann: “la politica è una forza terribile: basta solo sapere che esiste, e già ci si è dentro, si è perduta per sempre la propria innocenza”.
Chiarito che l’esperienza in atto non è né antidemocratica né antipolitica né apolitica, è altrettanto chiaro che la situazione risulta – dal punto di vista politico–istituzionale – alquanto anomala, cioè non “normale”, bensì “strana”, per usare l’aggettivo che lo stesso prof. Monti ha ritenuto di applicare al governo che egli presiede.
5. – L’esperienza insegna che le stranezze arrivano quando la normalità non regge più. E a questa “strana” situazione siamo arrivati, proprio perché la “normalità” delle vecchie tradizionali dinamiche politico–partitiche ha dimostrato, alla fine del 2011, di non reggere più, presa nella tenaglia di due fattori.
Un fattore congiunturale: la crisi economico–finanziaria dell’estate/autunno scorsi, con quel micidiale mix fra tassi di crescita bassi o negativi, e gli altissimi, insostenibili tassi di interesse sul nostro debito sovrano, che ci ha portati sull’orlo del default. Una crisi che esigeva misure immediate e molto forti che il governo precedente, ma più in generale il sistema politico–partitico che lo esprimeva, non era in grado di prendere: mentre il governo Monti le ha prese e le sta prendendo. Ed esigeva un recupero di credibilità internazionale, che il vecchio governo e la vecchia politica si dimostravano incapaci di garantire: mentre il governo Monti in poche settimane ci è riuscito (“Italy is back”: con quanto sollievo sentiamo adesso questa formula risuonare nelle cancellerie e nelle opinioni pubbliche d’Europa!).
Dicendo questo, si introduce il secondo fattore – più strutturale: la terribile debolezza del nostro sistema politico, che a questo drammatico passaggio della storia nazionale (ed europea) arriva estenuato, impotente, afasico. E in una situazione come questa, la competenza tecnica appare l’unica risorsa capace di surrogare efficacemente, o almeno decentemente, il palese deficit della politica; se c’è qualcuno che appare titolato a prendere il posto dei politici professionali, ebbene questo è il corpo dei professori.
6. – C’è a ben vedere qualche precedente, anche perché la malattia del sistema politico–partitico in Italia non è una malattia di oggi. E’ in incubazione da tanto tempo, e già in passato ha conosciuto episodi acuti. Facciamo un flashback di 20 anni, andiamo con la mente all’inizio degli anni 90. Tangentopoli, Mani pulite. Si dissolve la Democrazia cristiana, così come pochi anni prima si era dissolto (o quanto meno trasfigurato) il Partito comunista italiano. Entrano in scena nuove formazioni politiche, ispirate a logiche abbastanza inedite di populismo e localismo. Insomma crollano i pilastri del vecchio ordine politico. Finisce la prima Repubblica. Si apre in modo confuso e incerto la seconda. Tutto questo in una gravissima crisi finanziaria e valutaria, segnata da un durissimo attacco contro la nostra moneta nazionale – scatenato da George Soros, oggi filantropo, allora squalo della finanza.
Crisi politica, crisi economico–finanziaria: gli stessi ingredienti che si ripropongono 20 anni dopo, cioè oggi. E una soluzione che in qualche modo somiglia a quella di cui oggi parliamo. A guidare il governo nato per fronteggiare quella difficilissima congiuntura chi troviamo, nel giugno 1992, se non un professore? Parlo di Giuliano Amato, figura anfibia e di raccordo fra politica e non politica, figura che giocava la componente “professorale” come fattore decisivo del ruolo di governo che era chiamato a svolgere. E in quel governo Amato 1 (giugno 1992 / aprile 1993) non mancavano certo gli accademici: economisti come Franco Reviglio, Beniamino Andreatta, Piero Barucci; giuristi come Giuseppe Guarino; medici come Adriano Bompiani.
E quando il governo Amato cade dopo neppure un anno, chi è il capo del nuovo governo, insediato nell’aprile 1993? Carlo Azeglio Ciampi. Non un accademico in senso stretto (anche se un tratto caratteristico della sua figura pubblica, da lui stesso sempre rivendicato con puntiglio, è la sua esperienza giovanile all’interno di una venerabile istituzione accademica come la Normale di Pisa). Ma certamente un tecnico di altissimo standing, come può esserlo un governatore di Bankitalia. E certamente, comunque, non un politico di professione (anzi, neppure un parlamentare: caso unico, nella storia repubblicana, di capo del governo scelto al di fuori del Parlamento; lo stesso Monti diventa presidente del Consiglio quando è, sia pure da pochi giorni, Senatore della Repubblica). Ma soprattutto Ciampi presiede il governo in assoluto più accademico, più pieno zeppo di professori, che l’Italia abbia sperimentato. Entro in apnea, e dico d’un fiato i nomi dei ministri accademici presenti nel governo Ciampi fra aprile 1993 e aprile 1994: Beniamino Andreatta, Augusto Barbera, Paolo Barile, Luigi Berlinguer, Sabino Cassese, Umberto Colombo, Giovanni Conso, Leopoldo Elia, Ombretta Fumagalli, Franco Gallo, Gino Giugni, Livio Paladin, Luigi Spaventa, Vincenzo Visco.
Questo stesso schema – per cui quando la politica va in tilt, la competenza tecnica sembra presentarsi come l’unico fattore degno di surrogarla nella funzione di governo della società – lo ritroviamo, in quel medesimo giro di anni, nel microcosmo della RAI malata di lottizzazione: a quella che con ragione si chiamava la “RAI dei partiti” succede nel 1993 quella che fu chiamata la “RAI dei professori”, con un consiglio di amministrazione fortemente accademico, presieduto dal bocconiano prof. Claudio Demattè.
7. – Oggi il governo Monti appare l’erede di quello schema, ma lo ripropone per così dire all’ennesima potenza, imprimendo al processo di accademizzazione della politica, avviato 20 anni fa nei modi appena visti, un’intensificazione radicale, un drammatico salto di qualità rispetto ai governi pur accademici di Amato e Ciampi.
In che senso, lo si è detto. Quei governi erano pur sempre figli dei partiti, nascevano da dinamiche interne al sistema dei partiti, vivevano sugli equilibri di quel sistema. Perché ancora all’inizio degli anni 90, ancora sullo scorcio del secolo, ancora nel primo decennio di questi anni 2000, i partiti – sia quelli vecchi, più o meno rinnovati; sia quelli del tutto nuovi – pretendevano il controllo dell’azione di governo: anche se sempre meno risultavano in grado di esercitarla con forza, con efficacia, in modi orientati all’interesse generale.
Ma verso la fine del 2011, di fronte all’incalzare della crisi economico–finanziaria e all’evidente inadeguatezza dell’azione pubblica diretta a contrastarla, qualcuno dice: il re è nudo. Nasce così il governo Monti, affrancato – a differenza dei governi professorali degli anni 90 – dal sistema dei partiti. Affrancato non nel senso che la sua sopravvivenza non dipenda dalle scelte dei partiti che in Parlamento lo sostengono: questi, staccando la spina (come suol dirsi con espressione deplorevole) hanno il potere di mandarlo a casa. Ma affrancato nel senso che esso è nato, programmaticamente, per governare a prescindere dai partiti, cioè dai mix di interessi, dagli equilibri, dalle mediazioni che i partiti esprimono nella ricerca del consenso elettorale. E i partiti che lo sostengono sembrano accettare questa deminutio, rinunciando in questa fase, per la prima volta, a essere protagonisti della politica. Ecco il salto di qualità.
8. – Ma che i partiti non siano protagonisti della politica è una cosa di per sé non buona.
La politica è necessaria alla società, perché la società ha bisogno di essere governata razionalmente, e la politica è appunto tecnica o scienza o arte del governo razionale della società. E alla politica sono necessari i partiti, è necessario il protagonismo dei partiti: non tanto perché lo dice la Costituzione, all’art. 49; quanto soprattutto perché lo dice l’esperienza delle cose, quale si registra ovunque nel mondo moderno (o almeno nelle parti di esso che vivono all’insegna della democrazia).
Dobbiamo forse pensare che il governo Monti vada in direzione antagonista a questo bisogno di politica, a questo bisogno di partiti? No, tutto al contrario. Esso risponde al bisogno di politica, perché come ho già detto fa politica – cioè governa la società italiana – in un momento in cui i partiti non sembrano in grado di farlo con altrettanta efficacia; e così facendo non asseconda bensì contrasta le tendenze dell’antipolitica, che invece sarebbe pericolosamente alimentata dalla permanenza, al centro della scena, di partiti oggi incapaci di buona politica. Inoltre questo governo appare opportunamente consapevole che i professori non sono, non possono essere né il futuro né tanto meno l’orizzonte ultimo della politica in Italia. Perché questo ruolo appartiene, di diritto, non ai professori ma ai partiti: che devono però rimettersi, di fatto, in condizione di svolgerlo in modo corretto ed efficace.
Ecco allora che questa fase di governo dei professori può essere vista e vissuta come una fase di transizione, in cui i partiti fanno un passo indietro, ma solo per riprendere slancio verso il necessario recupero della capacità, oggi offuscata, di essere protagonisti della politica – della buona politica: una specie di purgatorio, diciamo. In questo tragitto possono imparare qualcosa di utile, guardando come si sviluppa l’azione di governo dei professori: i quali – conformemente alla loro vocazione didattica – qualcosa di utile possono insegnargli. Diciamo che i partiti farebbero bene a prendere questo passaggio in purgatorio come una specie di master da frequentare con diligenza per assorbirne competenze, know–how, stili di comportamento e di linguaggio, tutt’altro che inutili in vista di una rigenerazione della loro capacità di politica e di governo. Un’occasione da non sprecare.
Considero un’eventualità così remota da non doverla evocare neppure come deprecabile ipotesi, il prodursi del fenomeno inverso. Che cioè, anziché essere il governo dei professori a inoculare benefici anticorpi nell’organismo malato della politica, contribuendo a risanarlo, sia invece il vecchio sistema politico–partitico a contagiare di qualche suo vizio la nuova esperienza in corso, e i suoi protagonisti. Vogliamo pensare che non accadrà. Che in questo caso sarà la moneta buona a scacciare la cattiva, e non l’opposto.
9. – In questo scenario, due cose sembrano ragionevolmente certe.
La prima è che il governo dei professori è, come ho appena detto, un’esperienza a termine. Il termine grosso modo si conosce, perché è il tempo residuo della legislatura: un anno o poco più (che per l’appunto è il tempo standard di un master). E questo vale, direi, sia che Monti e i suoi ministri tecnici escano di scena; sia che restino in qualche modo sulla scena anche dopo il 2013, come qualcuno comincia a immaginare: perché in quel caso resterebbero in scena sulla base di un rapporto con la politica profondamente diverse da quello che li ha accompagnati al governo nel novembre del 2011.
La seconda cosa si riassume in una formula ricorrente nella pubblicistica fiorita intorno al governo Monti: dopo questo governo “nulla sarà più come prima”. Ciò significa che potrà essere meglio di prima, ma anche peggio di prima. Sarà meglio di prima, se il sistema politico, i partiti sapranno emendarsi e diventare protagonisti di pratiche virtuose al posto delle pratiche viziose a cui purtroppo ci hanno abituati. Ci potranno arrivare per virtù propria, trovando in sé stessi una capacità di autorigenerazione. Ma più realisticamente potranno arrivarci per pressioni o stimoli o aiuti provenienti dall’esterno: e fra questi ci metto anche la buona didattica dei professori del governo Monti. Bisogna però sapere che potrà essere anche peggio di prima. E sarà così, se il sistema politico–partitico non avrà questa capacità, e continuerà a crogiolarsi nei vecchi vizi. Con prospettive che spaventano: il dilagare del populismo, del qualunquismo, dell’antipolitica (ma ancora il Thomas Mann delle Considerazioni di un impolitico ammonisce: “l’antipolitica è anch’essa una politica”).
Si delineano dunque due alternative. Le persone di buon senso e di buoni sentimenti, in Italia e in Europa, fanno naturalmente il tifo per la prima, e guardano con molta preoccupazione alla seconda, la quale fa tutt’uno con il rischio che la politica e la vita pubblica si riducano davvero, nel nostro paese, a un campo di macerie. Ma nessuno può dire se prevarrà la prima o la seconda.
Questa incertezza, e diciamo pure questi timori, circa i possibili sbocchi dell’esperienza in corso, trovano un termometro sensibile nella risposta dei mercati alla domanda di credito che in questa fase lo Stato italiano rivolge agli investitori. Una risposta a forbice divaricata (anche se la divaricazione per fortuna tende da ultimo ad attenuarsi): tassi bassi per le emissioni di debito pubblico a sei mesi/un anno; tassi molto più alti per le emissioni a più lungo termine. Dove il messaggio è eloquente: nel breve periodo, finché c’è il governo dei professori, il rischio Italia si percepisce come contenuto, e chi lo corre si accontenta di una piccola remunerazione; ma dopo chissà…, nella percezione dei mercati il dopo Monti appare avvolto in un’incertezza gravida di rischi, e chi accetta di prenderli se li fa pagare cari.
10. – Eppure vorrei sforzarmi di cogliere un motivo di speranza, di fiducia in un esito positivo di questa vicenda italiana. E non faccio troppa fatica a trovarlo, perché è sotto gli occhi di tutti.
Chi ha il merito congiunturale di avere afferrato l’Italia sull’orlo del baratro finanziario per affidarla a mani capaci di evitarle il precipizio? E il merito più strutturale di avere avviato una possibile transizione verso l’auspicato risanamento del sistema politico italiano? In breve: chi ha inventato, chi ha costruito il governo Monti? Nessun dubbio sulla risposta: il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. La vicenda che stiamo commentando è una sua creazione, e riflette uno straordinario mix di professionalità politico–istituzionale e insieme di fantasia (ma oserei dire perfino di genialità) politico–istituzionale; una performance che ha combinato in modo strepitoso da un lato realismo, abilità nel leggere la congiuntura, per affrontarla con prontezza di riflessi; e dall’altro lato grande capacità di vision proiettata al futuro.
Ebbene: chi è Giorgio Napolitano se non, a pienissimo titolo, un figlio di quello stesso vecchio sistema politico–partitico che ha retto le sorti del nostro paese per tutto il corso della storia repubblicana, che da tempo è entrato in crisi, e che adesso sembra giunto a un tornante decisivo? Nella prova che egli ha dato – di disponibilità ad andare oltre la tradizione cui egli stesso appartiene, di determinazione e coraggio nell’aprire a orizzonti così nuovi e in buona misura sconosciuti – voglio vedere un segno di speranza, un segno di fiducia che il cambiamento di cui abbiamo bisogno è possibile, e ci sarà.
11. – Concludo.
Il libro di Thomas Mann, a cui appartengono le parole che ho prima citato, è del 1918. In quel medesimo anno un altro grande spirito tedesco (certo meno complesso e profondo dell’autore dei Buddenbrook della Montagna magica, ma pur sempre uno spirito grande) – parlo di Max Weber – scrive due piccoli testi gemelli: “La scienza come professione“ e “La politica come professione” (anche se “professione” è termine riduttivo, perché la parola dell’originale tedesco – “Beruf” – incorpora un doppio significato: “professione”, ma insieme anche “vocazione”). Due testi che davvero non è pretestuoso richiamare qui: sia per la loro evidente pertinenza tematica al discorso che si sta svolgendo; sia perché generati da un’occasione squisitamente accademica, visto che essi riproducono due lezioni/conferenze che Max Weber rivolse nell’autunno del 1918 agli studenti dell’Università di Monaco.
Ebbene, le parole che chiudono il secondo dei due scritti mi sembrano andare al cuore del nostro problema, che è essenzialmente – diciamolo, infine – problema di natura e qualità del ceto politico: “La politica consiste in un lento e tenace superamento di dure difficoltà, da compiersi con passione e intelligenza al tempo stesso. E’… confermato da tutta l’esperienza storica, che il possibile non verrebbe raggiunto se nel mondo non si ritentasse sempre l’impossibile. Ma colui il quale può accingersi a questa impresa deve essere un capo, non solo, ma anche – in un senso molto sobrio della parola – un eroe. E anche chi non sia né l’uno né l’altro, deve forgiarsi quella tempra d’animo tale da poter reggere anche al crollo di tutte le speranze… Solo chi è sicuro di non venire meno anche se il mondo, considerato dal suo punto di vista, è troppo stupido e volgare per ciò che egli vuole offrirgli, e di poter ancora dire di fronte a tutto ciò: ‘Non importa, continuiamo!’, solo un uomo siffatto ha ‘Beruf’ per la politica”.
Grazie.
* Vincenzo Roppo fa parte del coordinamento di LeG Genova ed è professore ordinario di Diritto civile nell’Università di Genova. Il testo della prolusione pronunciato sabato 3 marzo alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2011/12 dell’Università di Genova