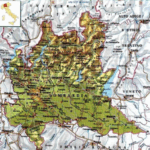Negli ultimi due giorni gli italiani – e in particolare la classe politica italiana – sono stati sottoposti a quello che si può definire uno choc da globalizzazione; e complessivamente non hanno gradito. La globalizzazione, però, pur con alti e bassi, resta e l’Italia – che agli italiani piaccia o no – è costretta a viverci dentro, nel senso che il Paese, come parte dell’Europa, deve guadagnarsi il pane in un mondo globalizzato vendendo i suoi prodotti in competizione con altri Paesi per acquistare nel resto del mondo ciò di cui ha bisogno.
E’ questo il senso del «ciclone Marchionne», ossia della risposta alle dichiarazioni dell’amministratore delegato della Fiat (e dell’americana Chrysler) nel corso di un programma televisivo domenicale e delle amplissime ripercussioni che hanno riempito la giornata politica di ieri.
Marchionne non è certo un diplomatico e ha detto, con la chiarezza un po’ rude che caratterizza i nove decimi dell’umanità, cose assolutamente vere e sgradevoli che gli italiani in cuor loro già sanno ma spesso preferirebbero non sentire: che l’Italia è diventata un Paese inefficiente e non competitivo, che l’organizzazione del lavoro permette in certi casi l’assenteismo di massa, che le fabbriche italiane della Fiat non contribuiscono neppure per un euro all’utile del gruppo.
Con un raro miracolo Marchionne è così riuscito a mettere quasi tutto il mondo politico d’accordo in un rigetto viscerale. Il presidente della Camera Gianfranco Fini ha dichiarato che si vede che Marchionne è più canadese che italiano; Pierluigi Bersani, segretario del Pd, ha detto che non possiamo diventare cinesi; il ministro del Lavoro Maurizio Sacconi ha affermato che l’Italia sta già facendo quello che deve fare; il leader di Italia dei Valori Antonio Di Pietro ha definito «offensive» e «indegne» le parole di Marchionne; Nichi Vendola, portavoce nazionale di Sinistra Ecologia e Libertà, l’ha invitato a fare autocritica e ha accusato la Fiat di non aver prodotto niente di innovativo.
In vario modo e con varie sfumature, buona parte dell’Italia ufficiale si autoassolve, non argomenta, al massimo ricorda pesantemente gli aiuti dello Stato alla Fiat, che peraltro sono stati un fattore comune della politica industriale dei Paesi ricchi durante la crisi degli ultimi due anni, in Italia sono stati inferiori alla media europea e comunque hanno riguardato tutte le auto vendute in Italia e non solo quelle qui fabbricate. Ci si è rifugiati in un’italianità di maniera, come i bambini convinti che il mondo esterno smetta di esistere se loro chiudono gli occhi.
Da quasi tutte le parti si è preferita l’invettiva, più o meno aperta, alla discussione. E’ mancato, insomma, un confronto critico. In particolare, in un caso purtroppo non infrequente di «cecità mediatica» che distrugge le sfumature delle notizie, si sono del tutto trascurate le parti «positive» dell’intervento del leader della Fiat che, tutto sommato, dovrebbero sembrare interessanti come la promessa (l’impegno?) di investimenti cospicui, di salari a livello europeo, di un rilancio a livello mondiale.
Marchionne può aver esagerato puntando i suoi riflettori soltanto sulle fabbriche italiane, trascurando il «cervello» della Fiat che continua a essere italiano in misura molto larga: centri di ricerca, progettazione, uffici che si occupano di strategia, amministrazione, programmazione e quant’altro certamente contribuiscono – e molto – agli utili aziendali. Ha però messo il dito sulla piaga quando ha segnalato il divario di produttività con gli altri Paesi; la causa da lui indicata – essenzialmente il sistema di relazioni industriali che non permette di trarre dalle fabbriche tutte le loro potenzialità – può non essere l’unica ma dovrebbe costituire l’oggetto di una discussione pacata e attenta. Altri possibili motivi di ritardo, legati al territorio, all’apparato legislativo, alla tassazione non andrebbero trascurati. Lo stesso ruolo dell’azienda può essere serenamente oggetto di discussione; ma proprio la serenità è la parola chiave, ed è proprio la serenità che pare mancare oggi. Per cui il tono delle discussioni si alza e la loro qualità si abbassa.
E intanto, per parafrasare Einaudi, gli imprenditori votano con i piedi. La Stampa ha documentato recentemente la migrazione di centinaia di «aziendine» non già verso Paesi dalla manodopera mal pagata ma verso nazioni vicine all’Italia, come la Svizzera. Molte imprese medie e medio-grandi, pur mantenendo in Italia il loro centro sviluppano all’estero le iniziative nuove. E questo non per «fuggire» ma perché, in caso contrario, andrebbero rapidamente fuori mercato. Di tutto ciò occorre che il Paese prenda atto e discuta con sobrietà.