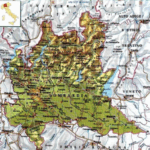Se tutto cambia intorno a noi, nel mondo dell’informazione, cambia anche in qualche modo il rapporto tra il cittadino e la democrazia? Questa è la domanda fondamentale che abbiamo davanti, negli anni che segnano una fantasmagorica moltiplicazione delle centrali informative, un declino della carta stampata, una marcia inarrestabile di internet, una pubblica opinione frantumata nei siti di riferimento, orientata dai blog, raccolta dalle nuove comunità dei social network. Tutto cambia, meno un punto, che resta fisso e uguale: l’informazione è un diritto dei cittadini, l’informazione è una funzione della democrazia.
Secondo alcuni studiosi – e cito per tutti Robert Dahl – per una buona democrazia non è sufficiente la cittadinanza, perché è più utile una “cittadinanza illuminata”, composta da soggetti informati e dunque consapevoli, anzi consapevoli proprio perché informati. Tutti siamo uguali come cittadini, ovviamente e per fortuna. Ma solo un cittadino che possieda l’informazione necessaria per comprendere i fenomeni può davvero dar vita a quell’elemento delicatissimo e indispensabile delle democrazie occidentali che si chiama pubblica opinione. Se il cittadino non è consapevole, non abbiamo davanti una pubblica opinione, ma il senso comune, che è una cosa completamente diversa dal punto di vista della fisiologia di una società democratica, e anche dal punto di vista del rapporto tra cittadinanza e potere.
Negli ultimi vent’anni la crescita dell’informazione è stata esplosiva in termini di quantità, e questo è un valore in sé, perché si accompagna ad una maggiore facilità di accesso, ad una moltiplicazione delle fonti, ad una realizzazione concreta del pluralismo.
Ma se la quantità dell’informazione è importante, fondamentale è anche la qualità, anzi un tipo particolare di qualità, che aiuta a distinguere, a capire, a giudicare: vale a dire l’informazione organizzata. Cioè un’informazione inserita su una scala ampia di riferimenti in modo da rendere visibili non solo i protagonisti, ma anche gli interessi che li muovono, mettendo in relazione questi interessi con l’interesse generale, recuperando gli antecedenti, proiettandosi sulle conseguenze, prendendosi la responsabilità finale di un commento. Insomma, ridisegnando per il lettore il contesto generale in cui la vicenda si muove. Partendo da un fatto, che scorre “nudo” sugli schermi di internet – imbattibile per velocità e contemporaneità – o sul video della tv o sulle onde della radio, il giornale lo organizza restituendo al lettore un paesaggio complessivo di comprensione e di riferimento. Crea quindi un vero e proprio sistema informativo che offre al cittadino-lettore la possibilità di farsi una sua mappa della vicenda, che lo porterà attraverso la lettura ad un suo autonomo e compiuto giudizio finale.
Questo passaggio è lo scarto tra conoscere e sapere, tra guardare e vedere, tra essere informati ed essere consapevoli, al punto da potersi infine assumere la responsabilità di un’opinione personale motivata: che naturalmente può non coincidere con l’opinione del giornale, perché non è questo lo scambio tra un quotidiano e i suoi lettori, non è questa la sua funzione.
Lo scambio è nella qualità dell’informazione fornita al cittadino per favorire una sua autonoma e libera comprensione dei fatti. Un giornale non può e non vuole vincolare i lettori alla sua opinione perché non è un partito: è molto di meno e infinitamente di più, in realtà – anche se in funzioni completamente diverse – perché il rapporto tra il giornale e i suoi lettori trasforma l’insieme in una comunità viva, in cui uno influenza l’altro, in nome di ciò che davvero si compra e si vende in edicola, e cioè un’identità, un sistema di idee che organizzano, gerarchizzano, ordinano le notizie del giorno. In nome non certo di una linea politica, finita per fortuna con il secolo delle ideologie: in nome di un modo di guardare al mondo e al proprio Paese, in nome di uno sguardo, di un sistema di valori, di quella che Piero Gobetti chiamava (con una formula che a noi di Repubblica è cara) “una certa idea dell’Italia”. Sapendo però che in una società democratica a capotavola deve sedere soltanto la politica, perché è lei che deve dare le carte e tenere il mazzo, in quanto solo la politica può disciplinare il libero gioco degli interessi legittimi che sono in campo, con l’interesse generale.
Si capisce così che cosa intenda uno studioso come Neil Postman, quando sostiene che la democrazia è “tipografica”: perché tipografica è la mente del cittadino-lettore che è alla base del discorso pubblico nel mondo occidentale. Anzi, potremmo dire che proprio il lettore di giornali è il soggetto ideale di una democrazia, il cittadino consapevole perché informato.
Ancora un passo: il cittadino lettore è probabilmente l’homo sapiens di questo secolo, in cui superficialmente si celebra la fine dei giornali. Se questo è il rapporto tra giornali, cittadini e democrazia, se il triangolo regge davanti alla crisi e al trionfo di internet, che senso ha dunque la vecchia domanda che si sente rivolgere ai giornali: “con chi stai”? Sarebbe ora di abbandonarla, passando finalmente alla vera domanda delle democrazie liberali, nei confronti di un giornale: “ma tu, chi sei”? Perché solo se davvero posso sapere qual è la natura, l’anima, la cultura di un giornale, la storia della sua redazione, l’identità trasparente della sua proprietà, solo così capisco qual è la sua “idea del Paese e del mondo”, e posso comprendere infine perché il giornale prende certe posizioni, “sta” con questo o contro quelli. Non per un disegno ideologico astratto, ma perché il suo modo di essere lo portano a sostenere un provvedimento, a giudicarne un altro, a condurre una battaglia politica e culturale. Perché il giornale, proprio in questa fase confusa di globalizzazione, di spaesamento, di crisi, scopre di avere un ruolo straordinario come mediatore culturale, per la sua aderenza al quotidiano, per la sua flessibilità nell’adattarsi ai fatti seguendoli, per la connessione quasi tecnica che sa creare tra avvenimenti e idee, per le energie intellettuali che riesce a mobilitare, per la traduzione indispensabile che sa fare abitualmente dal linguaggio scientifico o accademico degli esperti, al consumo del grande pubblico.
Una mediazione anche nel senso proprio del termine: perché internet nella ricchezza dei suoi blog e nella classifica quantitativa dei suoi click premia inevitabilmente le polarizzazioni e le posizioni più radicali ed estreme, mentre il giornale seleziona, porta a sintesi, gerarchizza, sceglie – e nel fare tutto questo introduce elementi di razionalità e di razionalizzazione, si assume una responsabilità democratica. In Italia, con la crisi dei partiti che sono ormai tutti giovanissimi e senza un portato culturale storico, i giornali hanno messo a disposizione dei cittadini un’elaborazione dei fatti intrecciata ad un pensiero e a valori di riferimento, reinterpretando in chiave etica, culturale, politica le controverse vicende quotidiane della post-modernità. Si potrebbe dire che in questo senso e nel piccolo spazio che spetta loro, i giornali lavorano sui fondamenti culturali di una comunità, cercando di fornire giorno dopo giorno al lettore, spaesato dalla mancanza di riferimenti sicuri e permanenti, quegli elementi di esperienza e di coesione intellettuale che consentono una visione non puramente episodica ed emozionale degli avvenimenti.
Una funzione particolarmente utile in un momento in cui, come dice Zygmunt Bauman, “nulla dura abbastanza a lungo da essere pienamente acquisito”. Se tutto questo è vero si capisce perché il conflitto tra i giornali e il potere sopravviva anche nell’era di internet, come il rapporto rimanga per forza di cose difficile.
Se questa è infatti la funzione democratica del giornale, oltre all’obbligo di dare le notizie, il potere (di qualsiasi segno politico) la troverà infatti scomoda, come un filtro inopportuno tra ciò che i governanti chiamano popolo e che i giornali considerano invece cittadini, e la sfera governante.
Il caso italiano è alquanto complicato a partire dai dati strutturali. Nel rapporto tra copie vendute e popolazione, infatti, da anni non si riesce a salire oltre il muro del 10 per cento, una percentuale mediterranea, molto lontana dalle 28,9 copie ogni cento abitanti vendute in Germania, alle 30,3 dell’Austria, alle 41,2 della Svezia. Lo spazio della televisione spiega in parte questo fenomeno. L’Italia è un Paese dove la televisione divora una quota della torta pubblicitaria complessiva che non ha uguali in altre democrazie. Negli Usa secondo il World Press Trend 2003 la quota destinata alla televisione non supera il 36 per cento, in Germania arriva appena al 33 per cento, mentre in Italia è arrivata nel 2007 al 54 per cento, costringendo i giornali ad alzare il prezzo per sopravvivere, allontanando per forza di cose dall’acquisto le fasce più deboli della popolazione, quelle più esposte alla crisi economica. Nella specialissima dieta mediatica degli italiani – studiata dal Censis nel 2004 – il 9,1 per cento della popolazione vede solo la tv, il 37,5 per cento non legge mai un libro e non sa nemmeno cosa sia internet. E’ quella che il Censis definisce come condizione di “solitudine televisiva”, una solitudine che si allarga al 46,6 per cento della popolazione particolarmente esposto ad un unico strumento mediatico a cui è debitore in toto degli elementi di conoscenza e di valutazione sulla vicenda pubblica.
L’altro dato strutturale è quello del controllo di questo sistema televisivo così influente sulla pubblica opinione.
L’Italia è infatti l’unico Paese democratico al mondo in cui un unico soggetto – che è anche capo del più grande partito, capo della maggioranza parlamentare e capo del legittimo governo – domina di fatto l’universo televisivo nazionale, con un controllo proprietario sui tre canali privati e un controllo politico sui canali pubblici. Si tratta di un controllo di quella che potremmo definire la moderna agorà, la piazza dove prende corpo e anima il discorso pubblico, quello spazio delicatissimo dove si scambia il mercato del consenso e dove si forma quel soggetto indispensabile di una democrazia occidentale che è la pubblica opinione. Questo squilibrio evidente a qualsiasi osservatore agisce soprattutto sul paesaggio culturale di fondo delle televisioni, ormai uniformate ad un linguaggio e uno sguardo comune, e nei telegiornali. In questo quadro, il compito dei giornali – nel loro ventaglio di opinioni – è ancora più rilevante. Anche se, in questo stesso quadro, è facile per un giornale diventare “eretico” rispetto al mainstream, proprio perché opera fuori dal senso comune tracciato dall’informazione televisiva. A questo punto conviene genuflettersi al mainstream o accettare il marchio dell’eresia? La domanda è retorica: ma la risposta è scomoda. Perché l’isolamento, come la solitudine, non è una condizione di libertà.
Tutti conoscono le 10 domande che Repubblica, il principale giornale del Gruppo editoriale da me presieduto, ha rivolto da maggio per sei mesi ogni giorno al Presidente del Consiglio (ottenendo infine le risposte, sia pure in forma indiretta e obliqua) sugli scandali che quest’estate hanno attirato l’attenzione dei giornali di tutto il mondo. Quelle domande sono nate quando il giornale ha creduto di rilevare contraddizioni evidenti nei racconti del Premier, o tra i suoi racconti e quelli di altri protagonisti. Repubblica ha chiesto ufficialmente un’intervista al Capo del governo, per potergli porre le dieci domande e risolvere quelle contraddizioni. Ha concordato con il sottosegretario un termine di quattro giorni per avere una risposta. Dopo quattro giorni, non avendo ricevuto risposte, ha pubblicato le domande. La convinzione del giornale, affermata più volte, è che là dove esistono contraddizioni del potere, lì si apre uno spazio naturale e obbligatorio per l’indagine del giornalismo.
Non voglio qui parlare delle vicende che riguardano il Premier, voglio parlare del rapporto tra stampa e potere che nasce da quelle vicende. Il Capo del governo ha infatti attaccato i giornali che si sono occupati di questo suo scandalo e in particolare durante un meeting ufficiale dei giovani imprenditori a Santa Margherita Ligure ha invitato dalla tribuna le aziende a non fare pubblicità sui giornali che ha definito “catastrofisti”, spiegando poco dopo che si riferiva specificamente a Repubblica.
E’ la prima volta, com’è stato notato, che un leader politico occidentale cerca di indebolire economicamente un giornale che lo critica, alterando il libero mercato. Lo stesso leader politico ha poi invitato pubblicamente gli imprenditori a boicottare Repubblica (“dovete ribellarvi a Repubblica”, sono le parole esatte), ha definito “delinquenti” due cronisti del giornale che gli rivolgevano una domanda, ha augurato il fallimento del Pais al corrispondente in Italia del quotidiano spagnolo, perché lo aveva interrogato sullo scandalo, e ha suggerito agli italiani di non leggere i giornali, spiegando che la buona informazione esiste solo in televisione, mentre quella dei quotidiani è cattiva. Infine, il Premier ha citato in giudizio le dieci domande di Repubblica, chiedendo un indennizzo di un milione di euro: è un’altra prima volta, il caso inedito di un Primo Ministro che denuncia in tribunale delle domande perché vuole che il giudice le cancelli e le tolga di mezzo. A questo punto la questione di verità, di accountability, nata con questa vicenda che ha fatto il giro del mondo, diventa anche una questione di libertà. Il Premier ha attaccato con Repubblica anche la grande stampa occidentale, accusandola di far parte di un complotto eversivo per rovesciare il suo governo, come se esistesse una sorta di internazionale dell’informazione. La domanda che bisogna porsi è se è ancora possibile in Europa lavorare con un’inchiesta giornalistica permanente sul potere in carica, oppure no.
E in quali condizioni è possibile fare questo lavoro. Cito un giudizio del giovane scrittore Roberto Saviano: “la libertà di stampa significa anche libertà di non avere la vita distrutta, senza essere attaccati sul piano personale, senza un clima di minaccia, senza avere contro non un’opinione opposta, ma una campagna che mira al discredito totale di chi la esprime”.
Ovviamente i leader politici di tutto il mondo hanno il diritto di difendersi da chi li attacca e anche da chi li critica. In democrazia, quei leader si difendono usando le armi straordinarie della loro influenza politica – dietro la quale si fa sentire il peso del consenso popolare che li ha eletti – e del loro ruolo mediatico. Non è invece mai accaduto, in Occidente, che un Primo Ministro usi televisioni e giornali sotto il suo controllo o di sua proprietà per attaccare sul piano personale – e non sul piano delle idee e delle opinioni, come nota Saviano – chi lo critica o chi esprime giudizi non conformi. In Italia, in questi mesi, è accaduto qualcosa di simile, e lo sa il direttore del giornale dei vescovi, costretto, dopo aver criticato il potere, a lasciare il suo posto per la pubblicazione di un foglio anonimo che lo accusava in linguaggio poliziesco di omosessualità.
La questione della libertà di stampa, in una democrazia e nel cuore dell’Europa e del 2009, va dunque riformulata in questi termini: intimidazioni, attacchi, denunce giudiziarie, insulti, possono condizionare il libero esercizio della critica giornalistica, o anche soltanto il lavoro d’indagine e d’inchiesta? Possono interferire con la serenità del lavoro giornalistico, con la libertà d’espressione? C’è qualcuno che quando accende il computer per scrivere un giudizio critico sul potere deve prima pensare a se stesso, alle sue vicende personali, alle sue eventuali debolezze, alle sue possibili paure, e dunque deve consigliare a se stesso di girare al largo, di evitare i problemi, di lasciar perdere? Ma tutto questo, ha oppure non ha un riflesso sul diritto del cittadino di essere liberamente informato, e cioè sul diritto di conoscere e sapere, vale a dire di poter assistere al normale e fisiologico confronto tra stampa e potere, nella piena libertà e autonomia di entrambi? C’è anche un altro interrogativo: questi metodi di elusione e di intimidazione, in una democrazia, servono davvero al potere? Il 5 novembre, dopo sei mesi di attacchi e denunce, il Premier italiano ha dovuto infine rispondere alle 10 domande di “Repubblica”.
Questa decisione dimostra che le domande erano legittime, ed era giornalisticamente giusto porle, ripeterle, pretendere una risposta. Il ritardo con cui la risposta è arrivata è certo politicamente significativo. Altrettanto significativo è il modo scelto per le risposte: rifiutando un confronto diretto con “Repubblica”, o un dialogo con la pubblica opinione, per scegliere invece un giornalista amico, e un suo libro edito dalla casa editrice di diretta proprietà del Capo del governo. Un’operazione politica controllata e protetta. “Repubblica” ha preso atto della decisione di rispondere, e del modo imbarazzato e generico con cui il Premier ha risposto: manifestando una coscienza del limite, che è la vera risposta, e lascia la questione di verità intatta e l’indagine giornalistica sul potere aperta.
Come questa vicenda dimostra, c’è una questione culturale e politica aperta, che riguarda tutte le nostre democrazie, sempre più inclini al leaderismo e al rapporto diretto tra leader e popolo. Nella moderna cultura populista che si fa strada in Occidente, il leader eletto dal popolo proprio per questa speciale “unzione” sacra si considera sovraordinato rispetto agli altri poteri, rifugge da ogni bilanciamento, da ogni controllo – sia quello della stampa, sia quelli istituzionali – perché non ne riconosce la legittimità. Quando però gli ordinamenti costituzionali sono quelli classici delle democrazie parlamentari occidentali, i comportamenti dei leader conformi a quella cultura populista spesso determinano contrasti, conflitti e abusi di potere, che il libero giornalismo deve naturalmente cogliere, sottolineare e denunciare, quando ne sia convinto.
In questi giorni in Italia i giornali sono di fronte ad un nuovo caso: il Presidente del Consiglio sta costruendo una legge che, riducendo il tempo dei processi, serva a cancellare due suoi processi in corso a Milano, con uno schema che potremmo definire così nella sua anomalia occidentale: il potere esecutivo usa il legislativo per fermare il giudiziario. Naturalmente la cultura della stampa come soggetto libero e non subordinato, rappresentante della pubblica opinione cozza in ogni Paese contro il potere, e tanto più contro la cultura della leadership populista, sovraordinata ad ogni controllo. Anzi, ogni critica di un giornale, in qualsiasi Paese, può essere presentata e stigmatizzata come un atto contro la sovranità popolare, contro il voto che scegliendo un leader non ammette obiezioni, contro l’unione in un solo corpo mistico tra il Capo e il suo popolo, entità rispetto alla quale il concetto di cittadino s’impoverisce ogni giorno di più. E’ un condizionamento culturale nei confronti dei giornali: chi critica il leader critica il suffragio popolare, dunque critica un potere non solo legittimo ma intangibile, quindi è automaticamente un eversore. Con un solo passo avanti si arriva facilmente all’accusa di antipatriottismo. Poiché leader e popolo sono uniti in una sacra unzione carismatica che consacra il potere nell’interesse e anzi nel destino della nazione, chi critica questa unione, o la indebolisce o la mette in crisi agisce contro l’interesse stesso del suo Paese, compie un’azione anti-nazionale, antipatriottica.
E’ un’altra insidia – come ho detto, di tipo culturale in questo caso – contro la libertà e la piena autonomia d’azione e di critica del giornalismo.
E’ ovvio che chi critica il legittimo potere – di fronte a ciò che ritiene un errore, uno sbaglio, un abuso – ama il suo Paese almeno quanto chi detiene il potere: lo ama attraverso la democrazia, attraverso la costituzione, attraverso il rispetto delle istituzioni, della regola civica dei diritti e dei doveri che vale e deve valere per tutti, per i governanti e per i cittadini. Anzi, nella parte del mondo in cui noi viviamo – L’Europa terra della democrazia dei diritti e della democrazia delle istituzioni – non c’è altro modo per amare il proprio Paese. In più, il proprio Paese si serve quando ognuno realizza in libertà e in coscienza il proprio compito svolgendo il proprio ruolo. E la democrazia contempla e annovera i casi molteplici in cui, nello svolgere ognuno le sue libere funzioni, stampa e potere giungono ad un confronto anche duro, che spesso diventa conflitto. Quando questo confronto-scontro viene considerato parte (anche scomoda, si capisce) della fisiologia del sistema, la libertà ne guadagna, e il diritto dei cittadini di conoscere e sapere si arricchisce e cresce. Quando questo conflitto viene considerato illegittimo o peggio eversivo, dunque criminale, il diritto del cittadino a conoscere e sapere risulta condizionato, impoverito e la stessa qualità della democrazia paga un prezzo.
Molti cittadini (è il caso di Repubblica, ma è il caso del Chicago Tribune) sono tornati a leggere abitualmente il giornale proprio quando svolge una indagine quotidiana nei confronti del potere: cioè per conoscere e per sapere. E allora, almeno in minima parte forse sta proprio qui – nell’autonomia dal potere, nell’esercizio ragionato di una critica, appoggiata ad una storia coerente di giornalismo, ad una certa idea del Paese, come dicevamo – la ragione di sopravvivenza della carta stampata. Nel flusso, nella contemporaneità, nella velocità, nella capacità di portata di notizie indistinte nel grande fiume di Internet, la battaglia del giornale di carta è perduta, contro un competitor che ha saputo cambiare la storia (perché in rete tutto è contemporaneo) e la geografia (perché sul web tutto è ubiquo). Solo che il giornale non è flusso. Il giornale sta immerso dentro il flusso, ma lo lascia scorrere trattenendo quei “pieces of news” con i quali si può costruire ogni giorno una cattedrale, che abbia il compito di assomigliare alla giornata che abbiamo attraversato, alla fase che stiamo vivendo. Nel fare questo, il giornale fa il contrario del grande fiume di internet, seleziona, gerarchizza, scarta e sceglie, trattenendo quelle notizie che sono portatrici di senso, che sono capaci di significato. Con questa ricerca di senso, il giornale ri-legge la giornata, allarga lo spettro di significato delle notizie che il lettore ha già visto scorrere sul computer o in televisione, le penetra negli interessi che veicolano, disegna un contesto in cui farle vivere in relazione ad altri fatti, esprime infine un’opinione.
Nell’integrazione con internet, che amplifica il brand e moltiplica l’audience, nasce il giornale a ciclo continuo, con il nastro che corre tutto il giorno sul web, e si fa giornale al mattino, mettendo in mano al lettore il meglio di quel che ha visto scorrere sullo schermo, alzandolo da una dimensione orizzontale ad una verticale, dove si incontrano i concetti, dove i fatti fanno nascere le idee, dove l’informazione diventa conoscenza, cittadinanza, responsabilità. Tutto ciò è utile sempre, in democrazia, dove è necessaria la comprensione dei fenomeni, per prendere parte davvero al discorso pubblico. Ma è indispensabile in questa fase in cui, come spiega Bauman, il cittadino non crede più nell’efficacia di azioni pubbliche durature ed è il momento della moderna “idolatria”: con “la notorietà che sostituisce la fama”, la celebrità che prende il posto della stima, la politica si trasforma in eventi che mutano il cittadino in pubblico-folla, in spettatore delegante, il quale con la forza dei suoi numeri e dei suoi applausi attribuisce carisma ai leader, divenuti idoli.
Molto semplicemente, il giornale è una contromisura, un antidoto, e può svolgere una funzione di fortissima modernità. Perché il cittadino-lettore, il cittadino liberamente informato può sviluppare una capacità critica autonoma: quella “immunity to eloquence” di cui parlava Bertrand Russell, la capacità cioè di resistere alla magia delle parole e ai suoi inganni.
Il buon vecchio giornale è contro ogni falsa magia proprio per questa sua ricerca ostinata e selettiva, attraverso i fatti, del senso delle cose: ciò che vale la pena sapere, ciò che merita ricordare, ciò che resta da capire.
* L’autore, presidente Gruppo Editoriale L’Espresso, è stato invitato dal Reuters Institute for the Study of Journalism presso la Oxford University per l’annuale Reuters Memorial Lecture, al St Anne’s College. Questo è il testo che ha presentato il 23 novembre 2009.