V come Vendetta. Non è solo comunicazione, è strategia politica. Di potere.
Non sono nemmeno 24 ore che Matteo Salvini, leader della Lega ma anche Vicepresidente del Consiglio e ministro oramai di lungo corso, ha marchiato a fuoco nel dibattito pubblico la parola “vendetta” associata alle vittime di violenza sessuale; nemmeno un giorno e persone che non te lo aspetteresti stanno già condividendo frasi fatte e meme che ironizzano sulle donne che in modo estemporaneo, a un certo punto, “cambiano idea” a metà rapporto sessuale e lo definiscono stupro.
Salvini ha più volte ripetuto, in favor di microfoni, che il suo partito ha bloccato l’approvazione al Senato della legge sul “consenso libero e attuale”, che invece alla Camera aveva votato, perché “è una legge che lascia lo spazio a vendette personali che intaserebbero i tribunali e alimenterebbe lo scontro”. Le vignette e i fotomontaggi sputati fuori velocemente grazie all’AI inondano subito la rete e contribuiscono a fissare quell’idea, che le donne sono imprevedibili, che potrebbero cambiare idea all’ultimo, o durante, e che, poverini, gli uomini non le capiscono, uno dei più popolari cliché di genere. È il ribaltamento della logica, più che dell’onere della prova. È uno dei capisaldi dei governi autoritari: il controllo delle parole, meglio se poche, semplici e dirette, nelle quali chiunque lo voglia – senza preclusione alcuna – possa riflettere un’identificazione di sé. Il linguaggio è pieno di slogan che richiamano luoghi comuni; di etichette facili da ricordare che tolgono la fatica dei ragionamenti, dei confronti e delle conclusioni coerenti. Producono schieramenti opposti in un caos babilonico che alza una cortina fumogena e un parapiglia dialettico in cui tutto può accadere.
Cos’è successo dunque tra il voto favorevole dei deputati leghisti e lo stop lanciato da Salvini proprio il 25 novembre? Ci sono varie tessere di questo grande puzzle.
Meloni e Schlein unite sul consenso
Prima di tutto c’è stata l’attenzione dei media, tradizionali e nuovi, sull’accordo bipartisan sul testo tra Elly Schlein e Giorgia Meloni. La Presidente del Consiglio e leader di Fratelli d’Italia aveva dichiarato che si trattava di un «impegno comune per combattere la violenza contro le donne»: parole espresse in un’intervista all’agenzia La Presse la mattina della Giornata internazionale di lotta per l’eliminazione della violenza sulle donne, lo stesso giorno in cui poi il suo vice, immediatamente supportato da Giulia Buongiorno, bloccava tutto. Schlein, invece, per celebrare questa importante alleanza trasversale per le donne, aveva ricondiviso una foto di lei e Meloni che si stringono la mano e che aveva fatto il giro dei social, dei giornali, dei telegiornali. Forse troppo, perché a qualcuno non desse fastidio.

Le elezioni in Veneto, Campania e Puglia
Tra il voto alla Camera e quello al Senato, ci sono state anche le elezioni regionali del 23 e 24 novembre in cui i pesi e gli equilibri dei partiti del centrodestra, in particolare Lega e Fratelli d’Italia, e in particolare in Veneto, si sono rimescolati a vantaggio della componente salviniana.
Il referendum sulla giustizia
Ma soprattutto si è scatenato il caso dei “bimbi nel bosco”, una vicenda gonfiata all’inverosimile su cui (quasi) nessuno ha sospeso il giudizio, tra polemiche manichee e pretestuose e, verrebbe da dire, strumentali. Una perfetta epitome della campagna referendaria, non ancora iniziata e già infuocata, sulla riforma della Giustizia voluta dalla maggioranza, tutta giocata contro la “casta” dei magistrati. Il segretario della Lega ha parlato di “violenza ingiustificata” a proposito del provvedimento del Tribunale dei minori di allontanamento dei bambini e della mamma dall’abitazione rurale. «Un giorno si svegliano e mandano cinque pattuglie dei carabinieri in un bosco, neanche ci fosse Totò Riina», ha detto. La sua deputata Giorgia Latini ha chiesto in aula chiarimenti sulla vicenda al ministro della Giustizia. Carlo Nordio ha risposto annunciando accertamenti ma non si è sottratto dall’esprimere dubbi e perplessità sull’allontanamento dei bambini dalla casa nel bosco, pur rimandando un’opinione definitiva alla fine delle verifiche in corso.
La strategia è chiara: si prendono casi concreti in cui sono protagonisti i giudici – i bimbi nel bosco come il caso Garlasco, ma anche la bocciatura del ponte sullo Stretto da parte della Corte dei Conti – e si mette in dubbio la correttezza del loro operato, si punta l’indice (una postura diffusa) contro l’esercizio della loro professione, si denuncia la mancanza di controllo delle loro azioni e decisioni. Insomma, un rosario di esempi di “malagiustizia” che dimostrano che bisogna cambiare. Vale anche per la legge sul consenso: dopo la brusca frenata, la maggioranza assicura che la legge si farà, che ne uscirà addirittura migliorata, ma intanto ormai il dubbio è stato instillato, scorre nell’internet e al bar, nei luoghi di lavoro e nei negozi e in ogniddove. E solo per averlo dichiarato ad alta voce è diventato plausibile: alla prossima denuncia di stupro, quanto c’entrerà la vendetta della vittima? Quanto starà esagerando? Si torna alla casella di partenza, che pensavamo lontana: è peggio del «Com’era vestita?», del «Però è salita a casa», del «E perché ci è uscita insieme?». Insomma, le donne mentono.
Alla trasmissione La Zanzara, Salvini ha detto: «Il consenso attuale e libero è una follia… rischia di diventare un’arma di chi vuole vendicarsi. E rischia di complicare la vita alle famiglie italiane». Attenzione alle parole in un assunto così breve: follia, arma, vendetta, famiglie italiane.
Un rischio che non esiste, dicono molti avvocati e magistrati tra cui il presidente del Tribunale di Milano, Fabio Roia, da decenni impegnato nella lotta alla violenza di genere. In un’intervista al Corriere della Sera, Roia ha spiegato che anche con la nuova legge, così come avviene già oggi ma senza un quadro normativo apposito, «sarà comunque il Pm a dimostrare l’assenza di consenso». Ma il punto è esattamente questo, perché qui il punto di vista è di chi non ha fiducia alcuna nei magistrati. Anzi.
Etichettare i bersagli
Il caso della legge sul consenso, poi, è efficace nella definizione dei bersagli, delle categorie su cui stare allerta: i lavoratori che scioperano, i giornalisti che fanno domande, gli insegnanti che insegnano, le donne che denunciano, i giudici che giudicano.
«Ciò che inizia come linguaggio diventa la giustificazione per l’azione: licenziare dipendenti pubblici, vietare libri, riscrivere programmi di studio, deportare migranti, criminalizzare il dissenso. Trump non parla per spiegare, ma per polarizzare. Definisce il disaccordo come un tradimento. Riformula il dissenso come una minaccia» ha scritto James B. Greenberg, professore emerito di Antropologia alla University of Arizona, a proposito della retorica trumpiana. È esattamente quello che ci ha detto accadere, in un racconto agghiacciante, Chiara Bottici nel primo incontro del ciclo “Autoritarismi in democrazia” (qui il link alla versione integrale e qui la sintesi su Radio Popolare): a proposito di parole, la professoressa di filosofia, come molti suoi colleghi, ha dovuto cancellarne alcune dalla sua bio e dai suoi lavori e tra queste c’è addirittura “donna” e “femmina”. Woman, female, sono tra le parole bandite dall’amministrazione Trump, come ha scritto il New York Times, e che infatti stanno sparendo dai documenti ufficiali, pena tagli di fondi e ripercussioni ben peggiori. L’elenco è lungo e ci sono anche “vittima”, “genere”, “sessualità”, “sesso”. C’è un’attenzione eccessiva e puritana volta a riscrivere i ruoli e i prossimi capitoli di una “guerra dei sessi”, sempre che si possa ancora dire.

Puntare l’indice
Non a caso, nel frattempo, tornando alle cronache romane, è slittato anche il voto sul ddl sull’educazione sessuale, quello che prevede che venga fatta nelle scuole superiori di secondo grado, tra studenti maggiorenni, previo consenso dei genitori: a inizio novembre, tre deputate del Carroccio avevano presentato in Commissione un emendamento che stabiliva il divieto di insegnamento dell’educazione sessuale nelle scuole medie, oltre che nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole elementari, come invece prevedeva inizialmente il testo del ministro dell’Istruzione, il leghista Giuseppe Valditara. L’educazione alla sessualità, alle relazioni, ai pensieri e alle parole che non feriscono sono i presupposti essenziali per evitare di arrivare fin lì, fino all’abuso, fino alla denuncia, fino all’intervento delle forze di polizia e dei giudici. Ma non va bene nemmeno quella, alla destra per cui quella è materia da delegare alle famiglie. Torna la centralità della famiglia, del privato, dell’individuo. È proprio un’altra idea di società, più tradizionale, gerarchica, ordinata, obbediente. Chi dissente è il nemico, indicato con l’indice puntato contro, come quello, qualche giorno fa, del presidente americano contro una giornalista di Bloomberg che sull’Air Force One gli chiedeva delle email in cui Jeffrey Epstein scriveva che Trump “sapeva delle ragazze”: «Zitta, zitta porcellina», le ha risposto lui, con il polpastrello teso verso il volto, attonito, di Catherine Lucey. Ieri invece l’obiettivo era Katie Rogers, la corrispondente del New York Times alla Casa Bianca, accusata di essere «una giornalista di terza categoria, brutta dentro e fuori». Trump intensifica gli attacchi alle giornaliste, il titolo di Time. Non ai livelli di “strega fallita” che il rappresentante di Israele all’Onu ha lanciato contro Francesca Albanese, relatrice speciale sui Territori palestinesi autrice di un dossier sul genocidio a Gaza che l’ambasciatore ha bollato come “libro degli incantesimi”.
Bugiarde, vendicative, megere e impostore, fondamentalmente minacce all’ordine costituito.
Erica Chenoweth and Zoe Marks, docenti di Harvard, lo hanno scritto chiaramente nel loro articolo “La vendetta dei patriarchi. Perché gli autocrati temono le donne”: l’attivismo delle donne costituisce una minaccia per i leader autoritari, perché si batte contro le gerarchie sociali, la concentrazione del potere nelle mani di pochi, per democrazie più egualitarie.
Il 25 novembre era il giorno migliore, ma non certo l’unico, per attaccarle.



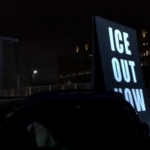

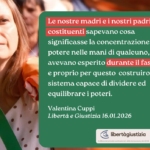







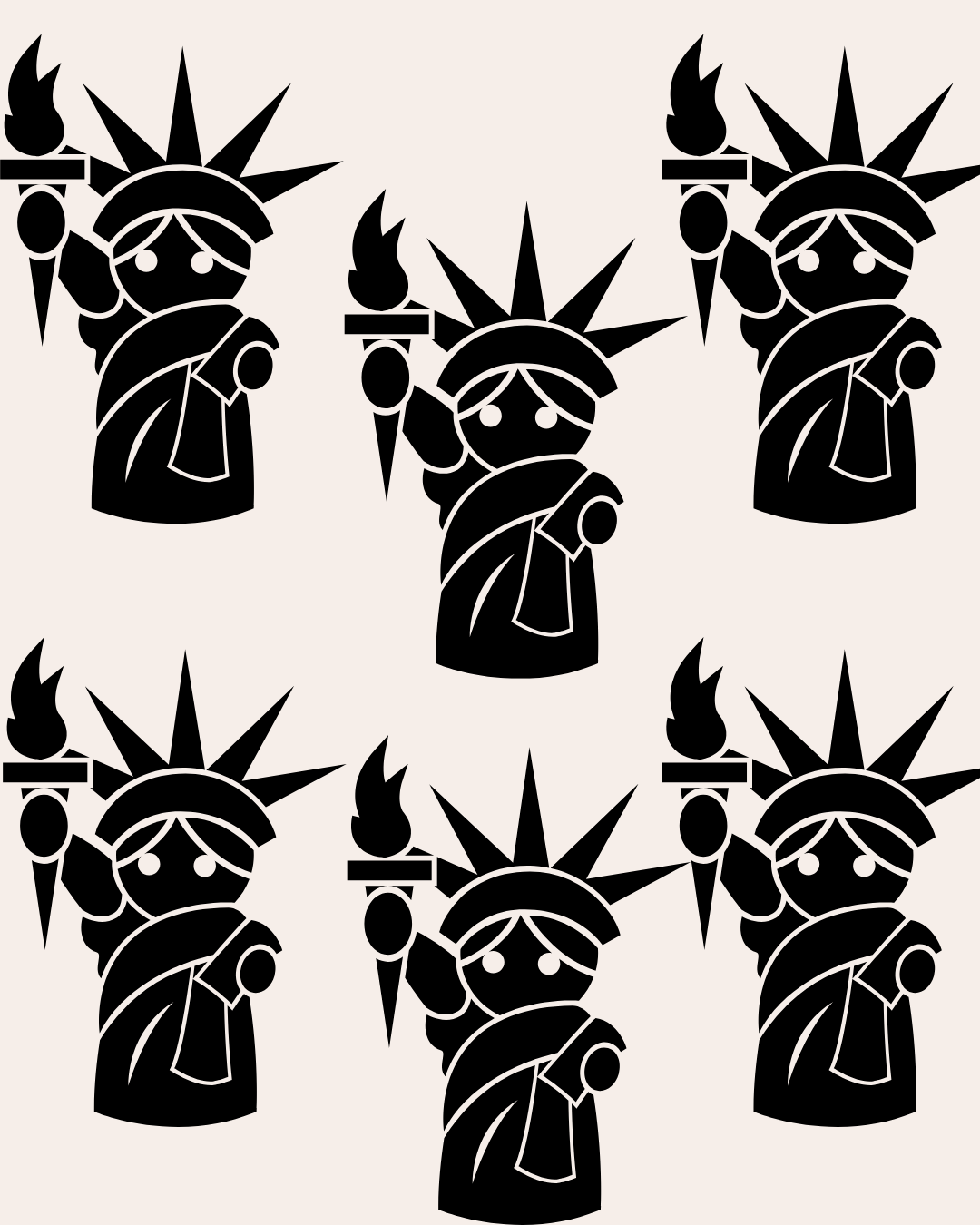


 Nadia Urbinati
Nadia Urbinati

