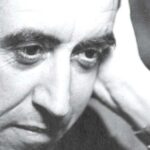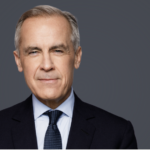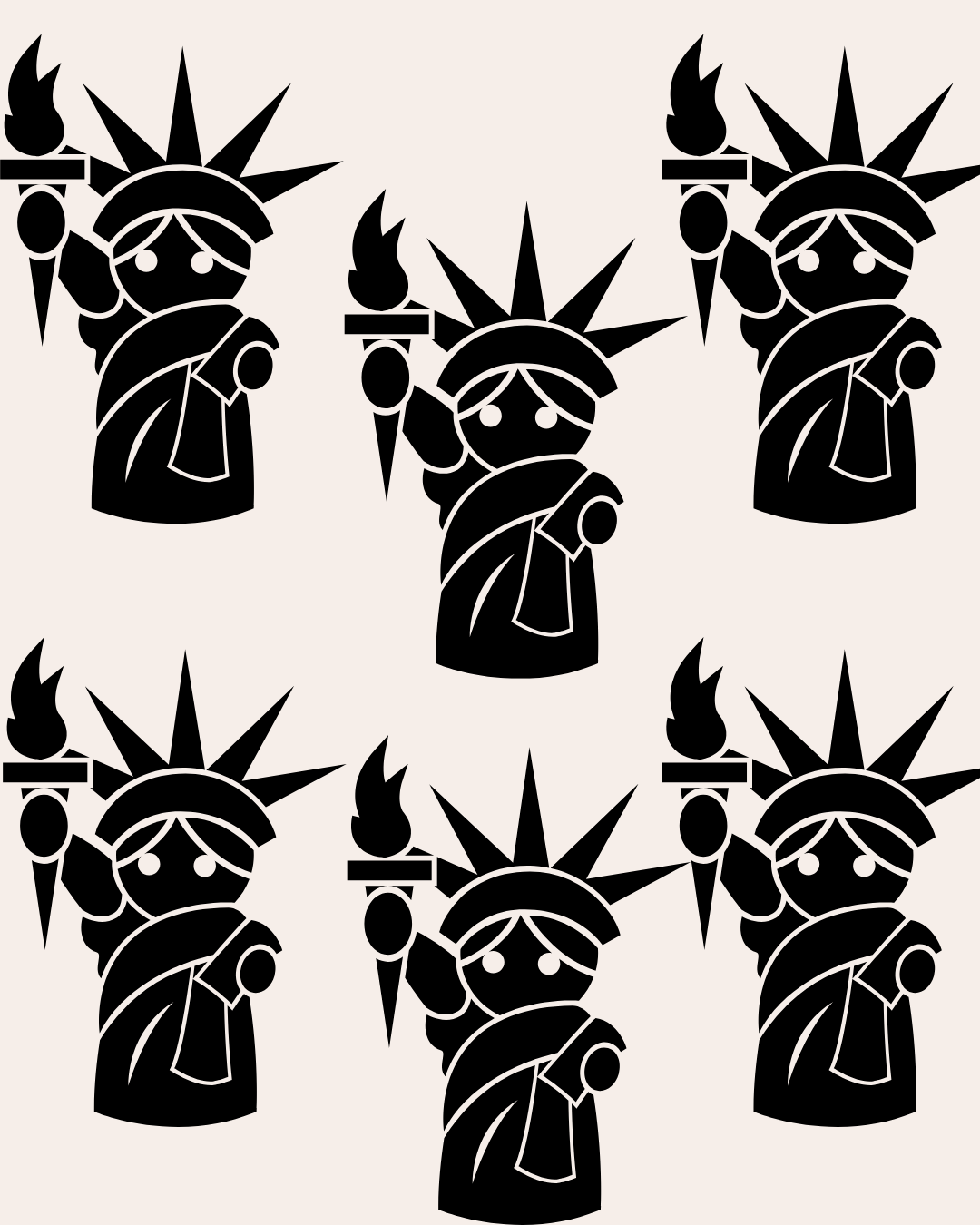«Ma tu sei matta, così mi espellono». La scorsa estate, un amico italiano che sta negli States mi risponde secco così, quando gli chiedo di fare un post su un aneddoto significativo dell’America d’oggi. Non è una delle sue solite battute da napoletano burlone, me lo dice serio.
L’8 ottobre, a “Radio Popolare”, Luisa Nannipieri intervista un italiano che vive a Chicago, una delle città a guida democratica in cui il presidente Donald Trump ha deciso di inviare i militari della Guardia Nazionale per “ripristinare” la sicurezza: l’intervistato testimonia come si vive nella metropoli, ma lo fa protetto dall’anonimato. Qui, dal minuto 1’20’’.
Del resto, se Trump ha minacciato di far arrestare il sindaco di Chicago Brandon Johnson e il governatore dell’Illinois JB Pritzker, colpevoli di averlo criticato, figuriamoci cosa può accadere a normali cittadini. A dire il vero, JB Pritzker ha anche la colpa di essere uno dei più ficcanti ed efficaci antagonisti del King degli Stati Uniti e uno dei potenziali prossimi candidati democratici alla Casa Bianca.
La politicizzazione della sicurezza nazionale statunitense da parte dell’amministrazione Trump, ha titolato “Le Monde” il 21 ottobre. «Attraverso epurazioni nelle agenzie di intelligence, politicizzazione istituzionale e una deriva autoritaria, il presidente americano ha scosso la democrazia statunitense e ha promosso un nuovo immaginario “nemico interno”»: il sommario spiega già tutto quel che sta accadendo negli Stati Uniti. E non solo.
La strategia del nemico
Il “nemico” è la chiave di tutto. Non ci sono avversari, ma nemici, nell’esercizio della politica da parte delle destre autoritarie.
La lista dei nemici di Trump si allunga: James Comey, Adam Schiff, Letitia James, John Bolton gli ultimi. Tra loro anche vecchi amici ora nuovi nemici. «Il rinvio a giudizio di James Comey oltrepassa una ulteriore linea rossa nel consolidamento del potere autocratico di Donald Trump. Si tratta infatti della prima incriminazione di un ex direttore dell’Fbi per atti d’ufficio e avviene per esplicita volontà di un presidente» ha scritto a fine settembre Luca Celada, corrispondente dagli Stati Uniti de “il manifesto”.
Sul “New York Times” del 17 ottobre, nell’articolo titolato Come Trump sta usando il Dipartimento di Giustizia per colpire i suoi nemici, si puntella il progetto di vendetta che il presidente ha palesato sin dai primi giorni della sua corsa al secondo mandato. “NBC News” il 21 ottobre: «Alcuni critici di Trump temono di poter essere il prossimo obiettivo degli attacchi giudiziari del presidente».
I giornalisti nemici
Il conflitto di Donald Trump con i media è una voce a sé stante di “Wikipedia”. Addirittura.
«Tutte le principali testate giornalistiche hanno respinto l’ordine del Pentagono di pubblicare o trasmettere solo informazioni fornite dal Dipartimento della Difesa (che l’amministrazione chiama Dipartimento della Guerra). E ci sono stati diversi altri esempi, proprio negli ultimi giorni, di giornalisti che hanno lasciato il lavoro in risposta alle pressioni della censura. Aggiungo il mio nome a questa lista. Fino al 10 ottobre ero il direttore di “Governing”, una rivista e un sito web che si occupava di enti statali e locali. Ma dopo aver dovuto affrontare crescenti pressioni della censura interna – in gran parte per evitare una copertura critica del presidente Donald Trump – mi sono rifiutato di assecondarli e mi sono dimesso»: il 22 ottobre Alan Greenblatt su Politico.com ha raccontato pubblicamente la propria personale vicenda. Ma ha anche messo nero su bianco un presagio facile da fare quando difficile da dire: «Dopo che il governo se l’è presa con i grandi – Trump quest’anno ha ingaggiato battaglie legali con CBS, ABC, il “New York Times”, il “Wall Street Journal” e l’Associated Press, per non parlare del taglio dei fondi alla NPR, il mio ex datore di lavoro – troppo spesso i piccoli si rendono conto di non avere le risorse per opporsi. La capitolazione diventa la via più facile».
Mettere a tacere ogni critica, dei grandi e dei piccoli, accomunati dalla paura delle imprevedibili azioni e reazioni di Presidente e dei suoi. I giornalisti con gli scatoloni in mano che lasciavano in gruppo il Pentagono dopo le restrizioni imposte dal Segretario alla Difesa (o alla Guerra) sono l’immagine dei tempi duri per la libertà di parola, al tempo delle parole in libertà.
L’hype sul woke
È la guerra alla cultura “woke”. Secondo ProPublica, per capire cosa s’intenda con questo termine e con questa crociata, basta guardare allo Stato dell’Oklahoma: «L’Oklahoma ha trascorso gli ultimi anni a rimodellare le scuole pubbliche per integrare lezioni su Gesù e incoraggiare l’orgoglio per la storia americana, con leader politici e legislatori che si facevano strada nel programma conservatore per la riforma dell’istruzione. Durante il suo incarico di sovrintendente scolastico statale, Ryan Walter […] ha definito i sindacati degli insegnanti “organizzazioni terroristiche”, si è scagliato contro le classi “woke”, ha minacciato di revocare l’accreditamento ai distretti scolastici che si opponevano ai suoi ordini e ha commissionato un test per valutare se i candidati insegnanti provenienti da stati progressisti avessero conoscenze del programma “America First”. Quando la seconda amministrazione Trump ha iniziato a sposare il suo programma “America First”, che include l’espansione dei voucher per le scuole private e il divieto di lezioni su razza e sesso, l’Oklahoma era già lì, aveva già fatto tutto». Lo smantellamento del Dipartimento dell’Educazione e i tagli economici all’istruzione sono tasselli di questo disegno.
Sulla cultura cosiddetta “woke” in Italia, nei giorni scorsi, si è registrato un hype montato ad arte con l’intervento della presidente Giorgia Meloni al cinquantesimo compleanno della Niaf, la National Italian American Foundation: «Ci sono forze che cercano di dividere gli Stati Uniti e l’Italia, di ridefinire la nostra storia e di distruggere le nostre tradizioni condivise. La chiamano cultura woke. Cercano di cancellare la nostra cultura. Si sbagliano». Chi sono quelli che cercano di cancellare e che si sbagliano? E qual è la “nostra” cultura? Per Trump è la «guerra dell’America contro l’America». Una guerra civile, insomma, alimentata da una posizione dicotomica su qualunque argomento e persino sui fatti: separare l’opinione pubblica, dividendola in maniera trasversale sui temi etici e su ogni aspetto della vita quotidiana, dichiarazioni e distinguo, mille pesi e mille misure, facendo saltare prassi e liturgie, confini delle cose che si possono fare e che si possono dire sotto la bandiera della crociata contro il “politicamente corretto” diventato sinonimo di censura, fino a spruzzare cacca sugli avversari in quella confusione primordiale generata con il ricorso smodato all’intelligenza artificiale, spesso diventata indistinguibile realtà. Uso “cacca” e non il più elegante “letame”, utilizzato in questi giorni da tutti i commentatori, perché è quella a essere stata “lanciata”; perché, come succede per i bambini, è proprio quel termine proibito, che provoca reprimende da parte degli adulti, a cementare complicità nel gruppo. È attraverso la desacralizzazione del linguaggio, e il controllo del binomio linguaggio-immagine, che si manipola e domina il discorso pubblico. Il processo è oramai in corso, a livelli avanzati, e una strategia uguale e opposta potrebbe servire.
Con meno della metà dell’elettorato che va a votare, è sconfinata la prateria in cui lanciarsi in scorribande che ormai proseguono senza strategie opposte. Nel mezzo, ci sono state le manifestazioni contro lo sterminio palestinese, nella confusione creata da una surreale discussione sulla definizione da dare in punta di diritto a quella che per la maggioranza dell’opinione pubblica era indistinguibilmente una carneficina.
Le imponenti manifestazioni per la Palestina
Con lentezza novecentesca, ma non per questo meno efficace, una folla poderosa è uscita dal cono d’ombra creato ad hoc dal catatonico dibattito pubblico, prima in piccole ma sentite manifestazioni e poi in una continua processione nelle strade e nelle piazze, nelle stazioni e nelle autostrade, chiedendo la fine del genocidio, della mattanza, chiamatela come volete.
Non più solo nella realtà parallela dei social e dei salotti tv, giovani, giovanissimi, tanti, milioni, hanno formato tutti insieme un corpo solo, un fronte unico, roba che non si vedeva da decenni. Una marea, più che un movimento, ma comunque forte, ampia. Un fenomeno che più che preoccupare, infastidisce. Infastidisce il potere perché ne mina la principale colonna portante: l’obbedienza. Già un significativo saggio si era avuto nel marzo 2024, quando la polizia caricò gli studenti pisani in corteo a sostegno della Palestina: la polizia cercò di fermare a colpi di manganelli ragazzi e ragazze che volevano raggiungere la centrale piazza dei Cavalieri. Non solo il corteo non si fermò, ma da lì partì un presidio durato tutta la notte, con l’arrivo di cittadini a sostegno dei giovani, e per settimane la città sfilò in solidarietà con gli studenti picchiati e contro la guerra a Gaza. Intervenne il Presidente della Repubblica: «L’autorevolezza delle Forze dell’ordine non si misura sui manganelli ma sulla capacità di assicurare sicurezza tutelando, al contempo, la libertà di manifestare pubblicamente opinioni. Con i ragazzi i manganelli esprimono un fallimento», la nota del Quirinale.
Annientata la coscienza di classe e l’unità dei lavoratori, rinchiusi ciascuno a difendere il proprio contratto e posto di lavoro; smantellata la rappresentanza sindacale e quella politica, in nome della disintermediazione neo liberal; chiuse le sedi dei partiti; addomesticata l’informazione pubblica e privata, l’unica fucina pericolosa rimasta, luogo di socializzazione e discussione libera, è quella delle agenzie educative, le scuole e le università dalle quali non a caso sono usciti, all’improvviso e con forza – qualcuno riproponeva l’abusato “non li abbiamo visti arrivare” – quelli che hanno detto No: studenti, rettori, professori, attaccati tutti con i vuoti appellativi che puntano a criminalizzare il dissenso. Era conseguenza logica e prevedibile, questa sì, che su di loro si sarebbe allungata presto un’ulteriore stretta.
Al convegno “La storia stravolta” – organizzato a Roma, nella sede del Cnel, dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane a due anni dal 7 ottobre – la ministra della Famiglia e delle Pari opportunità Eugenia Roccella ha accusato le università di essere “tra i peggiori luoghi di non-riflessione” sull’offensiva israeliana nella Striscia di Gaza.
«Allarme università: è ora di mobilitarsi», è l’appello di Tomaso Montanari lanciato da Roars.it, sito sul quale si concentra un forte dibattito di studenti, docenti, ricercatori, insegnanti. Lo abbiamo condiviso anche sul nostro sito, perché vogliamo tenere questa riflessione nell’archivio dell’Osservatorio Autoritarismo che abbiamo costituito quest’anno, che ha prodotto e produrrà momenti di dibattito e incontro anche con e dentro le università italiane e straniere.
«Alle università spetta la responsabilità più difficile: la ricostruzione culturale, la progettazione del mondo di domani», ha scritto su “il manifesto” del 14 ottobre Filippo Belloc, economista.
Sullo sfondo c’è un progetto di riforma del sistema universitario improntato a ridurre l’autonomia degli atenei e ad aumentare il controllo da parte del governo: non è una fantasia o un rischio, ma il progetto su cui stanno lavorando le commissioni istituite ad hoc e da cui non trapelano dettagli, se non quelli “in fuga” denunciati dalla Rete 29 aprile. Che confermano, appunto, questo scenario.
Per Lorenzo Zamponi, sociologo alla Scuola Normale Superiore di Firenze, si tratta della «orbanizzazione dell’università», come ha scritto, il 20 ottobre, su “Jacobin”.
È quello che sta accadendo negli Stati Uniti, più che mai oggi la macchina del tempo nella quale entrare per vedere cosa succederà da noi domani.
Secondo la Brown University, l’obiettivo dell’amministrazione americana è «limitare la libertà accademica e l’autonomia dell’università, compromettendo gravemente la capacità di adempiere alla missione». La Brown, istituzione privata e tra le più antiche, ha appena rigettato la proposta di “patto” avanzata da Trump a nove atenei americani: il Patto per l’eccellenza accademica nell’istruzione superiore. In cambio dei finanziamenti federali, è richiesto di garantire il rispetto delle “priorità” in tema di istruzione superiore, tra le quali — cito — «punire, sminuire o addirittura fomentare la violenza contro le idee conservatrici». Eccone altre: riduzione delle ammissioni di studenti stranieri; segnalazione di docenti e ricercatori impegnati nella militanza politica, qualunque cosa voglia dire; assunzioni secondo meri giudizi di merito senza tener conto dell’appartenenza a categorie protette; fine dei programmi di diversità e inclusione. Sono punti di un’agenda transnazionale: il ddl per cancellare l’educazione sessuale nelle scuole italiane – e consentirla solo alle medie superiori previo consenso informato dei genitori – ne è un esempio. L’obiettivo, come specificato dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, è la cultura gender: «Un conto è l’educazione sessuale, un altro la teoria gender che nulla ha a che fare con l’educazione sessuale», ha detto. Nell’attacco concentrico alla cultura democratica – derisa e svilita con l’abuso e la mistificazione del termine “woke” – c’è il ddl Gasparri sull’antisemitismo nelle scuole (n. 1627) che assegna a ministero dell’Istruzione e del Merito e a quello dell’Università e della Ricerca il compito di organizzare una formazione continua per gli insegnanti – ma anche per «militari, magistrati, personale della carriera prefettizia, Forze di polizia» – con corsi «specificamente dedicati allo studio della cultura ebraica e israeliana e all’analisi di casi di antisemitismo».
Il mirroring politico
Tornando a guardare a quel che succede negli States, capofila del ribaltamento di senso, questi sono i giorni in cui le università hanno dovuto dare risposta circa il Patto proposto. La deadline era il 20 ottobre. Delle nove a cui è stato proposto inizialmente, nove lo hanno respinto, mentre due non hanno ancora reso pubblica la decisione.
Harvard sin dall’inizio aveva manifestato il mancato allineamento al diktat del Presidente, il quale aveva subito bloccato 2,2 miliardi di dollari di fondi pubblici, con l’accusa di non aver fatto abbastanza per limitare i casi di antisemitismo. Provvedimento dichiarato illegittimo dalla giudice Allison D. Burroughs della Corte distrettuale di Boston. «Dobbiamo combattere l’antisemitismo, ma dobbiamo anche proteggere i nostri diritti, incluso il diritto alla libertà di parola, e nessuno dei due obiettivi dovrebbe né deve essere sacrificato sull’altare dell’altro», ha scritto nella sentenza che potrebbe fare da argine anche in altri casi. O che potrebbe aprire l’ennesimo braccio di ferro, giudiziario e semantico, per riscrivere il diritto. E i diritti.