“Pensare è sempre pensare con altri, a partire da altri, anche quando siamo soli”, scrive Marina Garcés nel suo libro Occupare la speranza. Sembra di ritrovare, in queste parole, il concetto zapatista del camminare domandando: “Pensare non è produrre teorie ma condividere spazio e tempo per l’elaborazione di un parlare – e di un ascoltare – reciproci”. Così che il semplice fatto del pensare fossa farsi ricerca e azione condivisa. Ma come giungere a un pensare che sia vero guadagno per tutti? “Non è fare dibattiti, dialoghi, tavole rotonde (…) ma creare contesti in cui la condivisione delle idee sappia condurre il pensiero di ciascuno più in là di ciò che avrebbe potuto pensare da solo”.
L’Osservatorio Autoritarismo, al quale Libertà e Giustizia ha dato nascita insieme a Castelvecchi editore e a più di trecento studiosi e docenti di decine di università italiane ed estere, nasce dalla constatazione di una separatezza di mondi: quello della militanza e dell’attivismo, quello partitico, quello della ricerca e dell’analisi. Eppure tutti siamo consapevoli del precipizio autoritario che si sta spalancando sotto i nostri piedi.
Per questo crediamo che sia così importante aprire le università al mondo non accademico. Per condividerne la ricchezza di ricerca, ma anche per difenderle: quello che sta accadendo negli Stati Uniti è emblematico, con l’attacco diretto agli atenei che non si piegano al pensiero governativo, ma non dobbiamo dimenticare che l’articolo 31 del ddl Sicurezza, poi stralciato da quella che è diventata legge dello Stato, contemplava la possibilità e forse l’obbligo di trasformare rettori e dirigenti degli organismi di ricerca in informatori dei servizi. «Le pubbliche amministrazioni e i soggetti che erogano servizi di pubblica utilità sono tenuti a prestare al Dis, all’Aise e all’Aisi collaborazione e assistenza necessarie per la tutela della sicurezza nazionale», diceva l’articolo, e i servizi segreti «possono stipulare convenzioni con questi soggetti, nonché con le università e con gli enti di ricerca. Le convenzioni possono prevedere la comunicazione di informazioni anche in deroga alle normative di settore in materia di riservatezza».
L’esperienza di Barcellona dei primi anni del Duemila, cui fa riferimento il libro autobiografico di Marina Garcés, è ricca di indicazioni teoriche e politiche di cui far tesoro, ma è molto diversa dalla situazione di un Paese, come il nostro, governato da una destra estrema, amica di Vox, di Trump, di Milei, di Netanyahu, che fin dai suoi primi provvedimenti ha mostrato di voler criminalizzare i migranti, la marginalità, i centri sociali, la gestazione per altri. Impossibile dimenticare gli esordi, con il decreto Rave e l’istituzione di delitto universale per il traffico di esseri umani e la maternità surrogata. Via via fino al decreto Sicurezza: pene fino a 5 anni di carcere per la resistenza passiva e la rivolta anche non violenta in carcere o nei CPR; da 2 a 7 anni per l’occupazione abusiva di un immobile; fino a 2 anni di reclusione per l’impedimento della libera circolazione su strada ordinaria o ferrata, ostruita “con il proprio corpo”, se commessa da più persone.
Pensare insieme, oggi, vuol dire sapere dove ci troviamo; saperlo teoricamente e concretamente, fisicamente, dentro e fuori il mondo accademico, in uno sforzo per accostare saperi, linguaggi, pratiche capaci di rompere le gerarchie, non solo quelle tra chi parla e chi ascolta, ma anche quelle prodotte dall’autoreferenzialità dei mondi.
Marina Garcés scrive che dobbiamo “mettere in moto un’interlocuzione che allo stesso tempo sia un apprendimento”. Lo fa citando il Canetti di Massa e potere: “Solo tutti insieme gli uomini possono liberarsi dalle loro distanze”.
Aggiungo che solo tutti insieme, uomini e donne possono inventare una resistenza che sia crescita per la collettività.
Vorrei portare a questo confronto alcune linee di riflessione. La prima è legata alla necessità di radicamento sui territori, presenza dei corpi, riti come condivisione di una storia comune, ovvero di quella necessità che il grande antropologo Ernesto De Martino segnalava ai partiti della sinistra già negli anni Sessanta. Quanto il suo discorso sia ancora vivo, lo hanno dimostrato le enormi e impreviste manifestazioni contro lo sgombero del Leoncavallo, a Milano, e per la partenza della Global Sumud Flotilla preparata dai portuali di Genova.
Il secondo argomento riguarda la percezione della città tra reale ed eufemismo, tra natura e desertificazione. A Milano, la difesa del Leoncavallo è diventata una spinta di aggregazione tra generazioni, che ha mostrato la sofferenza, il fastidio, la repulsa verso una immaterialità fatta di specchi – come quelli che ricoprono i grattacieli – e di eufemismi: “giardino segreto”, “bosco verticale”, “biblioteca degli alberi”, “Salva Milano”: una bolla linguistica, prima ancora che immobiliare, per mascherare speculazione, grandi interessi economici, aggiramento e svuotamento delle leggi.
Milano è stata un esempio straordinario di come si possa costruire un mondo al contrario, usando parole che nascondono: riqualificazione, rendering, green…
Non sono solo le dittature a usare a piene mani gli eufemismi, lo fanno anche le democrazie, comprese quelle che si dicono di sinistra. Edward Bernays – tra i principali teorici delle tecniche di manipolazione dell’opinione pubblica – mostrava già negli anni Venti del Novecento come il discorso propagandistico delle società democratiche si basasse su un uso pervasivo dell’eufemismo.
Ed ecco dunque piazze ristrutturate con fondi UE per la ripresa dalla pandemia trasformate in una colata di cemento, roventi d’estate, alluvionate d’inverno, ridotte a spianate abbacinanti di pietre, senza un segno di vita a ricordarci che siamo viventi, che siamo natura, e che di natura abbiamo bisogno.
Finte piste ciclabili, glicini secolari abbattuti, parchi pubblici assaltati ed erosi.
Con l’accordo per la vendita dello Stadio di San Siro, a Milano si cementificheranno 53mila mq di verde, assicurando un’espansione del verde aumentata; si produrranno centinaia di migliaia di tonnellate di CO₂, sbandierando una pretesa neutralità carbonica. A un’operazione di totale subordinazione al privato, dove a guadagnare saranno i fondi speculativi, verrà concesso l”interesse pubblico”.
Dell’uso delle città, della loro riduzione a campo di speculazione, del loro essere sempre più sottratte alla natura – al punto che i passeri smettono di nidificare dove non trovano più anfratti nei vecchi muri, ma solo superfici lisce – dobbiamo fare una questione pienamente politica e costituzionale.
Il terzo argomento riguarda la sicurezza. Vediamo, negli Stati Uniti, gli uomini della Guardia Nazionale che il presidente Trump ha dislocato nelle città americane. Ma non dobbiamo ignorare le figure in divisa sparse a gruppi a camminare per le città o a far mostra di sé in capannelli ai mezzanini del metro o sui piazzali delle stazioni ferroviarie.
Ci abituano a vedere la polizia pattugliare le nostre città. Farle diventare spettacolo consueto fa parte di un processo comunicativo che normalizza la forza repressiva dello Stato e la sua esibizione, sgretolando poco per volta la cultura democratica che ha assegnato ai cittadini uno sguardo critico e vigile sulle modalità della cessione del monopolio della forza allo Stato. Così che poco per volta ci abituiamo all’uso del taser e alle sue conseguenze mortali in caso di cardiopatie o altre fragilità; o agli inseguimenti a sirene spiegate di giovani – forse ladruncoli, tossicodipendenti, migranti privi di documenti – che non si sono fermati a un alt intimato dalle forze dell’ordine, per poi magare finire schiantati contro un albero, o un muro.
La sicurezza non è questa. È quella che possiamo portare con politiche di accoglienza e inclusione nei nostri territori, perché ciò che affligge la nostra società non avviene in uno spazio irreale, ma nei luoghi; gli stessi che abitiamo e ai quali diventiamo sempre più ciechi: suicidi di minori, abbandono scolastico, violenza, femminicidi, incidenti sul lavoro, precarietà, povertà, abbandono dei marginali, dei fragili, di chi non ha cittadinanza.
È nei luoghi che abitiamo che avviene l’attacco alla grande conquista della de-istituzionalizzazione portata da Franco Basaglia, e il ritorno alle istituzioni chiuse: manicomi, CPR, RSA.
Per questo motivo voglio portare l’esempio delle Madri argentine di Plaza de Mayo, che seppero affrontare e sconfiggere una dittatura che – esattamente cinquant’anni fa, il 24 marzo 2026 – si instaurò causando trentamila desaparecidos. Le Madri ci hanno insegnato che i luoghi non si devono abbandonare. Lo hanno fatto con le panchine di Plaza de Mayo, davanti al palazzo del governo, dove ogni giovedì hanno tenuto fede alla loro storica marcia, e molte di loro, una volta morte, hanno voluto che fossero sparse le proprie ceneri. La loro casa, diventata poi università popolare, è stata un luogo dove hanno cucinato, studiato, fatto politica, organizzato manifestazioni e azioni per il territorio, per le fabbriche occupate, per i bambini abbandonati: i merenderos, i mercati autogestiti, i corsi di laurea sociale.
Credo che il progetto filosofico-politico che torna nel libro di Marina Garces, Occupare la speranza, richiamandosi all’idea lefebvriana del “diritto alla città”, sia un partecipare attivamente alla creazione e trasformazione dello spazio urbano e civico per rispondere ai bisogni della collettività di cui abbiamo immenso bisogno per fermare il disegno autoritario che abbiamo davanti.



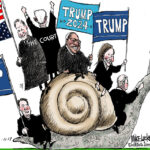






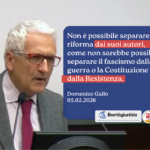



 Luigi Manconi
Luigi Manconi



