È curioso che quelli che nutrono maggiore speranza nella tecnologia siano quelli che hanno meno fiducia nella democrazia. Al gruppo degli autoritari noti si aggiungono ora tecnologi di grande fama. C’è una ragione che possa spiegare come mai coloro che formulano le promesse tecnologiche più audaci siano quelli che credono meno nelle promesse democratiche della conversazione egualitaria e della sovranità popolare? Esiste una connessione tra l’autoritarismo digitale e il pessimismo circa la condizione umana? A mio parere, il nesso concettuale tra le due disposizioni si trova nel modo in cui i tecnofili concepiscono il rapporto degli esseri umani con il futuro.
La tecnica è oggi sopravvalutata dai tecnosoluzionisti che la considerano adeguata a risolvere molti problemi la cui natura sembrerebbe richiedere altri tipi di procedure e logiche. Uno degli ottimismi più audaci consiste nel supporre che i problemi di natura politica abbiano una soluzione tecnica e che non sia necessario un intervento di altro tipo perché scompaiano come problemi. La tecnica si presenta così come un sostituto della politica; la democrazia sarebbe superflua, le sue procedure di deliberazione e decisione rappresentano un ostacolo quando disponiamo degli strumenti, dei calcoli e delle velocità forniti dalla tecnologia; il dibattito è una perdita di tempo, la regolamentazione un freno al progresso tecnologico e la sovranità popolare una consacrazione dell’incompetenza. La versione digitale dell’espertocrazia consiste oggi nella pretesa degli sviluppatori tecnologici di decidere per noi, senza perdere tempo in altre considerazioni.
Esistono distopie tecnologiche, ma anche un esagerato tecnosoluzionismo. Ray Kurzweil prevede da anni il superamento dell’intelligenza umana da parte di quella artificiale e, tra altre cose, la soluzione al problema dell’invecchiamento. Sam Altman, fondatore di OpenAI, annuncia altri trionfi come il ripristino del clima, la creazione di una colonia nello spazio e la scoperta dell’intero mondo fisico. Questi e altri annunci simili si basano sulla convinzione che il nostro futuro sarà deciso dalla tecnologia. Non solo la tecnologia risolverà i nostri problemi, ma dissolverà anche la natura problematica del futuro in generale, le angosce e i timori che produce un futuro che non conosciamo e che non riusciamo a dominare. Naturalmente lo sviluppo della tecnica ha risolto molti dei nostri problemi (allo stesso tempo sollevandone altri), ma la grande promessa dei nuovi signori della tecnologia non è tanto quella di risolvere quanto quella di dissolvere i problemi e, di conseguenza, far scomparire quel futuro problematico, con la sua incertezza e imprevedibilità. La stessa idea di porre fine all’invecchiamento e persino di garantire l’immortalità mira a salvarci dal futuro, che è proprio ciò di cui sono privi gli esseri immortali.
L’intelligenza artificiale promette parimenti l’immortalità digitale altrui e propone di trasformare i nostri defunti in avatar con cui chattare, tra l’altro senza il loro consenso. Perché? E che tipo di interazione si instaura tra un essere umano vivente e quell’essere che gli “imbalsamatori digitali” hanno ricostruito a partire dalle impronte digitali che ha lasciato prima di morire? Avremmo così un simulacro di parente immortale e interattivo che perfeziona la vecchia superstizione di chi credeva di sentire la voce dei propri predecessori. Potremmo arrivare a convincerci che quell’altro non è morto del tutto, che gli addii non sono più definitivi, come se la morte fosse un semplice cambiamento di stato e la digitalizzazione potesse fornirci una certa immortalità.
Qualsiasi promessa di immortalità digitale implica una mutazione della nostra condizione umana, che include temporalità limitata, futuro indeterminato e libertà di configurarlo. Liberarsi dal futuro non significa solo liberarsi da ciò che sta per arrivare, ma anche non dover decidere. Se la nostra vita fosse prolungata all’infinito grazie alla tecnologia, non dovremmo prendere alcuna decisione rilevante, né ci troveremmo di fronte a scelte che mettono in gioco la nostra sopravvivenza o quella delle nostre istituzioni. Saremmo in un presente continuo in cui avremmo solo il compito di ottimizzarlo, senza interrogativi radicali. Una tecnica così intesa non solo ci protegge da possibili mali futuri, ma ci libera dal futuro in generale in cui questi possibili mali potrebbero irrompere. Diventeremmo esseri ai quali, in fondo, non può succedere nulla. Alcune promesse dei tecnofili, oltre a non raggiungere tutti, hanno come obiettivo quello di porre fine a una condizione umana che considerano deplorevole e a tutto il suo corollario di incertezza, complessità e necessità di decidere. Si tratterebbe di sfuggire a quell’indeterminatezza che ci caratterizza: quella del futuro. Grazie allo sviluppo della tecnica, l’umanità raggiungerebbe finalmente uno stadio fisso e determinato, senza incertezze né controversie, protetta dai rischi della decisione, cioè senza umanità.
Il mito di Prometeo, che narra l’origine della tecnica, commentato da Platone, inizia con la constatazione di una carenza che caratterizza noi esseri umani: non avere artigli, né pelliccia, né ali, avere un corpo così poco specializzato per un compito specifico, ci rende gli unici esseri le cui facoltà non sono predeterminate. Il disagio di non essere come gli animali lo alleviamo con un furto che commettiamo ai danni degli dei: quello del fuoco che rende possibile la tecnica della forgiatura, che è un potere divino di creare e modellare le proprie facoltà, trasformando la nostra originaria inutilità in versatilità. Il furto prometeico compensa la nostra mancanza di animalità predeterminata con il potere di fare quasi tutto grazie alla tecnica. Non siamo animali che la biologia ha dotato di un’abilità specifica, ma grazie a questa indeterminatezza possiamo sviluppare abilità inaudite. Abbiamo rubato il potere di fare, ma non abbiamo smesso di essere animali, cioè esseri viventi la cui vita dipende da ciò che facciamo, una sopravvivenza che non è garantita dalla natura, ma assicurata artificialmente. Il futuro che avremo dipende da noi, non è predeterminato. Noi esseri umani non possiamo garantire il futuro né con il fissaggio naturale degli animali in un mondo determinato né con l’assimilazione agli dei; la nostra futura sopravvivenza deve essere continuamente creata, protetta, decisa, e questo attraverso una tecnica che non è inscritta nella nostra natura ma che sarà sempre il risultato di un furto, che è una metafora per designare la nostra artificialità.
Forse questo fa meglio intendere la coerenza degli autoritari digitali: si inizia affidandosi alla tecnologia che ci renderà immortali e si finisce con l’uccidere la democrazia. Non è un caso che Xi e Putin abbiano parlato di immortalità nel loro recente incontro a Pechino. Per affrontare gli autoritari dobbiamo affrontare alcune domande fondamentali. Perché solo gli esseri mortali hanno la democrazia? La democrazia ha senso solo in un essere che non è predeterminato, che deve decidere, il cui futuro dipende dalle proprie decisioni. Ecco perché i signori della tecnologia cercano di convincerci che qualcosa accadrà inevitabilmente (un’inevitabile disrupzione, il sorpasso dell’intelligenza artificiale, innovazioni tecnologiche che si verificherebbero solo in assenza di regolamentazione, ovvero se non decidessimo collettivamente come le vogliamo) e che insistere nel decidere insieme il futuro desiderabile sarebbe una perdita di tempo quando loro, investiti della loro autorità digitale, possono trasformare quella tecnica che, secondo la mitologia, è nata da un furto, in una proprietà che acquisiamo per tutta la vita, pagando però il prezzo che tutto sia deciso e predeterminato; che abbandoniamo quella condizione umana la cui indefinizione ci obbliga a discutere, negoziare e decidere: le cose che facevamo nei vecchi tempi dell’indeterminazione democratica.
[Innerarity ha da poco pubblicato con Galaxia-Gutenberg Una teoria critica dell’intelligenza artificiale, Premio Eugenio Trías per la saggistica. Questo articolo è la trascrizione del suo intervento alla seconda giornata di studi, promossa dall’Osservatorio autoritarismo, dedicata a “Intelligenza artificiale e democrazia” tenutasi il 12 settembre a Firenze, presso l’Istituto Universitario Europeo].



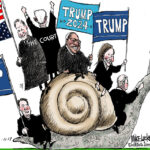






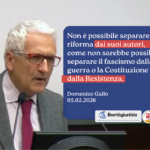



 Luigi Manconi
Luigi Manconi



