Sovranità popolare, stato di diritto, separazione dei poteri tra legislativo, esecutivo e giudiziario, tutela dei diritti fondamentali, principio di uguaglianza e pluralismo, libertà di espressione, partecipazione e manifestazione sono tra i pilastri delle costituzioni dei regimi democratici. Mentre, allibiti, vediamo smottare attorno a noi questi principi, che hanno fatto da cardine, almeno formalmente, all’universo di riferimenti di chi è nato in quello che chiamiamo Occidente, il rapporto 2025 di V-Dem – prestigioso centro studi svedese per l’analisi dello stato della democrazia nel mondo – mostra che per la prima volta negli ultimi vent’anni il numero di regimi autocratici è superiore a quello delle democrazie: 91 contro 88.
Il modello di democrazia liberale è il meno diffuso. Il 72% della popolazione mondiale (quasi tre persone su quattro, il dato più alto dal 1978) vive oggi sotto autocrazie. Il fenomeno non risparmia l’Europa, dove l’Ungheria è descritta come un’autocrazia elettorale, ovvero un regime in cui le elezioni vengono indette in condizioni tali da sottrarre all’opposizione ogni reale possibilità di vittoria. Segni preoccupanti sono registrati anche in Portogallo, Paesi Bassi, Cipro e Italia, dove i cambiamenti intervenuti dopo le elezioni americane dello scorso novembre, con il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, sembrano imprimere ulteriore slancio a dinamiche sempre più diffuse e contagiose di regressione democratica, consolidando processi già in atto.
È stato giocoforza, per l’Osservatorio Autoritarismo – nato da un manifesto promosso a marzo di quest’anno da Libertà e Giustizia e Castelvecchi editore, sottoscritto da più di trecento intellettuali e docenti universitari italiani e stranieri, tra cui Judith Butler, James Galbraith, Gustavo Zagrebelsky, Giorgio Parisi – iniziare il percorso di riflessione sul presente intrapreso con il ciclo “Autoritarismi in democrazia” proprio dal libro Trumpismo. Un mito politico di Chiara Bottici, firmataria del manifesto, filosofa alla New School for Social Research di New York. L’incontro, la cui registrazione video è accessibile sul canale YouTube di Casa della Cultura, mentre un ampio stralcio audio costituisce il primo dei podcast di Radio Popolare, media partner del ciclo – co-organizzato dall’Università Statale di Milano-Human Hall – ha colpito i presenti per la potenza testimoniale, oltre che per gli sviluppi teorici, di chi, come Bottici, negli Stati Uniti di Trump si trova a temere non solo di vedersi revocare la green card senza altro motivo che non sia l’occuparsi di argomenti invisi – come studi di genere, politiche di migrazione o studi postcoloniali – o insegnare in una delle università assurdamente considerate da Trump roccaforti dell’antisemitismo o della cultura woke, ma di essere soggetto agli arresti illegali effettuati dalle squadre dell’ICE (Immigration and Customer Enforcement), l’agenzia federale statunitense parte del Dipartimento della sicurezza interna che irrompe nelle case, nei ristoranti e perfino negli asili a caccia di sospetti clandestini da deportare senza alcuna prova di reato, e anche di cittadini statunitensi, come dimostra un’inchiesta di ProPublica che denuncia l’arresto illegale di almeno 170 persone, fra cui tre donne incinte e almeno venti bambini.
Chiara Bottici vede l’ascesa di Trump alla presidenza degli Stati Uniti e il dispiegarsi delle politiche del suo secondo governo come una tra le principali manifestazioni della risorgenza di forme di fascismo, sempre presenti nelle nostre democrazie, che descrive come fiumi carsici: un “tipo” ideale, uno strumento euristico che può essere usato per confrontare e comprendere diverse forme di potere. Il trumpismo incarnerebbe così una forma ibrida di neofascismo dove, accanto al mantenimento del rispetto formale delle caratteristiche della democrazia rappresentativa, la violenza emerge come prassi del potere, inculcando l’idea che non si possa fare reale affidamento sui diritti costituzionali perché perennemente soggetti alla possibilità di essere arrestati, picchiati, deportati in uno Stato diverso da quello di residenza ed eventualmente espulsi. Uno stato di intimidazione che va di pari passo con la destrutturazione del linguaggio, anche visivo, delle istituzioni.
Le immagini generate dall’IA di un presidente che alzandosi in volo bombarda di feci i manifestanti del movimento No-King, o quelle reali in cui zittisce una giornalista scomoda chiamandola «piggy» producono il medesimo effetto di sospensione della realtà e di progressivo smottamento di ciò che in una democrazia è ritenuto inaccettabile.
Contemporaneamente, l’identificazione degli elettori con il leader è tale che la stessa persona che durante la prima campagna presidenziale, nel gennaio 2016, poteva affermare: «Potrei stare nel bel mezzo della Fifth Avenue e sparare a qualcuno e non perderei alcun voto»; che durante la pandemia di covid-19 poteva assicurare in una conferenza stampa di ritenere che l’ingestione di varechina potesse sconfiggere il virus; che, non accettando il risultato elettorale che lo vedeva sconfitto nelle elezioni del 2020, ha potuto incitare i suoi seguaci all’assalto di Capitol Hill, è stato rieletto con la maggioranza dei voti.
Tornano alla mente le parole con cui Hannah Arendt, ne Le origini del totalitarismo, si riferiva alla funzione politica della realtà e alla sua soppressione nei totalitarismi: «Il suddito ideale del regime totalitario non è il nazista convinto o il comunista convinto, ma l’individuo per il quale la distinzione fra realtà e finzione, fra vero e falso non esiste più».
Il dominio degli oligarchi dell’intelligenza artificiale e degli algoritmi che detengono dati, potenza computazionale, modelli, brevetti, piattaforme digitali e reti di sorveglianza, influenzando di fatto comportamenti sociali e scelte politiche, ancora non esisteva.



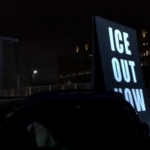

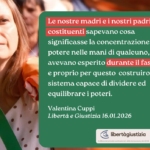








 Luigi Manconi
Luigi Manconi



