1) Nella riforma costituzionale intitolata «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare» c’è soprattutto un elemento che pare ancora non sufficientemente messo in luce, forse anche in ragione del tentativo di scansare i relativi problemi tecnico-giuridici. Questo elemento è il carattere prevalentemente distruttivo della riforma, e cioè l’intento di demolire, senza offrire credibili alternative, taluni pilastri della disciplina costituzionale della giurisdizione, e di ridurre, quindi, le garanzie date ai cittadini al fine di offrire contro il potere giudiziario maggiore spazio di azione al potere politico.
2) Anzitutto, è subito da notare che, contrariamente alla vulgata che si va diffondendo, la riforma non tocca la “separazione delle carriere” tra magistrati giudicanti e pubblici ministeri, la quale del resto neppure è menzionata come tale né nell’intitolazione né nel testo della legge costituzionale di riforma.
La “separazione delle carriere”, intesa come restrizione o impedimento al transito dei pm nella magistratura giudicante e viceversa nel corso appunto della rispettiva “carriera”, può essere del resto realizzata, come in larga misura si è già fatto, con legge ordinaria e senza alcuna modificazione della Costituzione. Il che è quanto basta ad assicurare pienamente, sotto l’aspetto del loro statuto personale, che i magistrati giudicanti non abbiano a considerare i pm come propri colleghi con cui collaborare anziché considerarli parti alla pari degli accusati, in ossequio ai principi del processo accusatorio varati sin dal 1988.
È chiaro poi, ma va sé, che ai fini della “parità delle armi” nel processo penale di cui all’art. 111 Cost. non basta la disciplina acconcia dello statuto personale dei magistrati, ma occorre altresì una non superficiale rimeditazione dei poteri, ancora squilibrati a vantaggio del pm, rispettivamente accordati ad accusa e difesa nelle varie fasi del processo. Per intervenire su questo squilibrio, davvero cruciale, bisogna tuttavia entrare nello specifico e nel dettaglio del processo penale, come non si addice alla Costituzione e può, invece, ancora una volta essere fatto con legge ordinaria.
3) La legge di riforma non riguarda comunque la “separazione delle carriere” tra la magistratura requirente e quella giudicante, nel senso appena sopra specificato, ma semmai mira a “distinguere” le carriere stesse. Nell’art. 102 cost. riformato viene infatti inserito, come compito nuovo delle “norme sull’ordinamento giudiziario”, quello di stabilire “altresì le distinzione tra la magistratura giudicante e la magistratura requirente”. Le carriere dei pm e dei magistrati giudicanti non sono dunque semplicemente “separate” nel senso che il magistrato, scelta l’una, non può transitare disinvoltamente nell’altra. Oltrechè “separate” per legge ordinaria la magistratura giudicante e la requirente sono anche, per costituzione, “distinte”. E ciò cambia notevolmente le cose, giacché nel linguaggio comune, con cui pure vanno intese le disposizioni costituzionali, la “distinzione” implica, come primo significato, la differenza o la diversità e, segnatamente, il “riconoscere e l’affermare una intrinseca diversità fra esseri, oggetti, concetti, situazioni, ecc.” (così il Vocabolario Treccani della lingua italiana).
Ne viene pertanto la possibilità di sancire, nell’ambito dell’ordinamento giudiziario, un diverso trattamento ed un diverso statuto personale per i magistrati giudicanti e i requirenti, anche quanto a posizione organizzativa e garanzie, con ovvio contraccolpo su autonomia ed indipendenza.
Il che trova con la riforma ulteriore riscontro anche nell’art. 104 cost., nel cui testo riformato, se permane la proclamazione della magistratura come “ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere”, viene aggiunto che la stessa magistratura ha carattere composito, ossia “è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente”, tra loro distinte in base all’art. 102 Cost..
Il mettere insieme, e coniugare come principi con lo stesso rilievo, l’ “autonomia” ed “indipendenza” per tutti i magistrati con una vaga ed imprecisata differenza o diversità tra la carriera requirente e quella giudicante è palesemente contraddittorio e, ad essere generosi, equivale a rendere ambigui, o se si preferisce passibili di numerose varianti attuative, gli artt. 102 e 104 Cost.
La “distinzione” tra pm e giudicanti rimane impregiudicata, ma proprio per questo lascia ampia discrezionalità alla legge ordinaria, non solo e non tanto quanto alla distanza che allontana la magistratura requirente dalla politica, ma anche quanto a missione complessiva da assegnare, appunto distintamente, alla magistratura requirente medesima.
Una delle possibilità oggi non data, o data come forzatura, ma a cui la riforma spianerebbe la strada potrebbe essere quella, ad esempio, di dosare l’indipendenza ed il carattere persecutorio dell’attività della magistratura requirente, esonerandola, magari con l’ eccezione per talune fattispecie di reato coinvolgenti funzionari pubblici o politici, dal principio per cui il pubblico ministero “compie e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini” (art. 358 cpp). Con ripercussioni non proprio innocenti nel ridurre la tutela dei diritti dei cittadini specificamente nella giurisdizione penale e nel conferire all’organizzazione giudiziaria un’impronta autoritaria.
4) In questo contesto si inserisce poi, ulteriormente, lo sdoppiamento in due del CSM, con un collegio per i pm ed uno per i giudicanti – ad asserito coronamento della “distinzione” interna alla magistratura – nonché la formazione di tali collegi per sorteggio, anzichè per elezione come sino ad ora accaduto.
I sorteggi per la formazione dei due collegi sono peraltro, nella riforma, congegnati con modalità diverse a seconda della competenza a nominare i componenti. Poichè:
- per un terzo i componenti dei due CSM sarebbero comunque estratti a sorte da un “elenco” che il parlamento “compila mediante elezione” tra professori universitari di materie giuridiche ed avvocati con quindici anni di esercizio, peraltro senza che l’art. 105 cost. riformato si preoccupi di sancire quanto lungo debba essere l’ “elenco” e se questo possa essere votato in blocco; dal momento che l’art. 105 cit. non fissa neanche una maggioranza qualificata per l’elezione tutto viene quindi demandato alla legge ordinaria di attuazione, la quale potrebbe tranquillamente congegnare un sorteggio da un “elenco” cortissimo e da votare appunto in blocco a maggioranza coincidente con quella per dare la fiducia al Governo ; il che muterebbe completamente il significato della presenza nei CSM di tali “membri laici” , la quale non sarebbe più un temperamento allo spirito di corpo dei membri tratti invece dalla magistratura, come è stata nella Costituzione del 1948, ma diventerebbe mero strumento della politica governativa;
- i restanti due terzi dei componenti di ciascun CSM, tratti dalla magistratura, sarebbero invece sorteggiati direttamente tra tutti i magistrati, distinguendo tra i requirenti ed i giudicanti.
5) I sostenitori di questa soluzione per comporre i CSM hanno spesso dichiarato, difendendo il doppio CSM ed il metodo del sorteggio, che una tale riforma costituirebbe l’unico modo per ottenere, d’un solo colpo, che i giudicanti non possano aver parte nei deliberati riguardanti i PM e viceversa, da un lato, e, d’altro lato, per ottenere che le diverse “correnti” dell’Associazione nazionale magistrati (ANM) non possano essere protagoniste dello stesso CSM sdoppiato, con un effetto di inquinamento, distorsione e scarsa trasparenza che già si sarebbe manifestato in passato.
Questa prospettazione, però, è, oltre che illusoria, anche completamente infondata per una pluralità di profili.
Anzitutto, e da una parte, lo sdoppiamento del CSM, per evitare che le deliberazioni non siano condivise tra magistrati giudicanti e requirenti, è il segno preciso che la “distinzione” delle “carriere” si spinge sino alla differenziazione di “autonomia” ed “indipendenza”, il cui presidio è l’unico ed essenziale scopo che il CSM medesimo ha sempre avuto e dovrebbe continuare ad avere per l’intera magistratura.
In secondo luogo, d’altra parte e considerato che la maggior parte dei magistrati aderisce all’ ANM, non si vede come e perchè si possa presumere che scegliere tra i magistrati medesimi con sorteggio possa garantire la loro estraneità o perlomeno il loro distacco dalle “correnti” che animano internamente la vita associativa dell’ANM stessa. Semmai, si dovrebbe presumere che, adottando il sorteggio per selezionare i magistrati da collocare nei CSM, si otterrebbe che il peso delle diverse “correnti” per le deliberazioni non sia più ragguagliabile al numero dei loro aderenti, ma dipenda esclusivamente dal caso; il che non pare possa portare dei concreti vantaggi di equità, rettitudine o trasparenza, e, anzi, potrebbe solo acuire il disorientamento in seno ai CSM.
In realtà, il più semplice ed autentico presidio di equità, rettitudine e trasparenza dei componenti dei CSM potrebbe essere quello di irregimentarne più convenientemente i poteri deliberativi, tipizzandone con legge ordinaria modalità e criteri di esercizio che oggi restano sovente affidati alla disciplina per essi deliberata, con atti formalmente amministrativi, dal CSM stesso. Tanto più che il sorteggio, quando come nel caso nostro per i magistrati diventa l’unico criterio di selezione, è un criterio cieco, il quale non ammette alcuna valutazione di professionalità ovvero di capacità, attitudine e preparazione del designato a svolgere il compito assegnato.
Non bisogna dimenticare, al riguardo, che qui si tratta di comporre i CSM, i quali, anche dopo lo sdoppiamento voluto con la riforma, hanno, per Costituzione, il compito di deliberare su “le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati”. E questi sono compiti organizzativi con sostanza di amministrazione del personale che, durante tutta la sua carriera, nessun singolo magistrato esercita mai, restando invece normalmente solo impegnato in processi giurisdizionali, in veste di requirente o di giudicante, per rendere singoli giudizi.
La compartecipazione alle deliberazioni dei CSM richiede dunque attitudini, capacità e conoscenze che esondano ed esulano largamente da quelle richieste nel singolo giudizio civile o penale. E sembra più che azzardato supporre che le attitudini, capacità e conoscenze per fare ingresso nei CSM si possano ritrovare simili in tutti i magistrati.
In altre parole, è solo per rapporto allo svolgimento appunto di singoli giudizi civili o penali che i magistrati possono essere reputati tra loro parimenti legittimati. Quanto invece a compiti organizzativi ed amministrativi pur assai rilevanti anche per “autonomia” ed “indipendenza” del magistrato, come quelli dei futuribili CSM, il possesso di idonee attitudini, capacità e conoscenze in capo a chi i compiti stessi sia chiamato ad esercitare è tutto da verificare. E da questo punto di vista, mentre l’elezione dei membri dei CSM da tutti gli altri magistrati può dare almeno la garanzia di una scelta ragionata da parte di chi dovrebbe poi subire le conseguenze dell’attività esercitata dagli eletti, il sorteggio non può garantire alcunché di concreto né di probante.
La riforma, in definitiva, recide il collegamento della partecipazione dei magistrati ai CSM con la garanzia di “autonomia” ed “indipendenza”, introducendo come vacua alternativa il sorteggio; il quale sorteggio, anche storicamente, è stato praticato in contesti democratici per selezionare collegi deliberativi solo allorché non soccorressero altri accettabili mezzi di scelta.
Né, a scanso di equivoci, la situazione problematica che sarebbe innescata con il sorteggio dei magistrati da inserire nei CSM potrebbe essere lenita dall’effettivo realizzarsi dell’eventualità, dischiusa come si è detto dall’art. 105 cost. riformato, che i “membri laici” di designazione parlamentare possano essere eletti dalla sola maggioranza di governo. Poiché questa eventualità dà adito a due ipotesi: può darsi che i “membri togati” sorteggiati tra i magistrati si ritirino in buon ordine, piegandosi agli orientamenti non più plurali ma univocamente legati agli indirizzi politici governativi dei “membri laici”, oppure può darsi che i CSM divengano sedi di conflitto permanentemente attivo tra l’affermazione degli indirizzi politici stessi del Governo e le rivendicazioni di “autonomia” ed “indipendenza” della magistratura.
6) L’ “autonomia” e l’“indipendenza” della magistratura, nella riforma costituzionale, sono infine ulteriormente toccate dal cambiamento circa gli accertamenti delle responsabilità disciplinari dei magistrati.
La competenza per i giudizi disciplinari, deferita in precedenza al CSM che l’ha esercitata attraverso una propria apposita Sezione, viene infatti trasferita ad una Alta Corte a sé stante, costituita come giudice speciale, in quanto tale avente almeno due peculiari aspetti, alquanto insoliti, da segnalare.
Va segnalato, intanto, che, a differenza di quel accade per le decisioni di tutti gli altri giudici speciali, per principio dettato dall’art. 111 cost. impugnabili in Cassazione non foss’altro per l’eccesso di giurisdizione, le decisioni dell’ Alta Corte disciplinare dei magistrati sono, per via di eccezione espressa della riforma, non impugnabili, se non dinanzi alla stessa Alta Corte in diversa composizione. L’Alta Corte è pertanto l’unico giudice speciale che, nell’ordinamento italiano, può essere totalmente autoreferenziale per qualunque suo giudizio. E ciò non è senza ripercussioni, poichè, nel contempo ed a differenza di quel che accadeva con il vecchio CSM e la sua Sezione disciplinare, il giudizio disciplinare sui magistrati non è più necessariamente un giudizio di pari, ossia non è più necessariamente il giudizio di un collegio composto prevalentemente da magistrati eletti in seno alla magistratura.
L’Alta Corte è invero composta da tre membri nominati dal Presidente della Repubblica, tre membri sorteggiati nell’ambito di “elenco” compilato dal parlamento attraverso “elezione”, nonchè sei membri tratti dalla magistratura giudicante e tre tratti dalla magistratura requirente, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie “con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità”. A parte l’iter di nomina, per cui possono valere osservazioni analoghe a quelle già avanzate per i CSM riformati, ed a parte l’ancoraggio del sorteggio dei magistrati al requisito di anzianità ventennale, che sembra elevare l’anzianità medesima in sé a requisito decisivo – riecheggiando impostazioni delle procedure comparative per i trasferimenti e per il conferimento di uffici direttivi ormai per fortuna superate – nel complesso della composizione dell’Alta Corte il peso dei magistrati è minore che non nei CSM stessi (3 quinti invece che 2 terzi).
Ma ancor più di ciò è da segnalare che l’Alta Corte, come accennato anche ai fini dell’impugnativa delle sue decisioni, deve articolarsi in una pluralità di collegi giudicanti, la cui configurazione è rimessa dall’art. 105 cost. riformato al legislatore ordinario, con il solo vincolo di assicurare che in ciascun collegio i magistrati giudicanti o requirenti siano “rappresentati”, non si sa come e quanto; in tal guisa consentendo, ostentatamente, che la rappresentanza della magistratura si esaurisca in una presenza assolutamente minoritaria all’interno dei collegi giudicanti.
Per quanto si legga e si rilegga il disposto della riforma su questa Alta Corte è arduo sfuggire alla constatazione che esso sia teso a colpire i magistrati con un inasprimento della giustizia disciplinare che risulta non avere precedenti in Italia, se non nel regno e durante il fascismo; i magistrati diverrebbero, in età repubblicana, gli unici funzionari pubblici italiani a non avere strumenti per ricorrere ad altri e diversi organi giudiziari contro le decisioni di condanna disciplinare; con la particolarità, di sicuro non frequente per funzionari pubblici a cui sono richieste professionalità qualificate anche sul piano tecnico-scientifico, che nel collegio il quale li giudica la presenza di figure con la loro stessa professionalità potrebbe essere largamente minoritaria.
7) Convivenza del principio di “autonomia” ed “indipendenza” della magistratura nel suo complesso con un principio di “distinzione” tra magistrati requirenti e giudicanti che invece spinge verso una differenziazione della posizione e dello statuto personale dei magistrati a seconda della “carriera”, con modalità e sostanza impregiudicate ed abbandonate nelle mani della legislazione ordinaria; introduzione di una composizione dei CSM che potrebbe ridursi alla sommatoria di “membri laici” espressi politicamente dalla maggioranza di governo con “membri togati” tratti dalla magistratura in maniera totalmente casuale, con esiti incontrollati ed incontrollabili; organizzazione a sé stante dei giudizi disciplinari, in funzione di un trattamento dei magistrati deteriore a paragone di altri alti funzionari dello Stato: poiché è in questo che si riassume l’ultima sostanza della riforma costituzionale, c’è n’è d’avanzo per concludere che si destruttura l’esistente senza fornire un disegno diverso di adeguata solidità.
Sotto questo profilo, chi lamenta solo o soprattutto che la riforma toccherebbe temi di minore importanza e non recherebbe alcun contributo alla soluzione dei problemi più grandi ed urgenti, a cominciare da quello della durata dei processi, dà una valutazione che suona assolutoria. In realtà, il fatto è che i temi comunque fronteggiati dalla riforma sono basilari ed anche urgenti, tra quelli da risolvere in sede costituzionale, ma la riforma, limitandosi per lo più a cancellare quel che si è fatto o si sta facendo, non offre per il futuro indicazioni plausibili e tantomeno risolutive.
Dal che potrebbe venire anche il sospetto che l’intenzione della maggioranza di governo, nel proporre la riforma e nell’approvarla, sia stata, piuttosto che quella di intervenire su questioni indilazionabili e bisognose di risposte immediate, l’intenzione di giungere ad un redde rationem nei confronti della magistratura, sollecitando avverso la stessa, reputata indebitamente invasiva della sfera politica, un pronunciamento popolare di carattere egualmente politico nel referendum sulla legge costituzionale.
A rendere attuale l’interrogarsi su questo sta la circostanza, per sé strana, che a richiedere la sottoposizione della legge costituzionale a referendum siano stati per primi, prevenendo qualunque iniziativa di opposizione, proprio i parlamentari della maggioranza governativa che la legge costituzionale ha varato. La circostanza è davvero strana perché è pacifico che la richiesta di referendum sospende e potenzialmente, qualora gli elettori votassero in tal senso, potrebbe bloccare definitivamente l’entrata in vigore della riforma. Mentre, qualora non fosse stata richiesta la consultazione referendaria, la legge sarebbe stata direttamente promulgata, entrando in vigore.
In apparenza, la maggioranza di governo è andata in contraddizione perché, chiedendo referendum, ha esposto a rischio la legge da essa stessa approvata. Ma la contraddizione non ci sarebbe, se non come mera apparenza, se alla maggioranza di governo interessasse, più che l’entrata in vigore della legge, una censura politica del popolo, in sede referendaria, contro la magistratura.



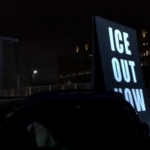

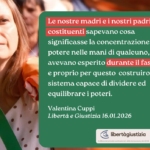






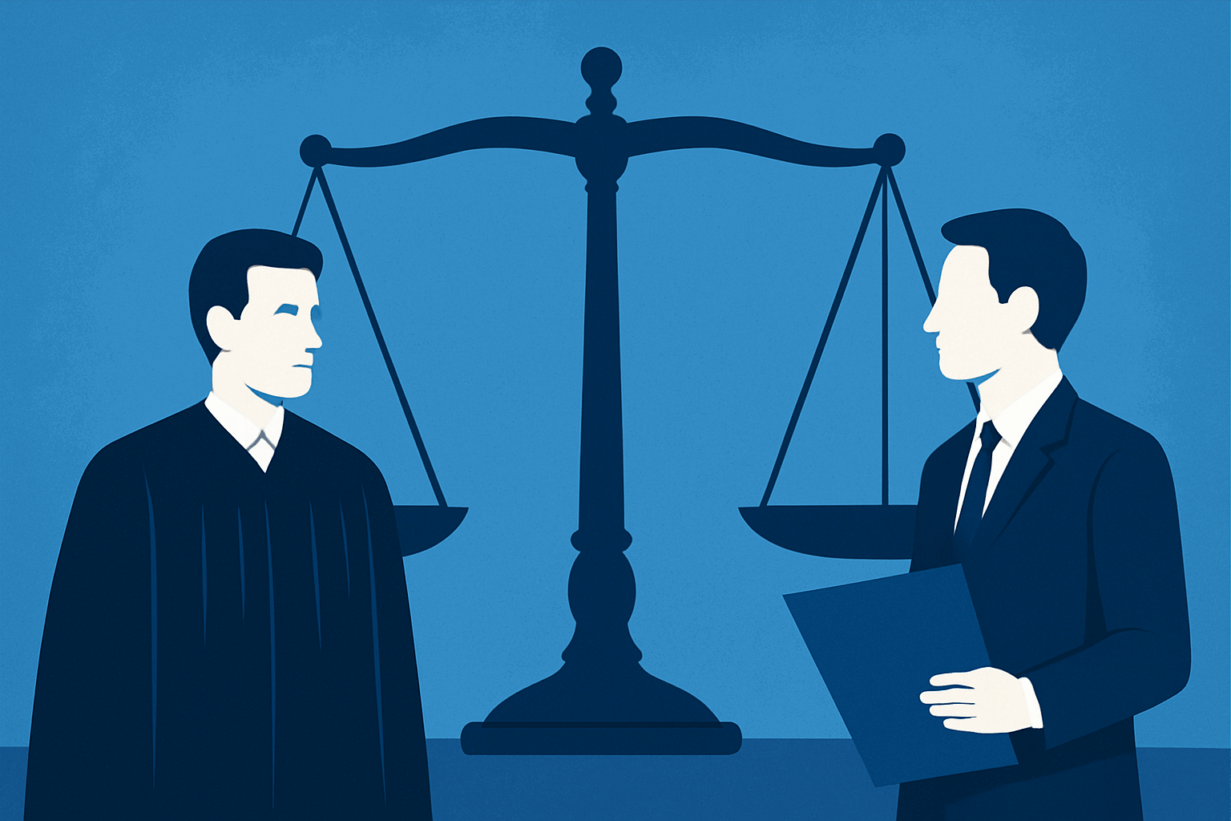


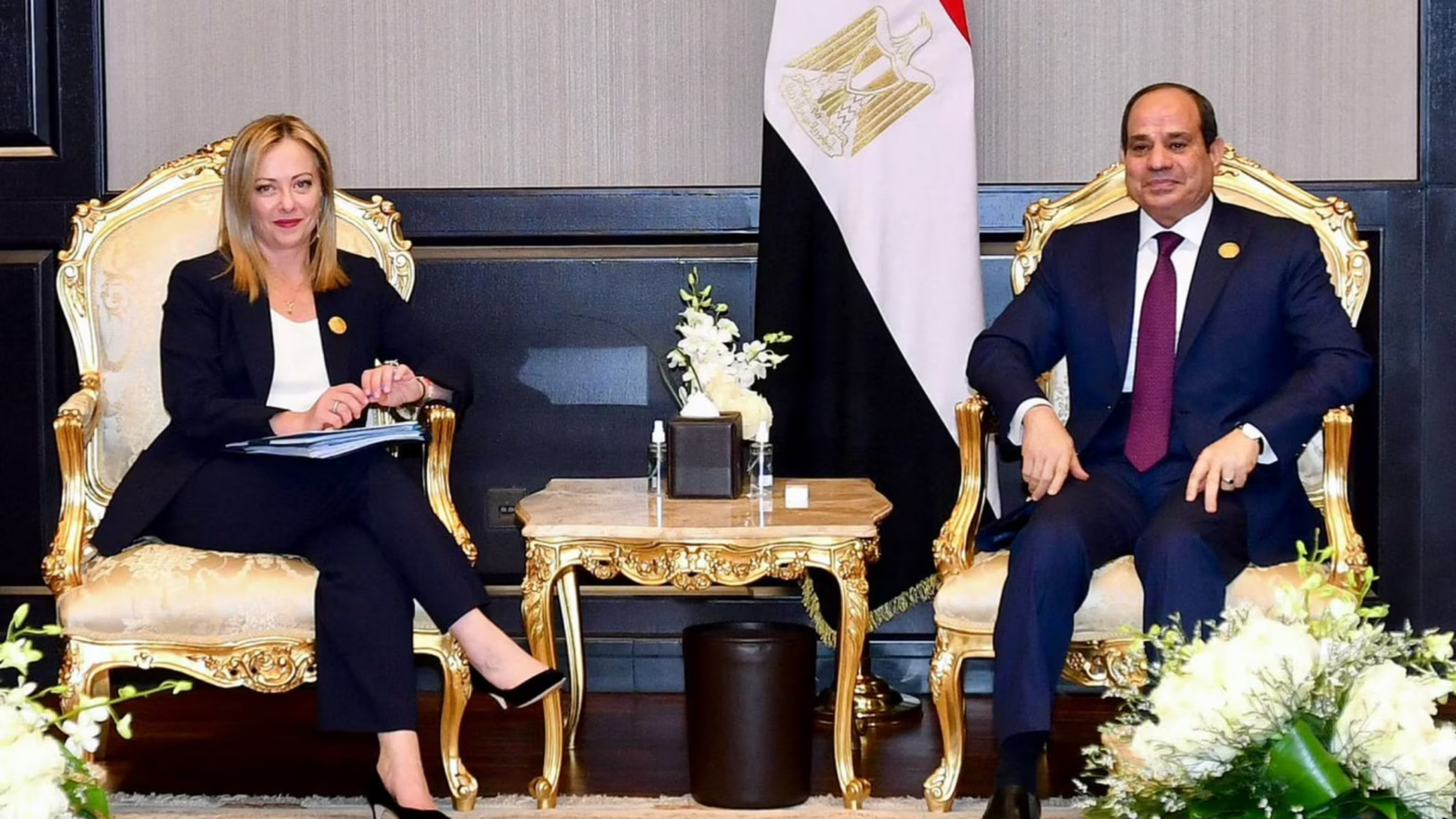
 Domenico Gallo
Domenico Gallo

