A che serve la riforma Nordio? La separazione delle funzioni nella magistratura è prevista dall’attuale ordinamento e, nel corso degli anni, ha trovato sostenitori da entrambe le parti dello schieramento politico.
La legge approvata nel 2022, che porta il nome dell’allora ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha introdotto vincoli stringenti al passaggio di funzione da inquirente a giudicante, consentendo un solo passaggio entro i primi nove anni dall’entrata in servizio. È pertanto evidente che la riforma Nordio non ha semplicemente questo obiettivo.
Due obiettivi
Due sono gli obiettivi. Uno simbolico: andare alla riforma della Costituzione del 1948, un testo non amato (e questo è un eufemismo) da questo governo. Uno programmatico: usare la riforma Nordio come ballon d’essai per saggiare l’opinione popolare sulla «madre delle riforme», il premierato.
Cambiare radicalmente il titolo IV della seconda parte della Costituzione repubblicana è come il prologo di una vera Seconda repubblica.
La riforma Nordio è radicale. Introduce la divisione delle carriere e va oltre la separazione delle funzioni, per cui l’aspirante magistrato dovrà decidere se fare il pm o il giudice e, sulla base di tale scelta, partecipare a un concorso pubblico o all’altro, sottostando alle norme e al controllo di uno dei due Consigli superiori della magistratura. Due magistrature con due governi, ovvero due Csm. Una cesura radicale che mina l’indipendenza della giustizia. Dividere è diminuire il potere.
La logica della riforma Nordio non consiste nel distinguere le funzioni. La logica è, semmai, il controllo politico (da parte del ministero competente e quindi della maggioranza di governo) sulla funzione svolta dalla magistratura inquirente (i pubblici ministeri), ossia quella che dirige le indagini preliminari e coordina la polizia giudiziaria. Questa magistratura sarà meno indipendente rispetto a quella giudicante. Ed è importantissima, come lo è la prima fase della giustizia, quella che sta in una relazione vicinissima con le forze di polizia e con il potere repressivo.
Chi ha scritto la Costituzione, e aveva vivissima la memoria dell’esperienza autoritaria e poliziesca del regime fascista, sapeva che il primo gradino verso la libertà della persona sta nel definire la latitudine dell’indipendenza del potere inquisitivo e giudicante – potere unico, secondo la Carta del 1948, suddiviso internamente tra chi dirige e svolge le indagini e chi dirige e giunge al giudizio finale.
Si tratta di due funzioni strettamente collegate e che devono entrambe essere esercitate nella più completa indipendenza da altre autorità, in primis quella politica.
Il governo autoritario di questa Italia ha preparato la strada alla riforma Nordio con leggi che non soltanto inaspriscono alcune pene, ma aggiungono anche reati e rendono il dissenso stesso al limite del lecito. Sono i diritti civili fondamentali che questo governo tiene sotto tiro. Non c’entra nulla, in tutto questo, il garantismo. Proprio nulla.
Questa riforma, che idealmente ci porta all’Italia pre-Costituzione, ha il seguente obiettivo: proteggere chi è socialmente protetto e intimidire i cittadini ordinari, ossia la democrazia. Se già assistiamo a giudizi opinabili e a trattamenti benevoli per amici e parenti dei potenti, domani ciò sarà ordinaria amministrazione. Ai poveracci resteranno i ceppi, più duri di quelli che hanno ora.
Calamandrei vs Rocco
È Alfredo Rocco l’ispiratore della riforma Nordio. Rocco era il grande giurista del regime fascista, autore del Codice penale che prevedeva una scissione rigida tra la funzione di accusa (pubblico ministero) e quella di giudizio (giudice). Proprio come la riforma Nordio.
Piero Calamandrei, uno dei padri fondatori della nostra Costituzione, si oppose a due magistrature, una dei giudici e una dei pubblici ministeri, sostenendo che la Costituzione italiana, nata dall’esperienza antifascista, aveva scelto un ordine giudiziario unitario per garantire l’indipendenza della magistratura e proteggere i cittadini dalle pressioni politiche.
Secondo Calamandrei e altri, una giustizia divisa rischiava di indebolire le garanzie della libertà e dello stato di diritto, riducendo la capacità della magistratura di fungere da presidio dei diritti fondamentali.
Le ragioni di Calamandrei per l’unità della magistratura (non due Csm) erano che tale divisione avrebbe compromesso l’indipendenza del potere giudiziario, indebolendo la sua capacità di proteggersi (e, insieme a essa, tutti noi) dalle pressioni politiche. Quindi, quando si legge che anche Calamandrei avrebbe condiviso questa riforma, si legge il falso.
Calamandrei definiva l’unità della magistratura «la sentinella della libertà», perché, senza una giustizia autonoma, la democrazia diventa un guscio vuoto. Proteggere l’unità della giustizia significa proteggere tutti noi. No, alla divisione. Sì, alla nostra libertà. Il partito della fiamma non offre garantismo.






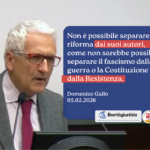








 Luigi Manconi
Luigi Manconi



