Per capire l’accelerazione che il governo ha imposto all’iter parlamentare della legge di revisione costituzionale sulla giustizia dal titolo Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare, approvata in quarta lettura al Senato il 30 ottobre scorso, con tempi contingentati e senza emendamenti – privando così il Parlamento della funzione di confronto democratico che dovrebbe essergli propria – bisogna tornare al programma elettorale con cui Fratelli d’Italia si presentò al voto nel 2022.
Al punto 22, intitolato Una giustizia giusta e celere per cittadini e imprese, si trova un esordio sorprendente, che chiama in causa chi difese la Repubblica romana dalle ambizioni di potere di Catilina e Marco Antonio:
«”Non può essere veramente onesto ciò che non è anche giusto”, scrisse Cicerone. Onestà e giustizia sono concetti che si fondono e che rappresentano la stella polare che traccia la rotta. Serve una riforma della giustizia che metta fine alle storture a cui abbiamo assistito negli ultimi decenni e che sappia coniugare le necessarie garanzie con l’equità e la velocità dei processi. L’Italia merita una giustizia più giusta, vicina ai cittadini e alle imprese».
Quanto fosse importante, per il partito di maggioranza, installare alla lettera, nell’hardware della nostra Costituzione, il pacchetto di istruzioni declinato al punto 22, è mostrato dalla dichiarazione rilasciata dalla presidente del Consiglio subito dopo il voto al Senato, la sera del 30 ottobre: «L’Italia prosegue il suo cammino di rinnovamento, per il bene della Nazione e dei suoi cittadini, perché un’Italia più giusta è anche un’Italia più forte». Ma più ancora è mostrato dalla dichiarazione dell’altro promotore della riforma, il ministro della Giustizia Carlo Nordio quando nel 2024, nella relazione annuale sull’amministrazione della giustizia, spiegava:
«Il Ddl di riforma costituzionale volto a separare le carriere dei magistrati, per i quali vengono istituti due Consigli superiori, oltre all’Alta Corte disciplinare, è promanato direttamente dal programma elettorale, perché la riforma della giustizia era tra i primi punti del programma, era un obbligo, un dovere verso gli elettori».
In quel programma – non a caso all’ultimo punto, come un coronamento – trovava posto la «riforma presidenziale dello Stato», poi trasformata in «premierato» ma ugualmente concepita per attuare la concentrazione del potere nelle mani dell’esecutivo e del suo leader, voluta da una destra che non ha mai mancato occasione di richiamarsi a due entità metafisiche, il Popolo e la Nazione, l’uno investitura e crisma, l’altra gabbia istituzionale e procedurale per la trasformazione dei cittadini in individui la cui libertà e i cui diritti trascolorano in privilegi accessibili in virtù della vicinanza al potere. Un vasto progetto con l’ambizione di instaurare un populismo tecnico più attento alla governabilità che alla coesione e alla giustizia sociale, che per affermarsi deve ridisegnare gli equilibri tra i poteri dello Stato con un passaggio che metta mano alla Costituzione, svilendo la magistratura, dividendola e ponendola sotto il controllo dell’esecutivo.
Per quanto si provi a esaminarla nei suoi aspetti tecnici, appare questa la ratio di una riforma che dichiara la sua necessità in una separazione delle funzioni tra giudice e pubblico ministero – che nella sostanza è già stata attuata dalla riforma Cartabia e che interessa un numero limitatissimo di magistrati – per procedere invece alla disarticolazione del Consiglio Superiore della magistratura, l’organo di autogoverno che tutela autonomia e funzionamento della magistratura ordinaria, sottraendo ai magistrati il diritto di eleggerne i membri. Descritti come correntizi, politicizzati, in fondo immeritevoli del metodo democratico, i componenti togati del Csm dovranno essere estratti a sorte tra quasi novemila tra giudici e pubblici ministeri, senza alcun criterio di valore o competenza, mentre i componenti laici (avvocati e professori universitari in materie giuridiche) saranno estratti tra alcune decine di nomi individuati dal Parlamento, dove la maggioranza risponde all’esecutivo.
Nella medesima logica di svilimento dell’autonomia della magistratura va l’introduzione di un’Alta Corte disciplinare, separata dal Csm, davanti alla quale si svolgerebbero i giudizi disciplinari riguardanti i magistrati ordinari, giudicanti (i giudici) o requirenti (i pubblici ministeri).
L’assonanza con la volontà dichiarata dal presidente americano Donald Trump di «fermare la dittatura giudiziaria» delegittimando una magistratura formata in larga misura, a suo dire, da radical left judges e Trump-hating prosecutors dediti ad affermare non la giustizia ma la «persecuzione politica», ci mette di fronte uno specchio che mostra e amplifica l’esito verso cui corre chi rivendica la supremazia dell’esecutivo sulla giustizia. Basti leggere i principi declinati nel documento Project 2025, noto anche come Mandate for Leadership, promosso da uno dei più influenti think tank conservatori degli Stati Uniti, le cui proposte sono intese a minare uno dei pilastri dello Stato di diritto americano, il principio di separazione dei poteri e l’indipendenza della magistratura. Quello stesso specchio ha mostrato un riflesso sinistro nel post di Elon Musk: «These judges need to go», riferito non agli Stati Uniti, ma alla decisione del tribunale di Roma di sospendere la convalida di trattenimento per sette migranti trasferiti in Albania, nel centro di permanenza per il rimpatrio voluto dal governo Meloni. Come negli Stati Uniti – dove la grossolanità dell’attacco che Trump muove ai giudici ha la funzione di spostare il conflitto dal piano legale a quello mediatico-politico e di rafforzare la fedeltà di un elettorato inacerbito nel risentimento verso élite e istituzioni percepite come ostili o lontane – la difesa della democrazia in Italia dovrà saper riconoscere le declinazioni retoriche del King, del Sent by God che, esentato dalle regole ordinarie, agisce in nome del popolo.
Sarà importante far conoscere diffusamente i meccanismi della riforma: l’inganno contenuto nella separazione delle carriere, quando non accompagnata da forti garanzie di indipendenza; la voluta umiliazione insita nel trasferire il potere disciplinare del Csm a un’Alta Corte presieduta da un “laico” non togato nominato dalla politica; la revisione del principio di obbligatorietà dell’azione penale, principio cardine della Costituzione. Ma ancora più importante sarà far capire che, se attuata, la riforma della giustizia danneggerebbe i cittadini più ancora dei magistrati, che si troverebbero ad affrontare un’ulteriore perdita di garanzie, già oggi fragili e bisognose di difesa; perché non c’è dubbio che ciascuno di noi è in condizione di debolezza, quando è messo nelle condizioni di doversi difendere da eventuali soprusi dello Stato. Il cittadino, nudo di fronte al potere, può solo rivolgersi al magistrato; ma una magistratura asservita non toccherà il potere, né si opporrà nel momento in cui verranno limitate le libertà dei cittadini. Basti pensare alla possibilità di essere arrestati in base a uno dei numerosi reati e fattispecie di reato introdotti nel codice penale dal decreto sicurezza convertito in legge: dalla protesta passiva ai picchetti sindacali, dall’occupazione di suolo pubblico «con il proprio corpo» a misure preventive restrittive della libertà personale, come il Daspo urbano; o a chi si opporrà alle materie e ai corsi di studio resi obbligatori, quando nelle scuole e nelle università – nei cui consigli di amministrazione prenderanno posto con diritto di voto rappresentanti del governo – si vedrà limitata la libertà di pensiero, di espressione e di insegnamento; o, ancora, quando si verrà sgomberati da una casa di cui non si è più in grado di pagare l’affitto, o accusati di non essersi fermati a un alt della polizia o di aver opposto resistenza a pubblico ufficiale, magari solo per un fraintendimento. Le libertà dei cittadini, minacciate da sempre più pervasive e insidiose misure di polizia e di ordine pubblico, sono infinitamente meno garantite che nel processo penale.
Chi controlla la giustizia controlla la democrazia, e la destra di governo ha già mostrato di cercare il plebiscito per attuare un progetto autoritario che verrebbe reso possibile da una Corte costituzionale retta da giudici di parte, dalla riduzione della presidenza della Repubblica a mera funzione di rappresentanza, da un’autonomia differenziata che mina l’uguaglianza dei cittadini e dei diritti, dall’instaurazione di una “capocrazia” in regime di premierato, con una legge elettorale capace di rendere inscalfibile la maggioranza al potere.
Il dibattito che porterà al referendum sarà accidentato, segnato dalla volontà già mostrata dai sostenitori della riforma di brandire mediaticamente gli evidenti mal funzionamenti ed errori della giustizia, a cominciare dal caso Garlasco. Oscurando un passaggio rivelatore contenuto proprio nel programma elettorale con cui il partito di maggioranza è salito al potere. Al punto 22, spicca la promessa di eliminare i tribunali per minorenni e istituire «sezioni specializzate presso ogni tribunale, anche per evitare casi come quello del “sistema Bibbiano”». Un rimosso, scomparso di fatto anche dalla pagina web di FdI, dopo la sentenza di piena assoluzione che nel luglio 2025 ha restituito dignità ad assistenti sociali, psicoterapeuti e amministratori locali sottoposti a una gogna mediatica inconcepibile da parte chi aveva dipinto il Pd come un partito di abusatori di bambini sottratti alle famiglie e affidati a coppie amiche. «Non luogo a procedere», «i fatti non sussistono», «non hanno commesso i fatti» sono le frasi che tornano in una sentenza che sancisce la totale infondatezza dei quasi cento capi d’imputazione del processo “Angeli e demoni” che avrebbero costituito il «sistema Bibbiano», usato dai partiti che compongono l’attuale maggioranza come propaganda elettorale durante le regionali che si svolsero nel gennaio 2020 in Emilia Romagna. In questa proterva volontà di usare la giustizia a fini politici sta la chiave di comprensione del progetto dell’esecutivo che, mentre afferma di voler separare politica e giustizia, fa della giustizia uno strumento di potere politico.
Certo, non sempre abbiamo una giustizia giusta, sono emersi casi di corruzione, malfunzionamento, elefantiasi che vanno corretti e sanzionati, ma dobbiamo sempre avere a mente anche gli esempi in cui è stata solo la magistratura a opporsi all’arbitrio, alla discrezionalità, all’incostituzionalità che può assumere il potere dello Stato, quando non ne venga imbrigliata l’inevitabile tendenza all’espansione e alla protezione di se stesso. E se è vero che chi controlla la giustizia controlla la democrazia, allora nessuno deve controllare la giustizia: la sua autonomia è precondizione dell’uguaglianza di fronte alla legge, e dunque della democrazia, che è, per l’appunto, regime dell’autogoverno.






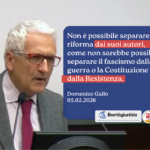





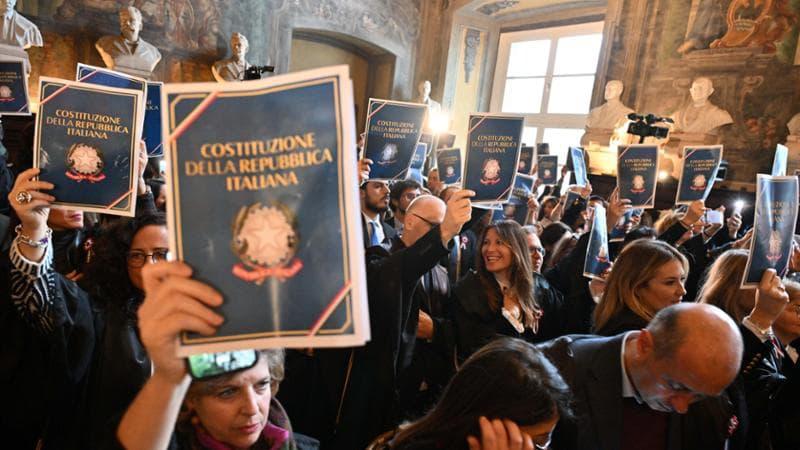

 Luigi Manconi
Luigi Manconi



