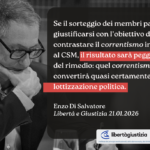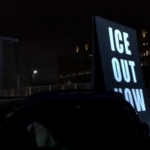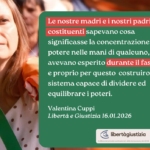Ai sensi dell’art. 1 della legge n. 91 del 1992 la cittadinanza italiana si acquisisce iure sanguinis, ovvero se si nasce da almeno un genitore italiano, oppure se si viene adottati da cittadini italiani (primo comma, lett. a).
Molto più limitato è, invece, l’acquisto iure soli, cioè per il fatto di essere nati sul territorio italiano; questa opzione è prevista per i figli di apolidi; se i genitori sono sconosciuti; oppure se, secondo la legge del Paese cui sono cittadini, i genitori non possono trasmettere la cittadinanza al figlio (primo comma, lett. b).
L’art. 9 della legge n. 91 del 1992 prevede anche che la cittadinanza italiana possa essere concessa – con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’interno – agli stranieri extracomunitari che risiedono in Italia da almeno dieci anni e dimostrano di avere una conoscenza della lingua almeno pari ad un livello B1 (misura introdotta dal decreto-legge n. 113 del 2018); di godere di un reddito consistente, in grado di sostenere sé e la famiglia; di conseguenza, di ottemperare agli obblighi tributari; infine, di avere la fedina penale pulita e di non essere in possesso di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica.
Ed è proprio sull’abrogazione di uno di questi requisiti che siamo fra l’altro chiamati a esprimerci i prossimi 8 e 9 giugno. È noto che nel nostro ordinamento il referendum ha natura abrogativa e, per questa via, non è naturalmente possibile introdurre lo ius soli, né lo ius scholae. Si è pertanto reso necessario individuare una norma la cui abrogazione possa produrre un effetto espansivo sulla platea delle persone naturalizzabili come cittadine italiane.
I promotori del referendum hanno inteso incidere «due diverse disposizioni, in modo da farne sopravvivere all’esito positivo del referendum, parzialmente abrogata, una soltanto (l’art. 9, comma 1, lettera b)»1. Si combinano dunque un’abrogazione totale, l’art. 9, comma 1, lett. f), recante la seguente disposizione «allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica», e una parziale, l’art. 9, comma 1, lett. b) limitatamente alle parole «adottato da cittadino italiano» e «successivamente alla adozione». La combinazione delle due abrogazioni lascerebbe in vigore la lett. b) modificata, che finirebbe col disporre «che tutti gli stranieri maggiorenni, con cittadinanza di uno Stato non appartenente all’UE […] potrebbero presentare richiesta di concessione della cittadinanza, una volta trascorsi cinque anni di residenza legale nel territorio della Repubblica»2
Il Giudice costituzionale ha superato il possibile vizio relativo alla manipolatività del quesito referendario precisando che la richiesta di abrogazione non intende sostituire la normativa vigente con un’altra, poiché il risultato sarà semplicemente quello di espandere la platea delle persone che possono chiedere la cittadinanza trascorsi cinque anni di soggiorno nel nostro Paese. Tutti gli altri requisiti restano invariati e perciò la concessione della cittadinanza continuerà a essere un «atto squisitamente discrezionale di “alta amministrazione”»3, soggetto alla valutazione del Ministro dell’interno.
Il buon esito della consultazione referendaria permetterebbe, inoltre, di allineare il nostro Paese al resto d’Europa dal momento che il requisito dei dieci anni di residenza è uno dei più restrittivi tra quelli previsti dagli ordinamenti degli altri Stati membri. La Germania, ad esempio, è stata uno degli ultimi Paesi a adottare una legge che prevede il termine di cinque anni per il riconoscimento della cittadinanza4.
Per quanto più direttamente rileva in questa sede, si stima che in Italia vivano circa 2,5 milioni di persone con cittadinanza straniera e la normativa di risulta sarebbe in grado di snellire le procedure di accesso alla cittadinanza.
Le difficoltà che incontrano gli stranieri riguardano, in particolare, la partecipazione a bandi e concorsi pubblici, l’accesso a servizi essenziali, ma anche maggiori oneri economici e procedurali; mentre l’introduzione di criteri più equi nel riconoscimento dei diritti di coloro che sono cittadini italiani permetterebbe di colmare queste disparità.
Ottenere la cittadinanza è complicato, soprattutto per la prima generazione di migranti, anche perché le condizioni abitative, spesso precarie, possono compromettere la validità del periodo di residenza legale richiesto; lo status di cittadino consente, invece, investimenti più stabili e sicuri. Allo stesso modo, la mancanza di un reddito continuativo – tipico di chi svolge lavori saltuari o sottopagati – rischia di precludere ogni possibilità di accesso alla cittadinanza alimentando un circolo vizioso. Dieci anni di residenza legale senza interruzioni sono infatti un periodo molto lungo per un Paese che non prevede permessi di soggiorno per la ricerca del lavoro, centellina le regolarizzazioni, prevede che si possa perdere il permesso di soggiorno perché si è perso il lavoro.
Affrontare il tema della cittadinanza significa dunque parlare anche di precarietà, sfruttamento e disuguaglianze perché l’attuale sistema lega il riconoscimento dello status di cittadino alla “produttività” e all’efficienza amministrativa, escludendo chi non riesce a soddisfare i requisiti economici o burocratici posti dalla legge.
Un ambito emblematico per comprendere le condizioni di vita degli immigrati irregolari è quello relativo al diritto alla salute, che naturalmente incide in maniera diretta sulla qualità della vita delle persone e sulla relativa possibilità di integrarsi nella società. Gli immigrati tenuti al rinnovo annuale del permesso di soggiorno devono affrontare, contestualmente, il rinnovo all’iscrizione al SSN e la riassegnazione del medico di base. Ciò ostacola, ad esempio, l’accesso continuativo a farmaci e a trattamenti a lungo termine, causando discontinuità nelle cure e, più in generale, ritardi o inefficienze nel godimento di un diritto che l’articolo 32 della Costituzione riconosce a tutti.
Anche in ambito lavorativo il godimento dello status di cittadino potrebbe consentire agli immigrati un ventaglio più ampio di opportunità, a partire dalla possibilità di partecipare ai concorsi pubblici, eliminando le limitazioni legate al possesso della cittadinanza e consentendo perciò una pianificazione del futuro più stabile e sicura. Lo stesso vale per l’accesso alla casa, atteso che molti immigrati incontrano difficoltà nel concludere un contratto di locazione proprio a causa del loro status giuridico.
Lasciare di fatto nell’illegalità per lunghi periodi molte persone che risiedono stabilmente nel nostro Paese e che partecipano alla vita – anzitutto economica – della comunità, significa esporle agli effetti della ricattabilità, del lavoro nero, della precarietà; continuare a rendere stretta, lunga e impervia la strada dell’integrazione non è neppure un deterrente, si è visto, per placare i nuovi flussi in ingresso.
Ultimo, ma non per importanza, lo status di cittadino è fondamentale per la partecipazione civica, in quanto condizione necessaria per l’esercizio dei diritti politici e per l’accesso, quantomeno, agli uffici pubblici. Per quanto più direttamente rileva in questa sede, il vulnus più evidente riguarda proprio l’esclusione dal diritto di voto: i cittadini italiani i prossimi 8 e 9 giugno sono chiamati a esprimersi su norme che incidono chiaramente sul futuro degli immigrati i quali, pur vivendo stabilmente nel nostro Paese, non hanno alcuna possibilità di partecipare a una decisione che li riguarda direttamente. Al contrario, parteciperanno alla consultazione referendaria gli italiani residenti all’estero, tendenzialmente inclini a manifestare una certa “italianità”.
Questo rappresenta forse il paradosso più evidente della cittadinanza oggi, ovvero una posizione giuridica che è riconosciuta a chi non vive in Italia per il solo fatto di avere origini italiane (e che il decreto-legge n. 36 del 2025, parte del c.d. pacchetto cittadinanza, si è proposto di circoscrivere al legame di secondo grado, ovvero a chi è figlio o nipote per parte di nonno/a di una persona con cittadinanza italiana), ma negata a chi contribuisce quotidianamente alla crescita politica, economica e sociale del Paese. Un ostacolo che la Repubblica avrebbe il dovere di rimuovere poiché rischia di mettere in discussione la coerenza stessa di alcuni dei principi fondamentali del nostro ordinamento, come l’eguaglianza, l’inviolabilità dei diritti fondamentali e la stessa democrazia rappresentativa.
La riduzione a cinque anni del periodo di soggiorno trascorso il quale è possibile chiedere la cittadinanza avrebbe dunque un impatto significativo sulla vita quotidiana di milioni di persone, poiché permetterebbe di garantire diritti fondamentali a chi è già parte integrante della nostra società, riconoscendone formalmente l’appartenenza e il contributo che apportano alla crescita del Paese.
[Questo articolo è stato pubblicato sul sito valerioovnida.org e lo riproponiamo con il permesso dell’autrice]