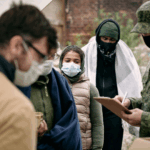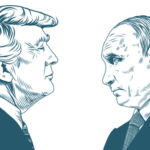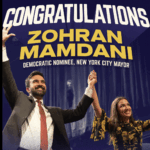Ero a Matera nell’ ottobre del 2014, pochi giorni prima che fosse proclamata capitale europea della cultura. Non era scontato che la città della Basilicata l’ avrebbe spuntata sulle concorrenti, ma tra le sue strade scorreva un’ energia che lasciava spazio a pochi dubbi. Non c’ era piazza, bar, luogo di ritrovo in cui la gente non parlasse di ciò che stava succedendo. I materani erano orgogliosi per come avevano costruito la candidatura, ma soprattutto – tra i luoghi di quella che quasi settant’ anni prima era stata definita « vergogna nazionale » e che ora ne era invece una speranza – ogni singola frase di ogni loro discorso viaggiava sul tempo verbale più difficile da praticare: il futuro.
C’erano stati almeno due episodi, nelle settimane precedenti alla mia visita, che rendevano il senso di quella atmosfera. Il primo. I commissari europei venuti di persona a valutare la candidatura non avevano sostato in sofisticate strutture alberghiere capaci di dimostrare che Matera era un posto come un altro. Erano stati invece adottati dalle famiglie della città. C’era stato un bando, e i materani avevano fatto a gara ad aprire le porte delle proprie case.
I commissari avevano così prima subìto lo shock culturale di ritrovarsi a tavola tra sconosciuti che li trattavano con il calore e l’ affabilità (ma anche la praticità) che si riserva ai fratelli o agli amici di lungo corso, e poi, per bocca di quegli stessi ospiti, avevano sentito parlare di Matera capitale europea della cultura con una competenza e una passione sconosciuti ai burocrati. Il Comitato cui era stato affidato il compito di elaborare la candidatura l’aveva insomma meritoriamente condivisa con tutta la cittadinanza. Il secondo episodio era stato una marcia simbolica che, dai Comuni vicini, aveva portato migliaia di persone tra le strade di Matera. Nel paese dei campanili (e delle eterne lotte condominiali), una magnifica manifestazione di sostegno. La statura culturale nonché lo stadio evolutivo di un popolo si misura anche dalla solidarietà, dall’ accoglienza, dalla socialità di cui è capace, e su questo il sud Italia ha da insegnare a tutti.
Tra pochi giorni, il 19 gennaio, inizia ufficialmente l’anno magico di Matera. È interessante capire cos’ è successo nel frattempo, ma soprattutto cosa potrà succedere in futuro.
Negli ultimi anni, soprattutto grazie a questa investitura, Matera e la Basilicata sono definitivamente uscite dal cono d’ ombra. L’ anno scorso il New York Times inseriva la Basilicata tra i più bei posti al mondo dove andare. A guardare gli alberghi, e il tipo di clientela che li affolla lasciando senza speranza turisti dell’ ultimo minuto, direi che da questo punto di vista la scommessa è vinta. Il turismo però da solo non basta. Un’ investitura così importante è anche l’occasione per dotare il territorio di infrastrutture all’ altezza, il che significa lavoro, sviluppo, possibilmente innovazione. Qui qualche lite condominiale e qualche conflitto istituzionale di troppo hanno creato rallentamenti, speriamo che il tempo perso si recuperi. C’è poi il programma di eventi culturali, che ha dimostrato e dimostrerà per tutto il 2019 di essere eccellente: a Matera in questi anni sono arrivati, e ancor più arriveranno tra i migliori artisti, musicisti, scrittori, pensatori, filosofi disponibili sulla piazza.
Ma tutto questo, ancora una volta, deve essere solo il punto di partenza. È vero che anni luce separano la Matera di Levi e Pasolini da quella attuale, è vero che i materani e il Comitato Matera 2019 (oggi Fondazione Matera-Basilicata 2019) si sono impegnati in un lavoro che nessun altro avrebbe svolto meglio, ma la cosa che meno auguro a questa terra per il futuro (qui, dal 2020, il compito spetterà alle istituzioni e alla cittadinanza) è la sua trasformazione in una sorta di Lucaniashire dove ricchi pensionati americani e tedeschi vengono a comprare casa, e un albergo con vista sui sassi viene eletto a rifugio da un qualche George Clooney venuto a riposarsi da fatiche fatte altrove.
Tutto questo potrà magari anche accadere, ma a corollario. A corollario di che? Non dimentichiamoci che Matera non è stata proclamata capitale europea del turismo o della gastronomia. È la capitale della cultura, e ha la fortuna e l’ onere di esserlo nell’ anno in cui l’ Europa si gioca tutto. Il nostro continente attraversa una crisi assai profonda, che sembra giunta al culmine.
Ciò di cui ha bisogno non è solo un luogo incantevole (dai Castelli della Loira ai mulini a vento dell’Andalusia, l’Europa ne è piena) ma un laboratorio di idee, un luogo di formazione, un centro di elaborazione culturale che lo aiuti a tirarsi fuori dal gran casino in cui è stato capace un’ altra volta di ficcarsi.
L’Europa trabocca di istituti di credito, ristoranti biologici e vecchi monumenti trasformati in resort. È invece povera di centri di formazione per la cittadinanza, di scuole innovative, di istituti culturali d’ eccellenza che siano liberi, multidisciplinari (dalla crisi attuale si esce solo con un approccio capace di intrecciare un vero dialogo tra scienziati, umanisti, artisti, economisti, politologi), e abbastanza ricchi di risorse da diventare influenti. Penso a cosa succede in posti come il Santa Fe Institute nel New Mexico o il Future of Humanity Institute di Oxford. Penso a cosa successe tanto tempo fa in una cittadina come Ivrea. Se Matera, naturalmente a modo proprio, sarà in grado di preparare e raccogliere una sfida di questa portata diventerà uno dei centri di gravità del continente, non solo per il 2019.
(*) Nicola Lagioia è scrittore e direttore del Salone Internazionale del Libro di Torino. Ha vinto il Premio Strega con “La ferocia”.
La Repubblica, 16 gennaio 2019