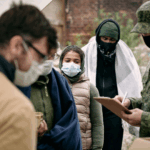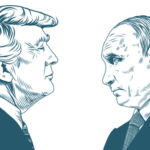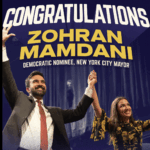Tutto nasce dal bicameralismo perfetto, divenuto sinonimo dell’assurdo, del perverso, dell’inaccettabile, del mostruoso. E’ lui a rendere paludose la nostre istituzioni. Lui a rallentare, se non addirittura a insabbiare, ogni tentativo di cambiamento. Lui a indebolire fino all’impotenza la governabilità. Lui la trincea di ogni abietto conservatorismo, il monumento allo spreco, il simbolo della lussuria politica.
Tutto nasce dal bicameralismo perfetto, divenuto sinonimo dell’assurdo, del perverso, dell’inaccettabile, del mostruoso. E’ lui a rendere paludose la nostre istituzioni. Lui a rallentare, se non addirittura a insabbiare, ogni tentativo di cambiamento. Lui a indebolire fino all’impotenza la governabilità. Lui la trincea di ogni abietto conservatorismo, il monumento allo spreco, il simbolo della lussuria politica.
Non esiste in nessun’altra parte al mondo, denunciano gli intrepidi riformatori, ed è tale la loro sicumera che chi tenta di eccepire sulla sciagurata riforma del Senato non manca mai di premettere, per evitare la pubblica gogna, di voler comunque superare il bicameralismo perfetto. Naturalmente sono tutti convinti che questa unanime condanna origini da valutazioni approfondite e inconfutabili.
Vediamole.
Nella passata legislatura (2008-2013) il parlamento italiano ha licenziato 391 leggi. Di queste, 301 sono state licenziate con la doppia lettura. Vale a dire che la camera che ha ricevuto la legge dopo la prima lettura non ha ritenuto di dover modificare alcunché. 75 leggi hanno invece ricevuto una modifica e sono state, quindi, deliberate in terza lettura. Delle rimanenti 15 leggi, al netto delle 4 di natura costituzionale che esigevano un doppio passaggio, 8 leggi sono state deliberate in quarta lettura e solo 3 sono andate oltre alla quarta. Se andassimo ad analizzare questi sporadici casi troveremmo nella complessità giuridica del loro impianto e nella difficile valutazione delle ricadute una valida giustificazione per il lungo palleggio. In sintesi possiamo affermare che nel 77,8% dei casi il bicameralismo ha funzionato come un semplice controllo di qualità, nel 19,4% ha, invece, introdotto utili correzioni o integrazioni nel corpo legislativo e nel rimanente 2,8% è stato un opportuno strumento di approfondimento e riflessione.
Si potrebbe obiettare che questo è andato a discapito della velocità e della produttività. Ammesso e non concesso che le leggi abbiano quel potere taumaturgico che molti attribuiscono loro (per cui a ogni problema dovrebbe corrispondere una legge salvifica da deliberare a tambur battente) e che la qualità della democrazia possa misurarsi con criteri quantitativi o cronometrici, la statistica ci dice che il Parlamento italiano ha deliberato 71 leggi nel 2011 e 102 nel 2012, quello francese rispettivamente 111 e 82, quello spagnolo 50 e 25, quello inglese 25 e 23, quello tedesco 153 e 128.
La produttività del bicameralismo perfetto rimane quindi al di sopra della media dei principali parlamenti europei. Per quanto concerne la velocità bisogna rimarcare che i regolamenti parlamentari permettono grande flessibilità nei tempi. Esempio significativo è la cronistoria del cosiddetto lodo Alfano inteso a bloccare i processi di Berlusconi. La legge che aveva iniziato il suo iter parlamentare l’8 luglio 2008, il 23 luglio era già stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale. 15 giorni in tutto.
Il bicameralismo perfetto non è quindi una palude. Lo conferma la logica. Siano A e B due leggi diverse per oggetto, ma entrambe afferenti alla competenza della commissione X. Nel monocameralismo esse si sovrapporranno obbligando una delle due a un periodo di attesa. Nel bicameralismo esse potranno essere approfondite contemporaneamente nelle commissioni X delle due camere. Poiché con buona probabilità la seconda lettura sarà un semplice vaglio di qualità, avremo leggi migliori in un tempo minore. Stupiti vero? Tutto vi sareste aspettato fuorché di immaginare il bicameralismo come strumento di velocizzazione dell’iter legislativo. In realtà il tallone di Achille del bicameralismo è nella duplicazione della liturgia necessaria all’insediamento del governo con il doppio voto di fiducia, ciò che lo rende, per l’appunto, “perfetto”. Proprio per questo alcuni “professoroni” hanno proposto di togliere al Senato questa prerogativa.
Slegato dalle congiunture politiche, avrebbe potuto alzare il livello qualitativo del dibattito politico e guardare agli effetti dell’azione politica su tempi più lunghi. Ma chi ha avuto la pazienza di seguire questo mio noiosissimo approfondimento avrà anche capito come esso sia irrimediabilmente perdente rispetto al fascino di chi promette la gratuità del Senato. Al sonno della ragione dobbiamo rassegnarci e, se proprio soffriamo d’insonnia, proviamo con il Tavor.
Difendiamo la Costituzione, i diritti e la democrazia, puoi unirti a noi, basta un piccolo contributo