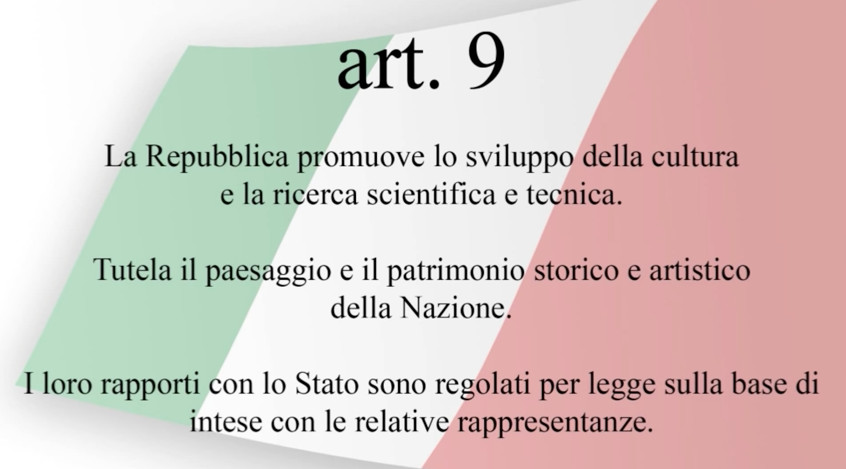Se proviamo a tracciare una storia dell’attuazione dell’articolo 9 della Costituzione dobbiamo riconoscere che il primo momento – quello della difficilissima sfida della ricostruzione postbellica del patrimonio culturale – rappresenta il punto più alto di una curva poi sempre in discesa. Una curva che non tornò a riprendersi nemmeno con l’infelice nascita del Ministero per i Beni Culturali (1975), che poi iniziò a precipitare con le privatizzazioni neoliberiste dei primi anni novanta, e che si è quindi definitivamente inabissata con le ‘riforme’ del ministro Dario Franceschini (2014-16).
In questa lunga storia di non-attuazione si possono distinguere due diverse fasi.
La prima (che arriva fino alla metà degli anni ottanta) è una storia di omissioni: una storia in cui la Repubblica non ha promosso abbastanza lo sviluppo della cultura e la ricerca, e non ha tutelato a sufficienza il patrimonio storico e artistico, a causa della superficialità di una classe dirigente incapace di comprendere il significato strategico (sul piano culturale e civile, ma anche su quello economico) di tutto questo, e dunque incapace di stanziare le risorse necessarie.
Nella seconda fase (quella che dagli anni ottanta arriva fino a noi) è lo Stato stesso ad entrare in crisi: anzi, ad essere progressivamente smantellato, prima teoricamente e poi di fatto. Paradossalmente, il ritardo culturale della classe politica italiana ha preservato a lungo il patrimonio culturale dalle conseguenze dello smontaggio neoliberista dello Stato: ma questa involontaria quanto provvidenziale franchigia è progressivamente venuta meno con l’inizio del nuovo secolo. Di fatto, l’ultimo quindicennio ha visto un precipitoso allineamento dei beni culturali a ciò che era già successo in altri settori chiave del ‘pubblico’ (si pensi alla sanità, o all’università): fino ad una fase estrema e recentissima in cui, di fatto, si è messo in discussione il significato stesso di parole come «cultura» o «tutela».
In quest’ultima, drammatica fase è forse possibile distinguere due segmenti diversi.
Il primo, caratterizzato dai governi di Silvio Berlusconi, ha eroso il secondo comma dell’articolo 9 minacciando soprattutto l’integrità della porzione pubblica del patrimonio storico e artistico della nazione, dando così una spallata pressoché letale all’esercizio della tutela, attraverso il taglio della metà (un miliardo di euro) del bilancio del Ministero per i Beni culturali ‘guidato’ da Sandro Bondi (era l’estate del 2008), di fatto mettendolo «in liquidazione» (Settis). Il secondo, caratterizzato dai governi di centro-sinistra e da ministri per i Beni culturali come Walter Veltroni e Dario Franceschini, ha realizzato la dismissione del patrimonio pubblico avviata dal centrodestra, e se ha recuperato qualche punto nei finanziamenti della tutela, ha però messo sotto attacco il primo comma dell’articolo 9, interpretando lo «sviluppo della cultura» come pura valorizzazione economica, minando le ragioni stesse della tutela e l’indipendenza di questa ultima dalla politica. Tra i due segmenti non c’è alcuna soluzione di continuità, ma anzi un crescendo di impegno per sradicare di fatto l’articolo 9 dall’impianto dei principi fondamentali del nostro progetto di Paese.
Prendiamo il nucleo concettuale delle politiche berlusconiane sul patrimonio: la sua alienazione. Dopo una serie di tappe di avvicinamento, peraltro tutte dovute a governi di centro-sinistra, l’apice della privatizzazione del patrimonio si toccò, grazie a Giulio Tremonti, con «la costituzione, nel 2002, della Patrimonio dello Stato spa, una società per azioni che, almeno teoricamente, avrebbe potuto gestire e alienare qualunque bene della proprietà pubblica» (Mattei, Reviglio, Rodotà). Ovviamente questa specie di escalation della privatizzazione colpì e travolse anche la parte più importante del patrimonio dello Stato, il «paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione»: e di fronte all’enormità dell’attacco, si risvegliò un’opinione pubblica non ancora del tutto franta. Il libro Italia spa di Salvatore Settis – che uscì proprio nel 2002, conquistando subito un ruolo guida – aprì gli occhi agli scettici e agli increduli, dimostrando con numeri e fatti che «il patrimonio culturale italiano non è mai stato tanto minacciato quanto oggi, nemmeno durante guerre e invasioni: perché oggi la minaccia viene dall’interno dello Stato, le cannonate dalle pagine della Gazzetta Ufficiale».
Anche grazie a quella resistenza, il progetto megalomane della Patrimonio dello Stato spa si arenò: ma solo per realizzarsi, di fatto, passo a passo. Oggi una fitta legislazione creata in gran parte dai governi di Centrosinistra consegna ai manuali di storia del diritto le differenze tra beni disponibili, beni indisponibili e demanio inalienabile dello Stato, e cancella l’idea stessa di un demanio inteso come una riserva inattingibile rivolta al futuro e finalizzata all’attuazione dei diritti fondamentali dei cittadini: tutto è, nei fatti, alienabile, tutto è anzi potenzialmente già in vendita, e le differenze di stato giuridico tra i beni comportano solo trafile burocratiche differenti. Così l’incubo della Patrimonio dello Stato spa si è di fatto avverato, anche se nella forma di uno stillicidio. […]
Negli ultimi anni l’insofferenza della politica italiana verso il sapere scientifico e tecnico appare crescente: tanto che nel discorso pubblico degli ultimi anni la contrapposizione tra le competenze della Repubblica e quelle gli enti locali è stata rappresentata come una contrapposizione tra una burocrazia non legittimata democraticamente (le soprintendenze) e le amministrazioni che hanno ottenuto il consenso popolare (innanzitutto i sindaci eletti direttamente). Questa insofferenza verso le magistrature repubblicane chiamate a difendere la publica utilitas contro l’arbitrio degli interessi privati è cresciuta a destra, ma è stata infine ‘sdoganata’ dal Matteo Renzi sindaco di Firenze, che arrivò a scrivere che
«Sovrintendente è una delle parole più brutte di tutto il vocabolario della burocrazia».
La convergenza politica sul progetto di eliminare l’articolazione concreta della ‘tutela’ imposta dal secondo comma dell’articolo 9 è stata plasticamente chiarita agli italiani durante una nota trasmissione televisiva televisiva («Porta a Porta» del 16 novembre 2016): qua, dialogando amabilmente con il segretario della Lega Matteo Salvini, l’allora ministra per le Riforme istituzionali Maria Elena Boschi candidamente ammetteva: «io sono d’accordo diminuiamo le soprintendenze, lo sta facendo il ministro Franceschini. Aboliamole, d’accordo». […]
Il «terribile diritto» della proprietà privata ha infine piegato l’interesse pubblico: l’eclissi dell’articolo 9 è oggi al suo culmine, e la formula del ‘silenzio assenso’ non è soltanto un escamotage giuridico procedurale, ma una traduzione simbolicamente efficace di ciò che il potere politico si aspetta oggi dai tecnici della tutela: un tacito consenso.
il Fatto Quotidiano, 11 febbraio 2017