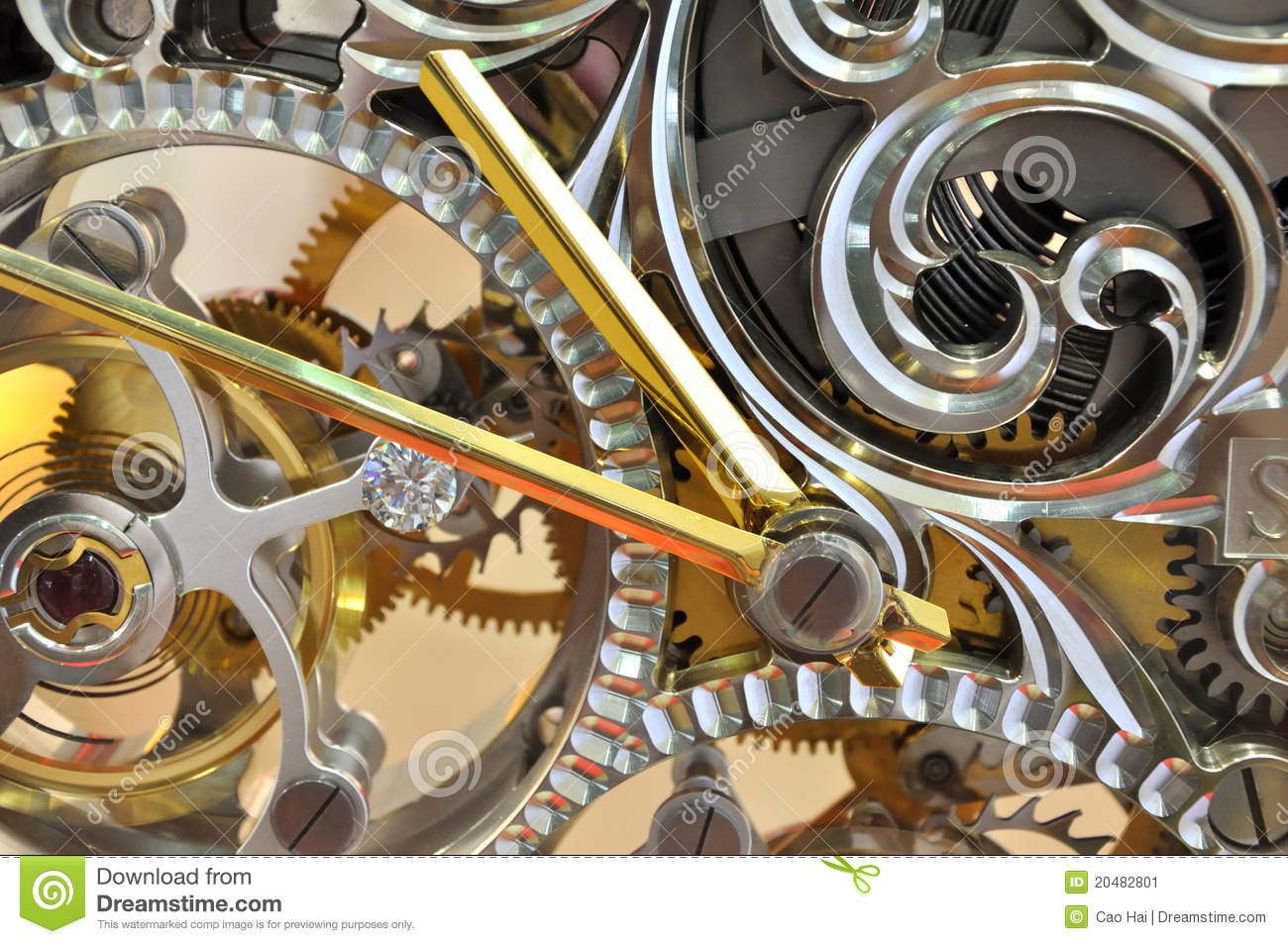La Carta Costituzionale contiene i principi fondamentali della convivenza sociale di una collettività di cittadini che appartengono al medesimo Stato. Perché una Costituzione possa definirsi democratica è necessario che i suoi contenuti siano condivisi da tutti, o quanto meno, dalla grandissima maggioranza dei cittadini. Una costituzione espressione non di tutti, ma di una parte dei cittadini, non può essere definita democratica. La nostra Costituzione entrata in vigore il 1 gennaio del 1948 (70 anni fa era in vigore lo Statuto Albertino!) è stata elaborata da una assemblea eletta proporzionalisticamente e perciò massimamente rappresentativa del popolo italiano e di tutte le sue espressioni politiche e culturali. E’ stata approvata con il consenso di oltre l’82% dei parlamentari e con nessun voto contrario.
Possiamo, perciò, ben dire che la Costituzione del ’48 possiede una piena e indiscutibile legittimazione democratica.
Questa premessa può apparire superflua, ma non lo è se pensiamo come si sta affrontando in queste settimane il tema della riforma costituzionale. E’, infatti, evidente che la modifica della Costituzione non può essere e non deve essere tema di competenza governativa. Certamente, cosi non è stato nei decenni passati. Basterà ricordare l’infelice riforma del titolo V voluta dal Governo Amato e i pasticci sulla devoluzione per accontentare la Lega di Bossi. Tutte modifiche costituzionali volute dai governi, approvate con maggioranze ridotte e che hanno provocato soltanto disastri gestionali e guasti all’assetto costituzionale.
Oggi, in nome di uno sbandierato decisionismo, che si presenta come l’ultima spiaggia delle ideologie salvifiche ormai al tramonto, il Parlamento (questo Parlamento eletto con criteri scarsamente rappresentativi) è chiamato con urgenza a modifiche costituzionali che vengono dipinte come indifferibili e necessarie per garantire l’efficienza e la funzionalità dei poteri statali.
E’ di tutta e chiara evidenza che cosi non è. Lo hanno dimostrato con precisione costituzionalisti, che non possono certo essere considerati conservatori, come Michele Ainis e Stefano Passigli. Anche con il bicameralismo perfetto i disegni di legge governativi sono sempre stati approvati in tempi più che sostenibili. La Costituzione consente al Governo la possibilità di ricorrere ai decreti legge, immediatamente esecutivi, e ai decreti legislativi, che lasciano al Governo ampi margini di intervento. Per non tralasciare il ricorso ai voti di fiducia che hanno consentito una eccezionale rapidità di approvazione dei provvedimenti dell’esecutivo. Non si può, perciò, non condividere l’affermazione di Passigli che “il mantra della debolezza dell’Esecutivo è stato un alibi per una classe politica spesso incapace di governare”.
E allora, se cosi è, per quale motivo tanta urgenza e tanta fretta nel voler ridurre il Senato ad una sorta di Cnel, espressione delle regioni, peraltro eletto dai consigli regionali, che costituiscono la classe politica a più alto rischio di criminalità, come è emerso dalle cronache politiche giudiziarie di questi ultimi decenni?
La risposta non ha nulla a che fare con la necessità di ammodernare la Costituzione del ’48 e di proseguire nel trionfante (almeno dal punto di vista mediatico-propagandistico) cammino riformistico del Governo. La sua motivazione è tutta interna al partito di maggioranza. Il braccio di ferro cui stiamo assistendo è soltanto l’occasione che il segretario premier intende sfruttare per ridurre all’obbedienza, in un modo o nell’altro, la sua minoranza interna.
Ma si può modificare una carta costituzionale per risolvere le beghe interne di un partito?
La questione su cui tutti dovrebbero riflettere con la massima attenzione è un’altra. Il cuore del problema non è quello su cui si discute in queste ore, non è se un Senato ridotto di poteri e competenze debba essere eletto o nominato. Tutti devono chiedersi se questa ipotizzata riforma, nel suo complesso, incide e in che misura sull’equilibrio dei poteri, che è la base fondamentale di una corretta democrazia. A questa domanda la risposta non può essere che di grande preoccupazione. Il combinato disposto delle modifiche alle attribuzioni del Senato e della legge elettorale determinerà una concentrazione inquietante ed eccezionale di poteri nelle mani del capo di un partito e provocherà una pericolosissima compressione della sovranità popolare. E’, perciò, necessario che tutti riflettano con la massima attenzione su quello che sta accadendo in queste ore e sulla deriva ineludibilmente autoritaria che si sta profilando.