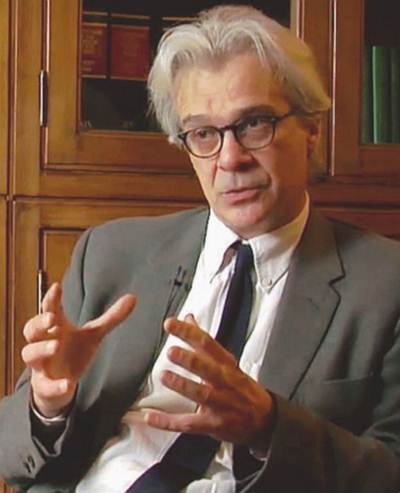Lorenza Carlassare – professore emerito a Padova, una dei nostri costituzionalisti più autorevoli – risponde al telefono con l’abituale fermezza: “Non è difficile valutare alla luce della Carta i fatti di questi giorni. Si discute se il comportamento del capo dello Stato sia stato corretto. La risposta per un costituzionalista è facile, perché noi valutiamo le situazioni solo ed esclusivamente in rapporto al dettato costituzionale e a ciò che rientra nella tradizione del sistema parlamentare. La nostra non è una Repubblica presidenziale: da qui discendono molte conseguenze. Il presidente quando forma il governo non fa il suo governo, ma quello della maggioranza”.
E come si deve regolare?
Semplicemente tenendo conto di qual è l’orientamento della maggioranza parlamentare e di quale governo potrà ottenere la fiducia delle Camere. Quel governo dovrà avere la fiducia e conservarla, altrimenti dovrà dare le dimissioni. L’unica stella polare che deve guidare il cammino del presidente è questa valutazione sulla possibilità o meno che quell’ esecutivo abbia la fiducia del Parlamento.
Dove risiede il potere decisionale del presidente?
Dopo le consultazioni, deve valutare qual è la persona maggiormente idonea a ricoprire la carica di presidente del Consiglio. È una valutazione che però non si basa su opinioni o convincimenti personali del capo dello Stato, ma sulla base delle consultazioni che altrimenti sarebbero inutili. Dopo aver individuato la persona e conferito l’incarico, la responsabilità passa al presidente incaricato che deve comporre la lista dei ministri del suo gabinetto. La proposta di cui parla l’articolo 92 della Carta vincola il capo dello Stato, che può esprimere valutazioni di cui il presidente incaricato può tenere conto se lo ritiene. Il diniego sul nome di un ministro può esserci per incompatibilità col ruolo, per conflitto d’ interessi o indegnità causata, per esempio, da condanne penali, dunque solo per ragioni oggettive.
Il presidente può fare valutazioni politiche?
No. Perché non è organo di indirizzo politico. La dottrina – da Serio Galeotti a Livio Paladin, per citare due autorevolissimi costituzionalisti – è sempre stata concorde nel ritenere il presidente un organo di garanzia e non di indirizzo politico.
Si dice che il presidente si sia fatto garante della Carta, che all’ art. 47 assicura la tutela del risparmio.
Mi fa felice riscontrare questo interesse per il risparmio degli italiani che per decenni non si è mai manifestato né da parte del presidente Mattarella, né dei suoi predecessori. Tanto è vero che tanti risparmiatori sono stati messi in ginocchio. E non mi riferisco solo a quelli truffati dalle banche: il risparmio è stato distrutto dai meccanismi attuali. È bene che il presidente se ne faccia carico, ma voglio far notare che nel programma di governo non erano previsti provvedimenti distruttivi del risparmio. La valutazione sulla linea economica è stata squisitamente politica. E questa sfugge alle prerogative presidenziali.
Ci sono punti del programma di governo che suscitano perplessità?
Credo quelli sulla sicurezza, citati anche in un’ intervista a Gustavo Zagrebelsky qualche giorno fa su Repubblica, come l’autodifesa sempre legittima, o l’uso della pistola a onde elettriche considerata dall’Onu uno strumento di tortura, l’introduzione di reati specifici per i migranti clandestini o il trasferimento dei fondi destinati ai profughi ai rimpatri coattivi. Sono cose in evidente contrasto con la Carta: il presidente avrebbe potuto farlo notare e comunque respingere i singoli provvedimenti.
Cosa pensa della ventilata messa in stato d’accusa?
Mattarella ha certamente esorbitato dalle sue funzioni.
Ma la messa in stato d’ accusa è qualcosa di più complesso: bisogna dimostrare, anche con comportamenti reiterati, l’intenzione di sovvertire la Costituzione. Non è questo il caso. In ogni caso, nell’ interesse del Paese è un discorso che va abbandonato perché paralizza il funzionamento delle istituzioni.
Si cita spesso il precedente di Napolitano, che ha interpretato in maniera vigorosa il suo ruolo: per Renzi anche imponendo il percorso di riforme costituzionali.
Le rispondo così: quando il presidente Cossiga esorbitava dalle sue funzioni, i costituzionalisti manifestavano le loro critiche continuamente proprio per evitare che si potesse parlare di una prassi consolidata.
La presidenza della Repubblica ne esce ammaccata?
Mi auguro con tutto il cuore di no.
Il Fatto Quotidiano, 30 maggio 2018