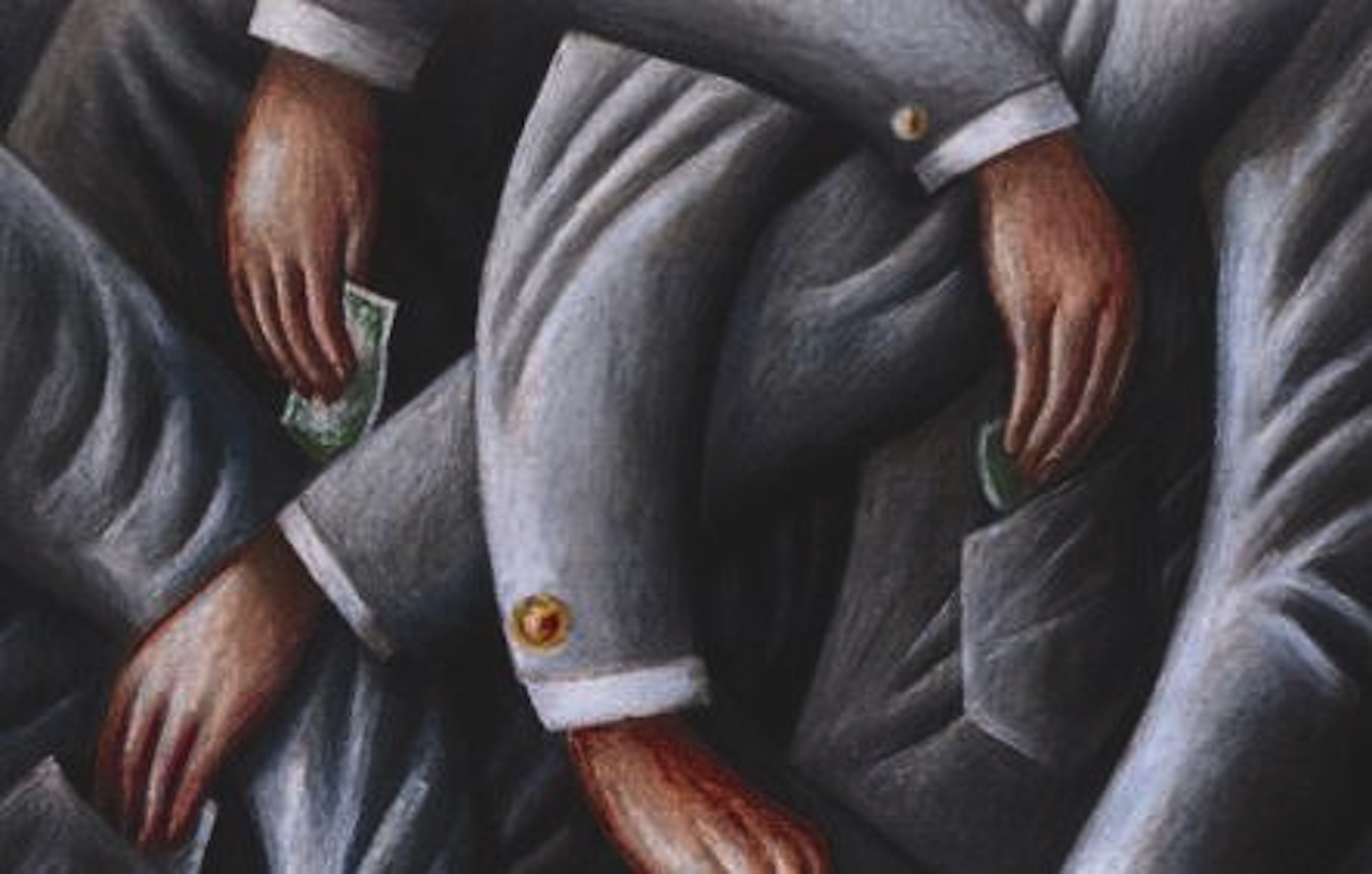Il celebre discorso parlamentare del 3 luglio 1992 alla Camera dei Deputati, in cui -in piena Tangentopoli- l’allora segretario del PSI Bettino Craxi chiamava in correità un intero sistema partitico, può essere considerato un crocevia di grande significato simbolico della nostra storia recente. Infatti, se all’epoca quel discorso poteva essere visto come la fine di una stagione, prodromico a una svolta verso un nuovo modo di “fare politica”, riletto oggi, in tempi di scandali non meno diffusi e, anzi, quasi più frequenti (nel Paese in generale, come a Pavia in particolare), quell’intervento può essere visto come il segnale di una Italia che, anziché prendere le distanze da quel passato e metabolizzare i propri errori, ha furbescamente ritenuto più conveniente assimilarlo, decidendo più o meno consapevolmente di rendere strutturali e pervasivi quegli errori, raffinando per di più le modalità operative attraverso le quali realizzare pratiche corruttive.
Perché le cose siano andate così, perché cioè non si sia verificata la palingenesi auspicata da tanti, bensì una recrudrescenza inaspettata della corruzione (sebbene Craxi, in quel discorso, è bene ricordarlo, si riferisse “solamente” ai finanziamenti illeciti ai partiti), è difficile da dire. Come non è facile stabilire se la sessantunesima posizione occupata dall’Italia nella classifica del Corruption Perceptions Index 2015 di Transparency, parecchio lontana dalle altre democrazie occidentali, sia frutto di regole inadeguate o di cattivi costumi individuali. È una affascinante domanda alla quale la sociologia politica e giuridica non sembra ancora in grado di dare una risposta univoca (anche se gli importanti studi di Alberto Vannucci qualcosa dicono).
Certamente, però, sembra cogliere un punto Massimo Donini, in un libro di due anni fa, “Il diritto penale come etica pubblica”, quando osserva che da qualche tempo in Italia la giustizia penale ha svolto il ruolo di surroga dell’etica pubblica. Questo è vero, a me pare, in un duplice senso: nel senso che è letteralmente scomparsa, se mai è esistita, la categoria di ciò che è appropriato fare quando si ricopre un ruolo pubblico e tutto si è ridotto alla dicotomia legale/illegale. E nel senso, non disgiunto dal primo, che si cerca allora di individuare nuove fattispecie penali (per esempio, il traffico di influenze illecite) con le quali allo stesso tempo reprimere e disincentivare comportamenti dannosi per l’interesse generale, che però i reati di concussione e corruzione non riescono a catturare.
In realtà, una visione che non si adoperi per ripristinare a livello politico e culturale uno spazio per l’etica pubblica, delegando i compiti di quest’ultima all’azione penale, rischia di essere miope. Se, infatti, non si riesce a motivare nel profondo gli individui ad agire onestamente e responsabilmente -nel senso dell’accountability (trasparenza, rendere conto del proprio operato ndr) di cui parlava Emanuela Ceva sul giornale di domenica- non si riesce nemmeno, temo, a creare quella “massa critica” capace di isolare i “mariuoli” ed evitare, come ricordava Michele Bocchiola mercoledì scorso, che la corruzione, divenendo sistemica, mini lo Stato alle fondamenta.
Provincia pavese, 27 febbraio 2016
(*) Professore di Filosofia del diritto, Università Statale di Milano